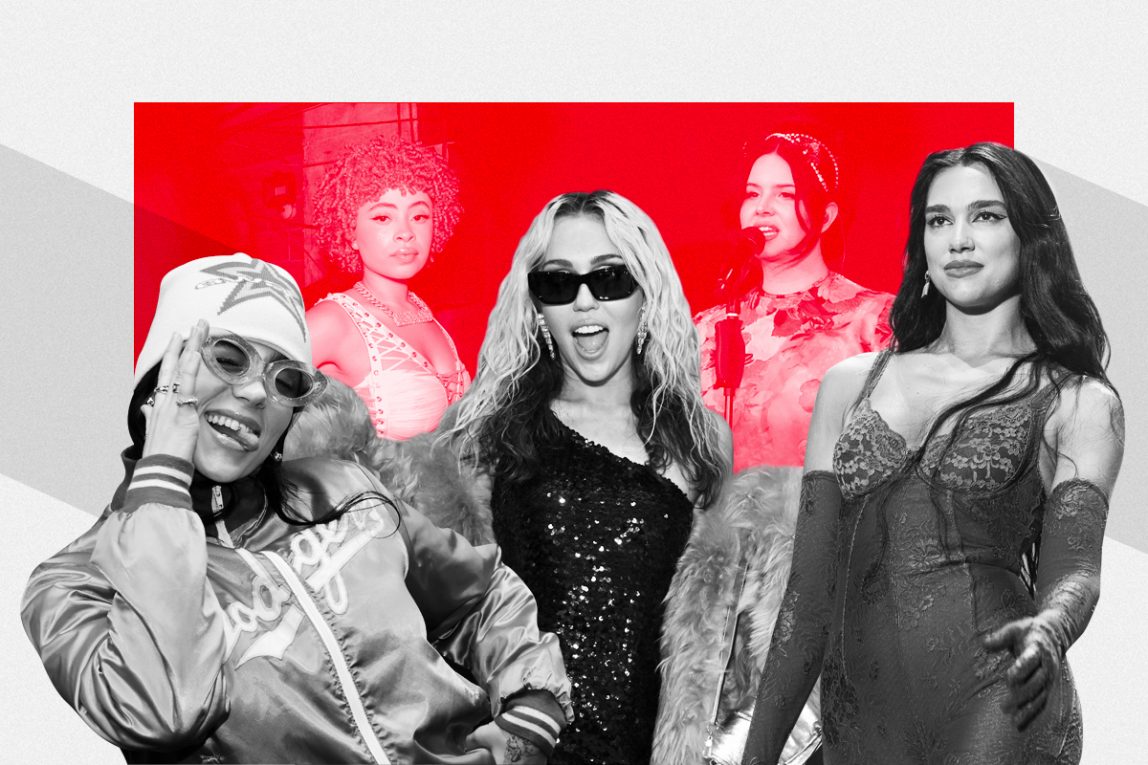Caroline risponde da una stanza d’hotel a Austin, in Texas. È nel pieno del suo tour («il migliore della mia vita fino ad adesso, amo questo spettacolo, il pubblico è tanto e si fa sentire») che ora sta attraverso gli States prima di lanciarla nei principali festival europei e mondiali (per l’Italia bisognerà aspettare la doppia performance – dj set e live – del 2 e 3 novembre al C2C Festival di Torino). Caroline l’abbiamo corteggiata per molto tempo, dall’uscita del suo ultimo disco Desire, I Want to Turn Into You pubblicato nel giorno di San Valentino. E lei da vera star – status che oramai si è guadagnata sul campo – si è fatta attendere, temporeggiando e rimandando, fino a oggi.
Nel frattempo in redazione il disco ce lo siamo ascoltati per bene, confermando ogni nostro buon parere (e tutto l’hype) su Caroline Polachek. Pop sperimentale, avant pop, failure pop, chiamate la sua musica come volete (per la cronaca lei odierà comunque ogni etichetta che proverete ad affibbiarle); a 37 anni e dopo esperienze tra band (Chairlift), progetti solisti (CEP, Ramona Lisa), collaborazioni con il mondo della PC Music (Charli XCX, AG Cook, Danny L Harle, Felicita) e un tour come opening act di Dua Lipa, Caroline Polachek è diventata finalmente l’artista – e la popstar – che sognava di essere. O almeno è sulla strada per raggiungere l’obiettivo perché visto la sua maniacale precisione probabilmente non smetterà mai di annotarsi i possibili miglioramenti da applicare alla sua carriera.
A metà tra la persona più cute del mondo e la studentessa modello che ti corregge per ogni minima virgola fuori posto, relazionarsi con il volto di Caroline Polachek – anche solo su Zoom – è quasi un’esperienza trascendentale, proprio come nel video di Sirens. Ma partiamo.
Hai un rapporto particolare con l’Italia che spesso è stata culla della tua creatività. Si potrebbe anche dire che la Caroline Polachek solista è nata qua da noi, a Roma, nel 2012, quando eri ancora nei Charlift.
Ero in tour con i Charlift, era la nostra prima data a Roma in un festival chiamato Villa Aperta a Villa Medici. Arrivata, mi sono innamorata del luogo, era magnifico. Lì c’è anche un’accademia francese e io parlo francese. Così mi hanno proposto una residenza e ho risposto: «Posso iniziare subito?». Era un’estate molto calda, non c’era molta gente a Roma e loro avevano un sacco di spazio nella villa e mi hanno detto «sì, puoi iniziare subito». Così ho cominciato a lavorare alle mie prime cose soliste.
In passato hai raccontato che in una vacanza italiana sei rimasta folgorata dai Matia Bazar e che ad Amalfi, dopo un acido, ha iniziato a pensare a I Believe, canzone presente nel tuo nuovo disco. L’Italia ti ispira.
Sono tornata in Italia altre volte e ogni volta era come se mi venisse sbloccato qualcosa nel profondo. Sono venuta anche durante gli anni pandemici. Un amico stava facendo un PhD a Roma e voleva compagnia. Così l’ho raggiunto con degli amici e abbiamo fatto un road trip che è stato una rivelazione; c’era il sole, ascoltavamo musica italiana anni ’80 (Matia Bazar compresi) dallo stereo scassato dell’auto circondati dall’umorismo, dalla sensualità e dalla vibe della cultura italiana. La cultura italiana ha un modo fiero e sentito di affrontare il caos con umorismo e gioia di vivere. Mi ha ispirato. Tanto che ho voluto tornarci con tutto il necessario per registrare.
E qui hai lavorato anche Welcome to My Island, uno dei brani portanti di Desire, I Want to Turn Into You, nonché il primo che hai scritto.
Ero in Sicilia, ai piedi dell’Etna, dove potevo vedere la lava sgorgare dal vulcano. C’era ancora il Covid, tutto era molto confuso. Vivere quella situazione è stato qualcosa di molto primitivo, un riflesso di come la società è sempre stata: ho realizzato come la famiglia e la rete di persone che scegliamo per la nostra vita siano le cose che ci fanno sentire sicuri, più di ogni governo o delle notizie al telegiornale. Ho sentito come un senso di universalità a vivere il caos della pandemia in Sicilia.
Prima i Chairlift, poi CEP e Ramona Lisa. Infine Caroline Polachek. Che tipo di percorso e di processo hai attraversato per arrivare finalmente a un progetto a tuo nome?
È stato un processo di riduzione. Quello che riesco a fare adesso è il frutto di una serie di sperimentazioni che ho potuto fare nell’arco della mia vita. Con Ramona Lisa ho lavorato sulla parte più teatrale, sulle coreografie e sul set design, con CEP ho invece avuto occasione di indagare il minimalismo sonoro mentre con i Chairlift l’universo più acustico. Tutte queste esperienze mi ha fatto comprendere cosa mi interessa fare nella mia musica: crea una musica pop elettronica sognatrice interessata all’idea del bello.
Dopo Pang, il primo disco firmato Caroline Polachek, si arriva a Desire, I Want to Turn Into You. Il titolo è molto particolare e introduce un concetto cardine della tua musica: il desiderio. Cos’è il desiderio per te?
Quel titolo è un paradosso voluto e ha tre differenti significati. A me serviva per creare una parentesi in cui le canzoni dell’album potessero vivere. C’è sicuramente un lato più dolce e romantico, ma anche una folle e pretenziosa idea di trasformarsi in qualcosa di impossibile, il desiderio stesso. Per me il desiderio è la forza motrice del mondo. Questo è un disco che parla di movimento, di energia, di sensualità. Il concetto di desiderio è ciò che unisce tutto.
Il desiderio è inoltre un termine ambiguo (come appunto il titolo), a suo modo misterioso e personalmente interpretabile. I testi dei tuoi brani giocano spesso su metafore aperte e immaginazioni e correlazioni libere. Che valore ha il mistero nella tua musica?
Per me è molto più divertente scrivere dei testi con un senso di mistero rispetto a raccontare una storia. Credo nell’importanza di lasciare uno spazio di interpretazione a chi ascolta, presentando due cose che non sono direttamente collegate tra loro e facendo sì che sia l’ascoltatore a creare la connessione tra le parti. Così per ogni persona il testo e il brano avrà un significato differente. Penso che – da lato mio – questa necessità di mistero dipenda dai social media; sono ossessionata dai social media perché chiedono qualcosa di creativo e stimolante al nostro cervello, ovvero di comprendere tra diversi non-detti, tra diverse informazioni che raccogliamo scrollando il feed. Quando scrivo testi facciamo qualcosa di simile, chiedendo a chi ascolta di farci un proprio lavoro creativo.
E se qualcuno comprende un tuo brano in una maniera completamente differente da quello che intendi tu?
Ah, quello succede spesso. E per me è bellissimo, magnifico.

Foto press
Anche a livello strettamente sonoro giochi con molto con un’astuta ambiguità. La tua musica è chiaramente pop, ma piena di variazioni imprevedibili e trovate particolari e sperimentali. A volte molto giocose, quasi provocatorie (penso ad esempio alla verve spagnola di Sunset e alle cornamuse di Blood and Butter). Cos’è il pop per te oggi? E nella costruzione della tua estetica sonora quanto è stato importante per te trovare un compagno di viaggio così aperto come Danny L Harle?
Non penso alla musica sotto forma di generi, penso alla musica in sé. Non so cosa sia la musica pop. O almeno non più. In radio magari abbiamo un brano come Sicko Mode di Travis Scott che dura cinque minuti e non ha ritornelli e in cui il tempo cambia tre volte. Mettere musica in certe categorie non è il modo in cui io la percepisco. E posso dire che Danny L Harle la pensa uguale. Ciò che rende un brano conosciuto non è sempre l’essere conforme a qualche cliché della canzone pop. Io e Danny abbiamo ascolti davvero ampi, dalla musica classica a ciò che va su TikTok, dalla musica fatta per la Norvegian Airlines al rap senegalese. Ascoltiamo senza limiti e ci scambiamo ciò che ci stimola. Ultimamente sono attratta dagli aspetti più formali dei brani, più attenta alla struttura e alla composizione che al genere in sé.
Danny L Harle è solo uno dei tanti affiliati e componenti della PC Music con cui hai collaborato in questi anni. Pensiamo a Charli XCX, AG Cook, Sophie (a cui hai dedicato I Believe), Oklou, Christine and the Queens e molti altri. Non solo dischi, ma anche live, eventi online (come il celebre canto con le anatre per 7 by 7). Insieme state lavorando nella costruzione di un nuovo pop liberato da certi cliché: cosa significa per te aver trovato questa community diffusa di artisti?
È stupendo poter contare artisticamente e umanamente su questo giro di amicizie; insieme abbiamo creato un vero ambiente collaborativo. Sicuramente la prima cosa che posso dirti a riguardo è che collaborare ci spinge ad alzare l’asticella, di continuo. E per tutti noi è fondamentale farlo trovando sempre nuovi modi per divertirci a fare musica, che sia una cosa più grande come un evento livestream o anche solo un testo da scrivere. Ci concediamo il permesso di provare. Ora che le scene sono delocalizzate e molto succede online, l’idea di scena a cui eravamo abituati fino a vent’anni fa non esiste più. Prendi ad esempio noi: ci troviamo a far musica a Londra, Parigi, Los Angeles. È come se la nostra scena fosse il cloud. Penso dica molto dei tempi che stiamo vivendo.
Pang, anche grazie al successo virale di So Hot You’re Hurting My Feelings, ti ha portato a un altro livello di popolarità. Negli ultimi anni il tuo progetto è cresciuto in maniera vertiginosa: per questo disco hai sentito un diverso tipo di pressione in scrittura?
Nella mia carriera non ho mai avuto tanti strumenti quanti ne ho adesso. Non ho mai avuto così tante risorse per il mio progetto. Ho potuto girare cinque video. Ho una serie di persone che lavorano con me, in tour e non, per dei task specifici. La pressione che ho è quella di sprecare queste risorse e le opportunità di fare qualcosa di bello. In tour prendo costantemente nota di ciò che potrebbe essere corretto e utilizzo i vari soundcheck per migliorare il live: a volte è cambiare un arrangiamento, o rifare una coreografia, modificare lo styling. Cerco sempre di fare un upgrade. Lo show si sta avvicinando a ciò che ho in mente e che penso di poterlo raggiungere. So che fare la stessa cosa ogni sera può farmi perdere una certa prospettiva, ma anche quando lavori ad un disco ascolti le stesse canzoni migliaia di volte. Ma non posso perdere l’occasione di tirar fuori il meglio da ogni risorsa che mi sono guadagnata.
Tra questi due album c’è stata la parentesi come opening act per il tour di Dua Lipa. Cosa hai imparato da quella esperienza?
È stato interessante andare in tour con Dua Lipa perché non suonavo per il mio pubblico, ma per il suo. È stata una grande occasione per imparare. Ad esempio, una cosa che ho capito è che non vorrei mai la sua fama; non voglio vivere costantemente con i bodyguard e con i fotografi che ti stanno sempre addosso. Lo odierei. Aver visto da vicino quella vita mi ha fatto capire quanto è importante salvaguardare la propria privacy.
Mi sembri una persona e un’artista molto focalizzata. Hai già in mente i prossimi step della tua carriera?
Sì e posso sintetizzarlo così: next is more.
In una recente intervista hai dichiarato che «il compito più importante dell’artista è di metterci in armonia con il luogo in cui viviamo». È questo il tuo obiettivo nella musica? O qualcosa che tieni come guida?
Armonizzare qualcuno con il mondo e tutte le sue contraddizioni, farci sentire meglio con noi stessi sono cose a cui la musica può ambire. Ma non è il mio obiettivo. Credo fortemente nella soggettività e penso sia impossibile comprendere ciò che pensano e vivono gli altri. Certo, puoi immaginarlo, ma la cosa più vera che puoi fare nella vita è attenerti a ciò che reputi giusto. Questo è il modo che ti dà più opportunità di connetterti alle altre persone. Io cerco di armonizzare me stessa con la mia storia e le mie idee sul futuro per poter sopravvivere in questa terra desolata mantenendo un’anima. Credo che la musica in un certo senso possa rispondere alle contraddizioni della vita, dove emozioni come sensualità, divertimento ed esaurimento convivono quotidianamente. Avere un pubblico è quindi un atto magico, è comprendere che queste risposte sono condivisi anche da altre persone. Tutto ciò che posso fare è provare a indovinare e sperare. E penso che continuerò a farlo.
Vorrei chiudere con una curiosità. Ritornando al tuo rapporto con l’Italia, lo scorso anno è uscito un brano – Last Days: Non voglio mai vedere il sole tramontare – un pezzo operistico per la colonna sonora del musical Last Days dedicato a Kurt Cobain in cui canti in italiano (anche se la nostra lingua l’avevi già sdoganata ne La vita nuova con Christine and the Queens). Per una cantante pop, madrelingua inglese, mi pare un doppio salto mortale. Ci racconti come è nato questo lavoro?
Quella bellissima composizione è stata scritta da Oliver Leith. Il libretto è invece è stato scritto da Matt Copson con cui ho collaborato nei miei ultimi video. La cosa interessante è che nell’opera contemporanea il testo viene scritto prima della melodia. E per me questo è folle, io sono abituata alla melodia come traino per la scrittura di un brano. Matt quindi mi ha portato questo testo in cui dentro c’erano un sacco di reference e concetti al mio album (come la passione per la vita e la paura della morte) che non era ancora uscito ai tempi. E per la melodia Oliver mi ha chiamato e mi ha chiesto «Caroline, qual è la tonalità più alta a cui arrivi?». Dopo aver provato al piano gli ho risposto «Fa diesis» e così mi ha mandato indietro questo brano dove devo rimanere appesa a questa tonalità per così tanto tempo che cantarla è diventata un’esperienza trascendentale. Fisicamente non riuscivo nemmeno a cantarla tutta di fila e abbiamo dovuto registrare le varie parti separate. Ma amo che sia un brano trascendentale ed estremo.