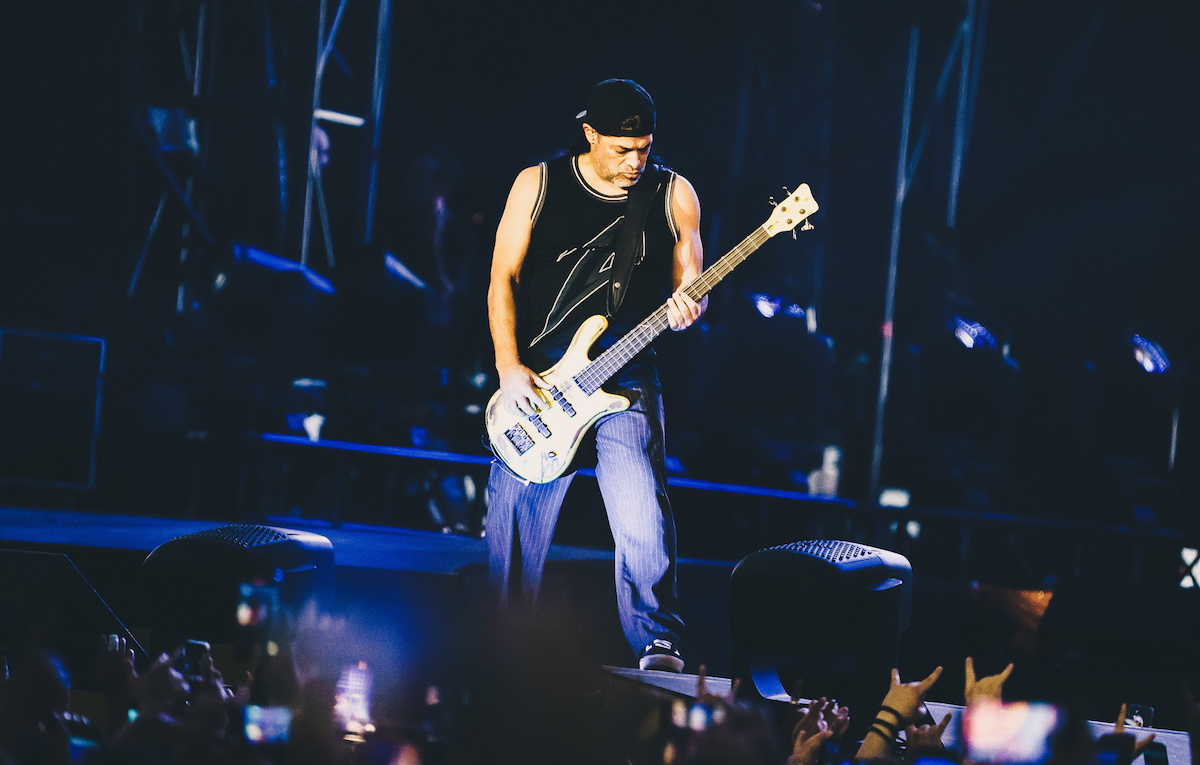Mentre siete intenti a leggere questo articolo, sopra le vostre teste, la sonda spaziale Voyager 1 si sta avvicinando, senza troppa fretta (62mila km/h), alla costellazione dell’Orsa Minore. Sei anni or sono, dopo appena trentacinque anni dal suo lancio, ha lasciato il sistema solare e, se tutto va bene, finirà il suo viaggio tra trentottomila anni. Anno più anno meno. Essendoci delle buone possibilità che finisca sul prato all’inglese di qualche extraterrestre, al suo interno sono stati messi dei souvenir della nostra civiltà, incisi su un disco d’oro così che possa resistere all’impatto. Tolti i convenevoli, ovvero una serie di saluti in cinquantacinque lingue diverse all’alieno che sia sia preso la briga di trovarsi un giradischi spaziale, l’allora presidente degli USA, Jimmy Carter, si occupò di far fare una playlist interstellare che bene rappresentasse i gusti musicali sul nostro pianeta.
Incredibile ma vero, non c’è traccia della Dark Polo Gang. Ma non c’è traccia nemmeno di Hendrix o dei Beatles, il che rende più complesso capire come sia stata fatta la selezione. Non c’è Verdi ma c’è il canto notturno degli indiani Navajo, non c’è Wagner ma c’è Louis Armstrong con Melancholy Blues. Esservi stati inclusi con un proprio brano è senza dubbio una responsabilità con un suo peso. Perché se sei morto e sepolto da cento e passa anni, come Beethoven, (ti) va bene. Ma se sei ancora in vita può succedere che ti chiedano di suonarlo di continuo, e suonatelo voi un brano consapevoli che, se non fosse gradito dalle parti dell’Orsa Minore, potrebbe scatenare chi sa quali conseguenze. E’ quello che successe a Chuck Berry, quando per i festeggiamenti del decennale del lancio, venne invitato nel 1987 a Washington per la sua Johnny B. Goode. Arriva in ritardo, l’autista ha sbagliato strada, lo molla davanti al Kennedy Center che si sentono già le note del Concerto Brandeburghese di Bach, si infila nel camerino e pensa di non volere uscire più. Si sente fuori luogo, lo strano della situazione, non all’altezza in un contesto sproporzionato alla sua musica. Allora l’amico e fotografo Es Edwards gli butta in mano un ansiolitico a base di etifoxina per fargli trovare da qualche parte il coraggio di esibirsi.
Per anni sono rimasto convinto che di questo parlasse Pastiglie, uno dei brani più noti dei Prozac+. Dell’ansia di non riuscire, di sentirsi inadeguati e trovare nelle pastiglie un aiutino chimico per ogni evenienza. Una canzone (a suo modo) punk sul classico tema dell’autodistruzione volontaria, con un testo vicino a quella (in)sofferenza giovanile attraverso cui siam passati un po’ tutti. Pastiglie per studiare, pastiglie per dormire, pastiglie per sognare e persino per amare. Prese sia per raggiungere uno scopo tanto più per capire se si è ancora in grado di fare o provare qualcosa. In realtà è molto poetico tutto ma non è così. Uno dei primi, se non il primo ma uno dei primi pezzi scritti da Gian Maria Accusani (ora chitarra e voce nei Sick Tamburo, se anche la vostra testa è in giro col Voyager 1) per i Prozac «Parla di ciò che dice, è palese!», mi dice. «Avevo notato, anche per un’esperienza diretta, che oramai ti prescrivevano pastiglie per ogni cosa e mi è venuto di buttarla giù in forma-canzone».
Piuttosto, è un’altra la peculiarità: «Era il mio primo tentativo di brano in italiano. Così, nonostante il testo sia sempre stato lo stesso, il giro di voce ha fatto almeno tre passaggi prima di raggiungere la versione nota a tutti. Io non sentivo per niente musica italiana, per questo l’idea di fondo era di trasportare in italiano quel tipo di suono in inglese che ascoltavo. Da qui nasce poi l’idea della ripetizione della vocale finale che ha caratterizzato molti dei miei testi di quel periodo».
Il che assolve, a mio avviso, Chadia Rodriguez per averne preso il ritornello di Pastiglie per inserirlo, a mo’ di tormentone, in un pezzo trap zarro e vanesio che nulla ha di che spartire sia con le mie pippe mentali nichiliste che con la realtà dei fatti or ora narrati. Non sempre la musica finisce, chissà come, nelle mani giuste. Non c’è sempre un Johnny Cash a trasmutare in struggente ballata country l’incedere industrial dei Nine Inch Nails. Capita più spesso che la musica faccia giri strani e, per dire, un brano di Nina Simone, Don’t Let Me Be Misunderstood, finisca per diventare simbolo di milioni di piccoli Tony Manero con i Santa Esmeralda. Vogliamo fargliene una colpa? «Sentire un mio pezzo in altri contesti non mi crea nessun disturbo» sorride Gian Maria. «Cover e altre versioni di pezzi miei ne ho sentite a volontà. Ma una canzone è una canzone e se qualcuno vuole rifarla in un modo diametralmente diverso c’è solo da dire grazie perché, alla fine, resta un tributo. Poi, è ovvio, io vengo da un altro mondo e sono di un altro mondo ma che un brano che ho scritto o un suo pezzo vengano messi in un altro contesto non mi crea nessun imbarazzo o nessun fastidio. Anzi, a volte è più imbarazzante una cover fatta da simili ma con pessimo gusto che un’appropriazione del tutto svincolata ma che regge bene». Tanto più se l’idea parte da un amico comune, quel Big Fish che con Gian Maria ha condiviso una signora etichetta indipendente, la Vox Pop, che durante gli anni Novanta produsse tanto i Sottotono quanto i Prozac assieme a una caterva di bella roba che andava dagli Africa Unite ai Ritmo Tribale. E proprio Fish ora ha le mani in pasta dietro alcuni dei progetti trap da quattro milioni di visualizzazioni, da Young Signorino a Chadia appunto. Nessuna appropriazione indebita quindi: «Mi ha chiesto se poteva prenderla e gli ho risposto di si». Easy.
Chadia Rodriguez, quando il video di Pastiglie era in heavy rotation sulle reti televisive nostrane, forse non era neanche nei pensieri di mamma e papà, essendo nata due anni dopo, nel 1998. Lei non può avere quindi una memoria storica ma noi sì. Non può ricordare le critiche, a volte anche feroci, lanciate ingiustamente da lì a breve contro i ragazzi di Pordenone da quanti si eressero a difensori della supposta musica “di qualità” di allora. La storia è nota: partiti dall’essere i next big thing di casa nostra, con tanto di copertine e approfondimenti per scoprire la formula segreta di quell’idea semplicemente irresistibile i Prozac+ finirono per tirarsi addosso l’ira funesta di quanti non ressero il loro successo. Per invidia o snobbismo, poco importa. Quelli che, nella migliore delle ipotesi, amavano i Tool, mettevano in copertina Beck, lodavano i Radiohead o i Pearl Jam e di italiano tolleravano poco, pochissimo, praticamente nulla. Quelli secondo cui il “non sanno suonare”, i “fenomeno da baraccone” e il sempiterno “musica per ragazzini” sono la santa trinità del Giudizio Critico per ogni evenienza; a patto che non si parli dei propri beniamini, solo in quel caso allora diventano pregi e non difetti. I più (Colti? Ricercati? Scemi? Fate voi…) facile che ora siano gli stessi che, alla soglia dei quarant’anni, lanciano le stesse invettive nei confronti di Chadia. Colpevole di avere citato un testo che all’epoca hanno rinnegato in lungo e in largo, hanno ritenuto fuori luogo e inadatto alle proprie orecchie dopo il trionfo di Acido/Acida e ora riscattano come “inno generazionale”. Invece di lodarla per l’encomiabile ripescaggio (suo, o di chi per lei) di una delle penne più capaci del circuito pop-punk italiano, ossia quella di Gian Maria Accusani appunto, che tanti millennials probabilmente non conoscevano e ora sì. Un paradosso che ci fa ridere e al contempo chiedere, di tutti i tipi di pastiglie multicolore menzionate nel testo, quale sarebbe oggi la più indicata per questo genere di amnesie collettive e ipocrisie diffuse. Del resto, prevenire è meglio che curare.