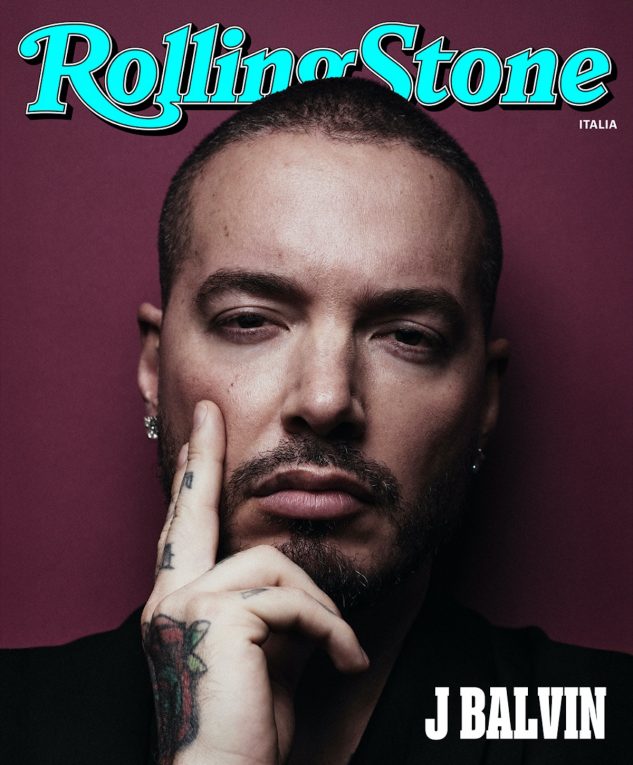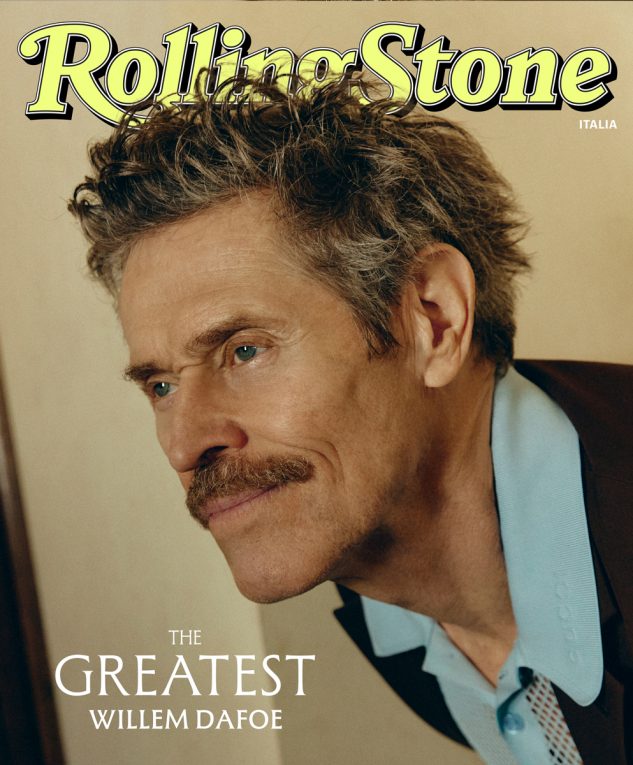Cristiano Godano «all’ennesima potenza»
Sta per pubblicare un album, ‘Stammi accanto’, che rappresenta alla perfezione il suo carattere di musicista riflessivo e autore che sceglie con cura le parole. Una lunga intervista: la ricerca della purezza, l’approccio meditativo, la «quiete magnetica», l’idealismo, la necessità della speranza. E la musica che gira intorno: «La mia non garantisce gli stadi, ma la rispettabilità»
Foto press
Cristiano Godano torna con Stammi accanto, un disco solista che è tutto tranne che una pausa di decompressione dall’attività coi Marlene Kuntz. È un viaggio dentro l’arte senza compromessi, con la consapevolezza lucida che «la mia musica non garantisce gli stadi, ma la rispettabilità». In un’epoca in cui basta un video su TikTok per azzerare o lanciare una discografia, lui sceglie di giocare a scacchi con la riflessione, con la spiritualità, con la vulnerabilità. «Sono un idealista», ammette. E lo dice come uno che sa di essere fuori dal mercato, ma anche uno che non è mai stato in vendita. Canta che “rimane una stanca vastità di illusioni”, scrive che queste canzoni «si sforzano di reagire opponendo una resa quieta alle turbe e alle paure», e in mezzo spunta pure Samuele Bersani per parlare d’ansia, «perché la musica è il mio demone». Godano, insomma, sembra non flirtare con l’ironia del disincanto: «Se una canzone non la sentissi mia, non saprei come difenderla. Non saprei che farmene».
In questa lunga intervista parla come scrive, e scrive come canta: critico, poetico, visionario. «Internet è una gabbia», «si darà per scontato che un processo artistico passi attraverso l’intelligenza artificiale», «i giovani hanno poche chance di vivere di musica». Eppure è uno che continua a credere che «stare in una band ti rende un uomo migliore». Rifugge dalla definizione di intellettuale («mi viene da prendere le distanze»). Si sente uno che si assume la responsabilità di ciò che pensa. E quando canta “Cerco un centro di gravità” dopo Battiato, lo fa con la faccia tosta di chi ti ricorda: «Picasso diceva che i bravi copiano, i geni rubano». E lui, in quel pezzo, è consapevole di aver rubato a un maestro.
Cristiano, può sembrare poco originale, ma prima di tutto come stai?
Sono molto sollecitato. Questo disco segna l’inizio di un periodo in cui mi muoverò parecchio, su e giù per l’Italia, per impegni legati al mio lavoro. Quindi sì, sono sollecitato anche dal punto di vista energetico. Evito di lamentarmi della stanchezza, perché la verità è che sto bene, davvero molto bene quando ho la possibilità di fare quello che amo.
Stammi accanto l’hai definito un disco puro, che «non cerca il colpo a effetto perché è fiducioso nella musica». Però hai ammesso che con questo approccio «potrebbe scolorire in un ingombrante anonimato». Perché prendersi un rischio del genere?
Perché forse, banalmente, sono un idealista. Mi piace l’idea di non venire meno a ciò che mi accende quando suono. In questo disco sono me stesso all’ennesima potenza. Non vedo l’ora di suonarlo dal vivo con i Guano Padano. Abbiamo fatto delle prove pochi giorni fa e mi sono piaciute tantissimo. Finalmente sto riuscendo a portare sul palco i miei pezzi con una band, perché con il disco precedente, causa contingentamenti di quel periodo nefasto che è stata la pandemia, non era possibile. Non ho mai suonato quei pezzi live con una band.
Parafrasando la vecchia serie tv americana, Il pericolo è il mio mestiere, questo pericolo fa parte del mestiere dell’artista?
Sì, io non posso far altro che prendermi questi rischi. Perché in fondo sono sempre stato fiducioso, anche con i Marlene Kuntz, della bontà di ciò che propongo. Certo, poi ci si rende conto che il mondo non sempre la vede come te, però nel mio approccio, così come in quello di Luca Rossi, con cui ho realizzato gran parte del disco, c’è una vera e propria purezza.
Nel panorama attuale, pensi che si sia persa questa voglia di rischiare?
Come ti dicevo, sono un idealista ma non è che non sia sensibile alla possibilità di vendere dischi o di fare streaming. Però, quando si vendevano davvero i dischi, tutto questo aveva un senso. Con gli streaming il senso è molto più labile. Solo chi fa numeri impossibili, e parliamo di centinaia di milioni di stream, può davvero ragionare in termini economici. Per il resto, se uno ha un minimo di consapevolezza, è quasi inevitabile cercare di fare le cose bene, cioè da un punto di vista puramente musicale. Detto questo, ho opinioni pessime su quello che sta accadendo alla musica a causa di internet. È molto verosimile che abbia innescato un passaggio nefasto, che verrà solo amplificato dall’intelligenza artificiale.
Sei così pessimista sul futuro della musica?
Per quanto mi riguarda è una semplice intuizione: secondo me è plausibile pensare che fra due o tre generazioni si dia per scontato che un processo artistico passi attraverso l’intelligenza artificiale. Tutto ciò è disarmante, ma ne sono convinto. Non sono sicuro che accadrà, però è un’ipotesi per me più che plausibile.

Foto press
È vero che Stammi accanto ha rischiato di non vedere la luce?
Sì, quando le canzoni del disco sono state pensate, l’esigenza principale era trovare da qualche parte l’energia per uscire da quello stallo in cui l’umanità si era ritrovata a causa del Covid. Perché io faccio parte di quella categoria di artisti che sono stati letteralmente schiacciati. E per molto tempo non ho potuto, e forse nemmeno saputo, approfittare del grande tempo a disposizione che avevo. Ma poi, a un certo punto, ho sentito il desiderio fortissimo di uscire da tutto ciò. Questo desiderio è arrivato più o meno in concomitanza con la scoperta del vaccino. E con il vaccino, finalmente, la popolazione ha potuto rifiatare. Nell’umanità si è diffuso un desiderio vitale di risorgere, un desiderio molto fisico, anche, di uscire, di andare a fare aperitivi con gli amici, insomma, di tornare a vivere. In quel momento mi sono ritrovato tra le mani in mano un disco che non aveva paura di affrontare non solo questioni sociali, ma anche la mia vulnerabilità, la mia riflessività. Questo disco, più ancora che vulnerabile, è molto riflessivo. Contiene considerazioni che ruotano attorno a un approccio meditativo, alla spiritualità orientale. Questa componente, che credo sia predominante, mal si conciliava con quel desiderio collettivo di rinascita e leggerezza.
Quindi è rimasto in stand-by?
Allora ho sospeso tutto, perché eravamo in uscita da un periodo negativo. Adesso, invece, siamo entrati in un periodo tristemente complesso, probabilmente deprimente, pieno di angoscia. E dobbiamo trovare il modo per decodificarla. Ed è in questo momento che la vulnerabilità e la riflessività del disco tornano a essere compatibili con il periodo che stiamo attraversando. Penso che sia necessario avere il coraggio della propria vulnerabilità, e allo stesso tempo bisogna trovare da qualche parte le risorse per tenere viva la speranza.
Non a caso canti: “Eppure so che devo continuare a sperare”.
La speranza, oggi, è un’ancora di salvezza. Perché l’assenza di speranza è immobilità, sospensione nell’angoscia. E di tutto abbiamo bisogno, tranne che di questo. Altrimenti, davvero, lasciamo che il nostro mondo così complesso ci fagociti definitivamente.
Nella presentazione scrivi: «Queste canzoni si sforzano di reagire opponendo una resa quieta alle turbe e alle paure». Sembra un atteggiamento gandhiano, o esagero?
In parte può esserlo, anche se il clima e l’atmosfera del disco è di una magnetica quiete che lo attraversa tutto. Infatti, non c’è mai un momento arrembante. È tutto orientato a quel desiderio di eleganza e raffinatezza che avevamo. Un desiderio anche di suonare e godersela nel suonare. Per me è puro godimento. È un approdo, un nuovo inizio. Anche se nuovo inizio è forse un’espressione un po’ esagerata, perché ho già iniziato da tempo a fare queste cose in acustico. Però continuano a gratificarmi moltissimo.
Anche il luogo in cui l’avete registrato ha influito. Il PlaTone studio, sull’appennino tosco-emiliano, dove «passavo le mattine a oziare contemplando la natura e perlustrando i luoghi, e dopo pranzo si cominciava per andare avanti sino alle 21».
Parliamo di un’esperienza precedente a quella delle residenze artistiche per Karma Clima. È una narrazione che anche lì abbiamo avuto modo di sviluppare. Io però ero già reduce da quest’altra esperienza, in una montagna forse meno eclatante rispetto al Monviso, che avevamo davanti durante Karma Clima, ma comunque immersi in un contesto isolato. Un isolamento favorito non solo dal fatto che quei paesini sono davvero piccini, ma anche perché in quel periodo la gente era ancora inibita ad uscire di casa. Le mattine per me erano rigeneranti. Perlustravo le zone intorno, ricordo certi passaggi vicino a un fiumiciattolo sotto a dove dormivo, e poi si andava a suonare tutto il giorno. Indubbiamente questo ha favorito la quiete del disco. Una quiete che non va però fraintesa con una mollezza. Mi sembra che si senta una bella tensione magnetica nell’album.
Uno dei brani, Dentro la ferita, è in collaborazione con Samuele Bersani. Perché proprio con lui ed è nato prima, durante, o dopo l’esperienza che ha raccontato di aver dovuto affrontare, cioè il tumore ai polmoni al primo stadio che è riuscito a curare?
La canzone esisteva già. Avevo proprio il desiderio di ospitare qualcuno nel mio disco, perché mi piaceva l’idea di aprirlo ad altre voci. Ma non qualcuno a caso, tanto per cercare di racimolare streaming a tutti i costi. Samuele l’ho conosciuto all’epoca di Ricoveri virtuali e sexy solitudini, un disco dei Marlene Kuntz, dove andammo in Islanda a realizzare tre video con i Masbedo, il duo di video artisti. Samuele è molto amico dei Masbedo, quindi era lì con loro in quella sorta di viaggio-fuga che si era concesso. Lì nacque una reciproca simpatia, anche se non coltivata da una frequentazione abituale. Io lo stimo molto come artista, e credo che anche lui stimi me, altrimenti non avrebbe accettato l’invito. Gli ho fatto ascoltare il brano, sperando che il tema lo toccasse, lo coinvolgesse. È un tema delicato, perché ruota attorno all’ansia, anche se le parole cercano di amplificare il significato, di estendere le evocazioni. Gli è piaciuto e ha aderito con disponibilità.
Prendo da Dentro la ferita: “Ho dato un nome al mio demone”. E che volto ha?
Il mio demone è la musica. Qualche giorno fa mi sono imbattuto in un reel curioso di Moby su Instagram in cui dice che nel momento in cui è nato ha capito che la musica sarebbe stata tutto per lui. Ora, io non credo che per me sia successo così repentinamente, però ricordo perfettamente quanto fossero emozionanti i primi 45 giri che mia madre mi comprò. Avevo 5 o 6 anni. E non era l’oggetto a emozionarmi. Era la musica. Credo di aver semplicemente assecondato questa passione fortissima. E, essendo riuscito a vivere facendo musica, sono riuscito anche a seguire il mio demone soddisfacendo me stesso.
Visto che ti piace rischiare, provo a farlo anch’io. Nel brano Stammi accanto ci sono un pianoforte e un testo che mi hanno rievocato Imagine di John Lennon, ma senza la speranza, anche ideale, che animava quel brano. Sono solo mie suggestioni?
Non era una mia reference, però è affascinante quello che ci hai sentito. Mi piace! Gli ideali di cui parlo nel testo, la caduta di quegli ideali, sono una faccenda estremamente personale. Non parlo della caduta degli ideali in un contesto sociale, ma delle mie illusioni. Però la tua è una lettura bella, plausibile. Diciamo che la parte di rischio te la sei giocata bene.
In quel brano canti: “E c’è una stanca vastità di illusioni e ideali: è la mia vita. Come finirà amore mio? Cosa resterà di me, di noi? Giunto al limite resto in bilico: se passerò di là mi perderai e mi perderò. E poi la fine”.
È innanzitutto una canzone d’amore. Un amore che è finito, o che sta finendo. Però le strofe possono suggerire anche altre interpretazioni, quindi aiutare ad allargare la visione. Credo che sia una delle tecniche che utilizzo più spesso nei miei dischi. In particolare quando parto da me stesso, ma sappiamo bene che la letteratura è finzione, il poeta è un fingitore. Sono cose che non compio intenzionalmente, le percepisco dopo, non è che mi metta lì a dire: ora devo fingere. Ma è un’attitudine, un modo per chiamare chi ascolta a una forma di condivisione. Quindi sì, può far pensare che parli di altro, ma resta una canzone d’amore.
Quando hai citato la meditazione mi è venuta in mente Nel respiro dell’aria, secondo brano del disco, dove utilizzi parole che sembrano derivare, appunto, da un percorso spirituale: ascendere, discendere, elevarsi, anima.
Ci sono anche altre canzoni connesse a quel tipo di spiritualità. Questa ha un tono un po’ sfacciato, una sfrontatezza che ogni tanto mi piace avere nei testi. Sono consapevole di usare parole forti, è un filone, non frequentatissimo ma significativo, di canzoni in cui emerge un tratto tipico della mia poetica: il proiettarsi per aria. È una mia strategia immaginifica, una forma di fuga dalle contingenze. Come per esempio in Nuotando nell’aria, nel ritornello di A fior di pelle o in La fuga di Karma Clima. È un’attitudine che ho, e secondo me Nel respiro dell’aria rientra perfettamente in quel filone.
Da Eppure so: “Ricompare il mondo che non vorrei, ogni cosa porta il peso dei nostri guai”. Come affronti la discografia attuale, dove nonostante tanta ricerca a livello di musica e testi si può comunque finire nell’anonimato?
Con resilienza. Ma anche con molta proattività. Mi pregio di aver intuito in tempi non sospetti, quindi molti anni fa, che internet rappresentava l’inizio della fine. E di essermi lamentato della “ruberia” della rete quando ancora i musicisti cercavano di far finta di niente. Ora tutti hanno capito e sono rassegnati a fare musica gratis. Io queste cose le dicevo già 15 anni fa, quando ti garantivi, al massimo, la gogna di chi ti sorrideva con sufficienza, come se non sapessi interpretare la modernità. Ma io sentivo che lì sotto, lì dietro, si nascondeva una gabbia. La rete è una gabbia costruita in modo da farci muovere guidati dagli algoritmi. Sono cose oggi abbastanza di dominio pubblico, anche se non ancora per tutti.
In Lode all’istante utilizzi un termine piuttosto desueto come “aulente”. La resistenza all’omologazione e agli algoritmi passa per l’utilizzo del vocabolario?
Sì, anche se non voglio passare come un ingenuo vecchietto abbarbicato al passato. Credo semplicemente nella forza di un approccio puramente artistico, quindi idealmente artistico. Non mi garantisce gli stadi, però mi garantisce la rispettabilità. E i miei fan si aspettano che io non venga meno a questi valori. Durante il tour di Catartica dell’anno scorso, la maggior parte del pubblico era vicina a noi come età, ma non erano così poche le facce giovani. E quei giovani erano molto attratti da qualcosa che li sorprende, come un impatto come quello dei Marlene. Alcuni li ho visti chiedersi: «Ma cosa fanno questi?». Lo stesso vale per l’uso delle parole. Preferisco l’ammirazione profonda di un 30% di persone all’incomprensione indistinta di un 80%. Mi fa sentire appagato. E quando intercettate, comprese, capite, le mie canzoni sono convinto appaghino a loro volta chi le ascolta.

Foto press
Con Cerco il nulla hai avuto un po’ di spericolatezza nel sostenere “Cerco un centro di gravità” dopo Franco Battiato…
Ma sai, com’è che diceva Picasso? I bravi artisti copiano, i geni rubano. O qualcosa del genere. Raramente un artista inventa tutto dal nulla. Ora, io in realtà ho semplicemente sfruttato quella frase per giocarci. Era molto coerente con l’immaginario del pezzo, che tra l’altro credo sia il mio preferito del disco. È come se fosse una piattaforma su cui poi posso espandere le mie visioni. Ovviamente è tutto molto consapevole, questo è evidente.
Nell’ultimo brano, Vacuità, mi è venuta in mente una citazione, di cui non ho trovato riscontri ma che rende l’idea, che Carmelo Bene attribuì alla mistica Teresa d’Avila. «Perché lo fai?» le chiedevano. E lei rispondeva: «L’amour pour l’amour, l’amour pour la fièvre». In particolare in questo passaggio: “Ma quando poi arriva lei effondono per me un’azzurra intensità quegli occhi fulgidi: ravvivano il desiderio”.
Quello che mi interessava nel testo era proprio questa dinamica. Vacuità è un concetto cardine del buddismo: è uno stato mentale e spirituale auspicabile per un percorso di emancipazione. C’è un passaggio del testo in cui dico: “Slegami dagli orpelli e portami dove scivola ogni cosa che la mente vede, giudica o desidera”. Sia la meditazione che il buddismo puntano a questo: liberare la mente. E la vacuità rappresenta l’approdo ideale di questa condizione. Volevo sottolineare che sì, c’è questo mio slancio, questo tentativo di arrivare lì, ma poi una distrazione clamorosa, come lo sguardo dell’amata, ti riporta con forza alla dimensione terrena, concreta, emotiva. Questo è un po’ il senso.
Ti sei mai chiesto cos’è che spinge un artista, a un certo punto di una carriera piena di soddisfazioni insieme a una band, a intraprendere un percorso solista?
Forse sarò deludente, ma per me è una questione eminentemente musicale. Non posso chiedere ai Marlene di vestire queste canzoni, con questo tipo di arrangiamenti. Non è nel loro codice. Non sarebbe nemmeno pensabile. Me lo posso permettere, perché i Marlene non devono più dimostrare niente a nessuno. E poi, io sono un never-ending man, per cui non posso costringerli a fare 100 date all’anno. Io invece, se le faccio sono felice. Mi piace stare in giro, raccogliere l’affetto della gente, sentire la loro passione. È qualcosa di vivificante, che mi fa stare bene. Mi piace l’abbraccio reale e metaforico delle persone. Lo cerco.
Prima della sua scomparsa, chiesi a Paolo Benvegnù che cosa ricordasse più vividamente di se stesso nell’esperienza con gli Scisma, e rispose: «Ero un giovane uomo infernale e presuntuoso». Sono atteggiamenti che, in passato, ti hanno riguardato?
Penso di sì. Ma credo anche che sia qualcosa di intrinseco all’essere giovani, all’essere scalpitanti. C’è il fuoco della gioventù, e poi il ghiaccio dell’esperienza. Fa parte del percorso di crescita. Però, non mi pare di rintracciare nulla nel mio passato che oggi mi procuri imbarazzo. Sicuramente ci sono state scelte presuntuose, ma non così tanto da doverle rinnegare. So riconoscerle. Magari il linguaggio, certe posture… ma direi che quasi subito mi sono reso conto dell’importanza e della responsabilità che avevo per ciò che scrivevo.
Per esempio?
Ricordo che già all’uscita del primo disco avevamo inserito, in epoca pre-internet, un invito al dialogo: «Scrivici a…». Con la casella postale di Cuneo intestata ai Marlene Kuntz. E arrivarono tantissime lettere. Uno dei leitmotiv di quelle lettere era: «Sei un poeta». Per me era sorprendente, qualcosa di assolutamente nuovo e inaspettato. E da subito ho capito che dovevo usare le parole con grande responsabilità. Mi ricollego alla parola “aulente”. Se avessi dovuto usare una parola come “odorosa”, che è un sinonimo, non sarebbe scivolata così bene nel canto. Paul Valéry diceva: «La poesia è una lunga esitazione fra il suono e il significato». Io voglio significare, ma anche che le mie parole suonino bene. E non devo aver paura di usarne una strana. Me ne assumo la responsabilità se so che può funzionare.
Dopo la reunion, i CCCP hanno spiegato di volersi sciogliere definitivamente perché tutto ha un inizio e tutto deve avere una fine. Ci avete mai pensato con i Marlene?
Allo stato attuale posso solo dire che i Marlene non hanno mai mollato. Mai. Abbiamo sempre avuto il desiderio di una lotta pura e genuina. Siamo sempre stati consapevoli, già da Catartica in avanti, che tutto un giorno sarebbe potuto finire. Anzi, all’inizio avevo spesso il timore che la favola finisse presto. Lo ha testimoniato anche la scena musicale da cui venivamo. C’erano tanti gruppi all’inizio, ma poi rimasero solo in pochi, dai Litfiba ai CCCP ai Diaframma. La stragrande maggioranza è sparita. E io, forte di questa consapevolezza, ho sempre lottato perché i Marlene non morissero. E lo abbiamo fatto seguendo un principio: la dimensione artistica. Non c’è un solo brano dei Marlene che sia stato scritto per servire a qualcosa. Ogni pezzo è stato pensato, invece, per essere bello. Non certo per vendere.

Foto: Gabriella Vaghini
Visto che hai una rubrica su Rolling Stone, prendo spunto da un tuo articolo su un “amico-nemico” che ha fatto scelte considerate piuttosto ardite entrando in ambienti mainstream come X Factor per provare a cambiare il sistema dall’interno. Hai scritto: «Manuel Agnelli ha impostato tutta la carriera all’insegna di un’ambizione smisurata come probabilmente non si era mai verificato prima in Italia nell’ambito del rock non mainstream, e si è posto un obiettivo straordinario: portare la sua musica ai piani alti o medio-alti del potere, scalino dopo scalino, concerto dopo concerto, con un senso del business ben chiaro in testa». Pensi che, passati alcuni anni, abbia raggiunto l’obiettivo?
Intanto, rispetto alle mie scelte, è anche una questione di tempra, di energia. La mia tempra è diversa da quella di Manuel, sostanzialmente. Penso a quando De André disse che non amava rispondere alle interviste in televisione perché i tempi della tv non gli permettevano di espandere il suo pensiero. E parliamo di una televisione che, comunque, lasciava molto più tempo di oggi, con un pubblico ancora disponibile a dedicare 3-4 minuti a qualcosa. Ora, con i social, se riesci a tenere le persone per 30 secondi è già tanto. Quindi il problema si è ingigantito. Io penso di essere sempre stato frenato dal timore di non essere la persona adatta a vestire certi tipi di abiti. L’articolo che scrissi voleva illustrare un’attitudine, anche straordinaria, rispetto a quello che era il modo di essere musicisti all’epoca. Un’epoca più sganciata dalla visione economica. Ma non lo dicevo né in positivo né in negativo: volevo solo fotografare una situazione. Raccontavo due mondi differenti. E una sua certa abilità.
Dai Måneskin a X Factor e poi fenomeno globale con il rock, si è arrivati a Lucio Corsi e Brunori, due cantautori legati all’indie, secondo e terzo a Sanremo. Non che una presunta nuova ondata sia solo merito suo, ma un bug l’ha inserito nel sistema?
Non saprei. So che Manuel ha avuto spesso problemi seri nel confrontarsi con quel mondo.
Problemi, immagino, anche legati al fatto di non poter davvero fare le scelte che avrebbe voluto. Non credo che abbia potuto, ad esempio, assegnare i brani a X Factor come magari si sognava di fare. Credo si sia scontrato con un sistema più forte di lui, da quel punto di vista. E poi io non sono mai stato un fruitore costante di X Factor. C’è stata un’edizione in cui l’ho visto quasi tutto, ma in generale i miei interessi vanno altrove. Però si può voler vedere X Factor come si può voler vedere Sanremo, con curiosità. Non necessariamente con la pruderie del distacco. Io, ad esempio, quando guardo Sanremo, non sono affatto distaccato. Anzi, cerco di apprezzare tutto ciò che è apprezzabile.
Ti riporto un episodio che mi ha raccontato Giulio Casale: «Una volta il direttore generale della Warner mi disse: “Casale, con la faccia che hai potresti essere più famoso di Nek”. Io mi alzai e gli risposi: “Ti ringrazio, perché mi hai restituito esattamente l’immagine che non vorrei mai essere nella vita”». È stato il tuo stesso atteggiamento?
È vero. Noi apparteniamo a una visione della musica purissima. I miei riferimenti erano i Sonic Youth. Ma venivo anche dai Fugazi, dagli Shellac, dai Big Black… Era tutta roba in cui ciò che contava era solo la musica, non i soldi. E io provengo da quella visione lì. Ma non vorrei che la mia immagine fosse quella di uno che fa la sua lotta personale contro il sistema. Io, in questo sistema, cerco di entrarci alle mie condizioni. Cerco di persuadere gli ascoltatori e il mondo della bontà artistica di ciò che faccio. Non sono capace di scendere a compromessi, tipo “metterci la faccia” per diventare il nuovo Nek. Se scrivessi una sola canzone in cui non credo, non saprei come difenderla. Non saprei rappresentarla, sostenerla, divulgarla con entusiasmo. Ogni canzone che ho scritto ha pari dignità. E se una canzone nasce con malizia, per arrivare da qualche parte, io non saprei che farmene.
C’è qualche no che hai detto e di cui oggi sei orgoglioso?
Devo pensarci… credo di no.
Forse perché certe proposte, conoscendoti, neanche te le facevano?
Può essere che, semplicemente, non ci provassero nemmeno sapendo già come eravamo fatti. Siamo entrati nel mondo delle major con il disco Che cosa vedi, era il 2000, ma nessun discografico ha mai provato seriamente a imporci qualcosa. L’unico caso che ricordo è stato il suggerimento di fare un duetto con Skin.
Con La canzone che scrivo per te, contenuta proprio nel disco Che cosa vedi.
Io e i Marlene non avremmo mai avuto quell’idea, non l’avremmo nemmeno pensata. Ci siamo presi del tempo per valutare, e siccome siamo curiosi abbiamo detto: «Ma sì, perché no, sarebbe figo». A parte questo, nessuno ci ha mai chiesto nulla. Tant’è che i dischi successivi, fatti con la major, erano difficilmente vendibili. Penso soprattutto a Bianco sporco, del 2005, un disco di introspezione incredibile. Ricordo che arrivammo alla sede della discografica, ci accolsero con dolci e cordialità, poi facemmo ascoltare il disco. E credo che nei loro occhi si sia letta una domanda: «Come cazzo lo vendiamo?». Ma non fu una provocazione. Pensavamo fosse la cosa più bella che potessimo fare in quel momento.
Come si vive, da intellettuale, in un’epoca dove gli intellettuali non sono mai stati così poco rilevanti?
Intanto ho grosse difficoltà ad ammettere di essere un intellettuale. Me lo dicono, però mi viene sempre da prendere le distanze. Sono un musicista che prova a riflettere. Che si va a impelagare, come tu sai bene perché scrivo anche sul vostro giornale, in discorsi e considerazioni che, in genere, mi garantiscono una gogna e delle shitstorm che non vorrei. Perché tutto ciò che scrivo lo faccio col cuore in mano. Con il desiderio di contribuire a una riflessione. Poi mi rendo conto che le cose non vanno sempre così. Ma sì, hai ragione: siamo in un’epoca in cui non c’è nessun carisma specifico legato alla figura dell’intellettuale.
Ultimamente hai preso posizione in altri due articoli. Cito i titoli, che sono piuttosto emblematici: “In bocca al lupo, Europa” e “Contro il tecnofascismo”.
La faccenda del tecnofascismo l’ho teorizzata almeno sei o sette anni fa. E sono orgoglioso di aver individuato, in personaggi come Bezos, Zuckerberg, Thiel, Page e Brin i nostri principali “mostri”. Mi sembra che oggi molti si stiano finalmente rendendo conto della realtà. Ne ho parlato negli articoli che ho scritto, quindi mi sento sereno e coerente. Quando poi ho trasformato quegli articoli virtuali nel libro Il suono della rabbia, la mia più grande paura era rileggere cose che sarebbero potute essere ormai superate, visioni fuori tempo massimo. Invece, con mia soddisfazione personale e intellettuale, era tutto ancora attuale.
Cosa ti dava tanta sicurezza anni fa sui rischi di cui prendiamo coscienza oggi?
Un libro che mi ha davvero aperto la mente, e che ho citato più volte: Il capitalismo della sorveglianza di Shoshana Zuboff. L’ho letto quando è uscito. Già avevo sviluppato molte mie intuizioni, ma quel libro me le ha confermate, inquadrate, rafforzate. E grazie a questa rilettura dei miei scritti passati, ho capito una cosa importante: posso fidarmi delle mie sensazioni perché spesso ci vedono giusto.

Foto press
Quando un giovane ti dice «voglio fare il musicista», tendi a metterlo in guardia sulle difficoltà, oppure lo incentivi a provarci?
Sono piuttosto diretto nel dirgli come stanno le cose. Cioè che avrà pochissime chance di costruire una carriera che gli permetta di viverci. Ma aggiungo anche, con molta sincerità, che l’esperienza di gruppo, principalmente, è formativa di per sé. Coltivare un percorso artistico con le premure necessarie per fare le cose al meglio è formativo. E oggi è già molto, perché questa cura del dettaglio non è più nell’ordine di idee di chi approccia la musica con il computer. Cercherei di fargli capire anche che quell’esperienza ti fa diventare una persona migliore. È chiaro che non si tratta solo di una pacca sulla spalla. Io gli spiego chiaramente che portare avanti un percorso artistico proprio, con serietà, sacrificando magari il divertimento del venerdì sera per andare alle prove, ti rende un essere umano più completo. Ma non risparmierei di aggiungere che, oggi, le possibilità di farcela sono molto poche.
Lucio Corsi, visto il percorso e l’esplosione attuale, è un esempio positivo?
È l’eccezione che conferma la regola. Lucio ha alle spalle un percorso già consolidato. Ha fatto la cosiddetta gavetta, le cantine, se vogliamo usare un termine fuori moda. Aveva già una fanbase concreta. Ma quello che mi ha colpito è come si è giocato benissimo una delle occasioni della vita. A Sanremo sbagliare è facilissimo, per mille motivi. Anche solo perché arrivi con la canzone sbagliata. Ma qual è la canzone giusta? Io non lo saprei mai dire con certezza. Eppure lui è arrivato con quel pezzo, e con un modo di stare sul palco incredibile. Si è preso il suo tempo, in un contesto così enorme e con quella pressione addosso. L’ho ammirato tantissimo. Ho pensato: «Cazzo, quella è una roba da fighi».
Tornando all’importanza di una band, si è sempre fatto affiancare dal chitarrista e autore, oltre che amico, Tommaso Ottomano.
E ha fatto benissimo. Salire da soli su quel palco è da stomaci forti.
Una curiosità, ma della trap di questi anni c’è qualcosa che ti ha colpito?
Mi sono imbattuto in qualcosa che mi può essere piaciuto, ma non ricordo nulla in particolare. Cerco di stare dietro alla musica, solo che ormai è impossibile, e non ci riuscite neanche più voi giornalisti. È un accumulo continuo di informazioni che, sarà anche l’età, svaniscono in fretta. Non memorizzo nomi, titoli, volti. Anche il rap, quando è figo, mi piace un sacco. Soprattutto certe cose che arrivano dall’America. Lì sono davvero fortissimi. Io ero un superfan dei Public Enemy, quando esplosero. La prima ondata mi ha segnato.
Prima di salutarci, prendendo spunto dal tuo disco, chi vorresti accanto oggi?
Vorrei stare accanto a tutte le persone che sanno trovare, da qualche parte, la speranza. E vorrei che anche loro volessero me accanto. Una comunità di persone consapevoli, che provano a tenere viva la proattività e la resistenza. Che evitano quell’effetto di fagocitamento di cui abbiamo parlato prima. Ecco, io vorrei stare accanto a questa comunità che lotta.