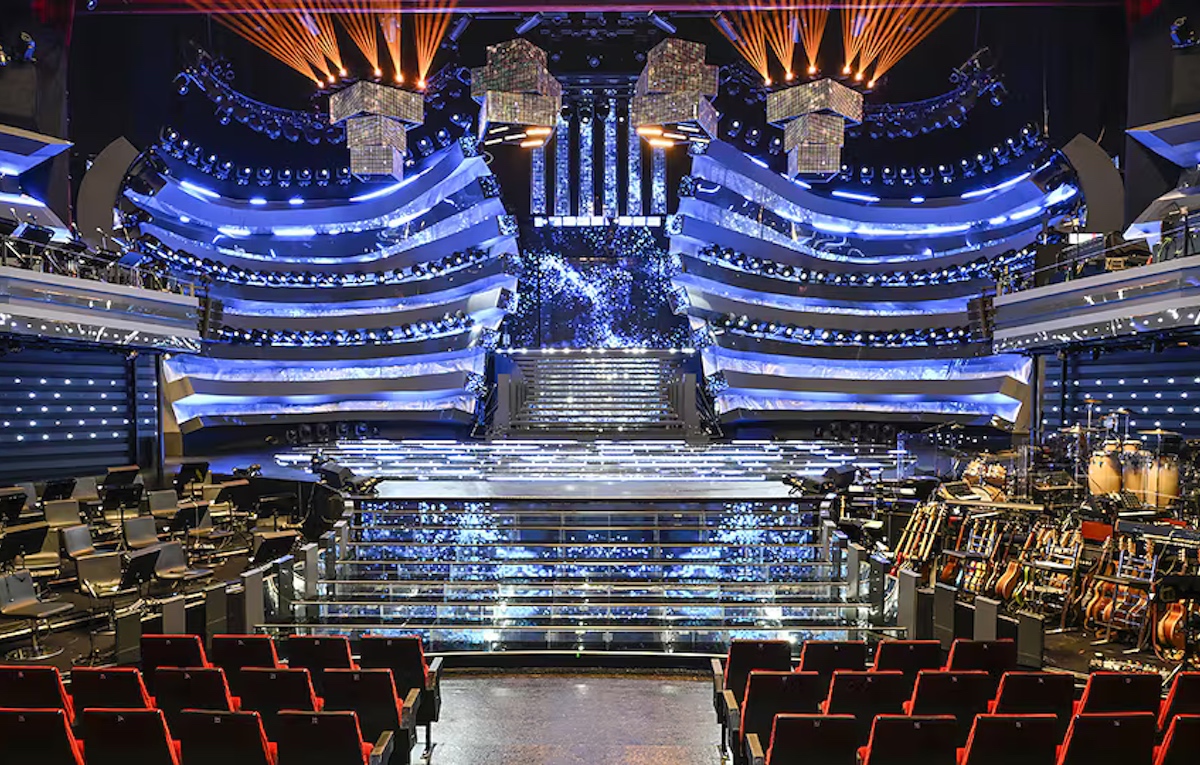Jake La Furia ed Emis Killa non appartengono alla stessa generazione (il primo è nato nel 1979, il secondo dieci anni dopo, nel 1989), ma senz’altro appartengono alla stessa cultura e mentalità: quella del rap in cui ogni parola vola come una farfalla e punge come un’ape, per mutuare una famosa citazione di Muhammad Ali. Testi ad alto contenuto di citazioni iconiche, barre intricate, valori solidi, tematiche importanti; nonostante la potenza e la densità, però, ogni loro strofa è leggera e agile come un peso piuma che danza sul ring cercando di schivare il gancio dell’avversario.
Il primo ha fatto la storia con i Club Dogo conquistando trasversalmente l’underground e il mainstream, il secondo è riuscito a sfondare il soffitto di cristallo e ad arrivare al grande pubblico del pop pur senza avere mai abbassato la qualità delle sue rime. Il rapporto di fratellanza che li lega è noto a tutti, testimoniato anche dal fatto che entrambi si sono fatti tatuare il numero 17, che ritengono particolarmente fortunato, sotto l’occhio sinistro. Nessuna sorpresa, quindi, che a un certo punto della loro carriera abbiano deciso di pubblicare un album insieme, e l’abbiano intitolato proprio 17.
«Sarebbe dovuto uscire il 17 aprile, ma eravamo in pieno lockdown e nessuno sapeva a cosa saremmo andati incontro, quindi abbiamo deciso di rimandare», racconta Jake. E oggi, 18 settembre, l’album è finalmente fuori, anche se purtroppo la situazione è tutt’altro che risolta: «È un periodo in cui tutto può cambiare da un momento all’altro, ma vorremmo tornare a fare degli instore e dei live e a incontrare la gente. Ovviamente le modalità saranno diverse, ma è ora di ripartire, anche se in modo attento: pian piano spero che ci riusciremo», aggiunge. Nonostante le contingenze le aspettative erano molto alte, e a ragione: l’unica cosa forse veramente discutibile del disco è la copertina, in cui i nostri eroi, in groppa a due fidi destrieri e rivestiti di pellicce, gioielli e occhiali da sole, si stagliano come cavalieri della post apocalisse sullo sfondo di una metropoli distrutta, con tanto di fungo atomico che esplode in lontananza.
Come cacchio vi è venuta in mente un’immagine del genere?
Jake La Furia: Beh, il disco doveva intitolarsi 17 prima ancora che il 2020 si rivelasse uno dei peggiori anni dalle origini della Terra ad oggi, e considerando che è un numero che tradizionalmente porta sfiga, l’idea era quella di essere scaramantici e di cavalcare l’idea di una possibile catastrofe da Armageddon. Dopodiché la catastrofe è avvenuta davvero (scoppiano a ridere entrambi, nda).
Emis Killa: A un certo punto, in una riunione, era saltata perfino fuori la proposta di chiamare l’album Covid-17.
Jake: Cazzo, questa me l’ero persa. Peccato, perché altrimenti avrei detto di sì!
Emis: Scherzi a parte, siamo due persone che non amano prendersi troppo sul serio e non si fanno grandi problemi su quello che la gente pensa di loro: una copertina così, in un periodo di pandemia mondiale, magari ad alcuni potrà sembrare di cattivo gusto, ma a noi piaceva, perciò alla fine l’abbiamo tenuta.
Avete molte altre cose in comune, oltre a queste, tant’è che siete amici da anni: come mai avete aspettato così tanto a fare un album insieme?
Emis: Finalmente è capitato un momento in cui eravamo entrambi liberi da impegni personali e musicali, e avevamo il tempo di dedicarci a questo progetto.
Jake: Ci pensavamo da tanto. Però, se devo dire la verità, io avrei voluto smettere con il rap: non me ne fregava più un cazzo, avevo in mente di mollare e fare tutt’altro. C’è voluto un amico come Emis, di cui ho anche grande stima artisticamente parlando, per farmi tornare la voglia. E credo che si senta, che è un disco fatto per scelta e non per obbligo. Lo dico nonostante sia io che lui abbiamo quella fastidiosissima sindrome per cui quando ci riascoltiamo, ci facciamo sempre cagare.
Emis: Sembra una cosa molto comune, ma in realtà là fuori è pieno di gente che si esalta a riascoltare i propri pezzi: sono quelli che poi postano sui social i video in cui ballano da soli in studio con la loro musica in sottofondo…
Jake: E ti dirò di più: a giudicare da quello che si sente in giro, c’è anche parecchia gente che non si riascolta proprio, altrimenti certi pezzi non li farebbero proprio uscire!
A proposito, fin da quando avete annunciato l’album avete sottolineato il fatto che sarebbe stato un disco rap al 100%, senza compromessi o derive troppo commerciali: «Se vi aspettate di ballare sbagliate, vi faremo sentire l’odore del sangue», avete scritto sui social. Da dove deriva quest’esigenza di tornare alle origini?
Emis: Sia io che Jake avevamo abbandonato il mondo del rap underground già da un po’, e ci eravamo cimentati in una carriera mainstream, con singoli più pop che sono andati molto bene anche in radio. Uscire con un disco rap crudo e vero è molto più difficile, lo sapevamo già: non tutti lo capiscono, sul mercato funziona meno, e soprattutto è una bella rogna, perché sembra quasi che ogni volta tu debba rispiegare da capo alla gente cos’è il rap, come funziona e perché ha certe caratteristiche. Sinceramente, se non l’avessi fatto con lui, non credo che sarei uscito con un album così da solo. Ma da un nostro progetto insieme i fan si aspettavano esattamente questo, anche se sicuramente là fuori era pieno di scettici che pensavano avremmo sfornato 17 tracce su beat reggaeton. Volevamo ricordare, in un periodo in cui tutto è un grande circo e sembra che valga qualsiasi cosa, che il rap è questo, e che noi due siamo nelle condizioni e nella posizione di poterlo fare.
Il primo singolo estratto, Malandrino, gioca molto sul concetto di strada, anche con una certa ironia di fondo.
Jake: È una celebrazione di un sottobosco in cui entrambi ci muoviamo da anni: il nostro pubblico e la nostra gente appartengono a quel mondo. Non volevamo metterci a fare le pulci a chi lo è davvero e chi millanta, però: ormai, come diceva Emis, là fuori è un grande circo. Non necessariamente nell’accezione negativa del termine, sia chiaro: il punto è che l’immaginario del rap di strada ormai è talmente sdoganato ovunque che è diventato intrattenimento, e molti ragazzini si limitano a rifare ciò che vedono. Non credo che neanche Trippie Redd, indipendentemente da quello che dice nei suoi pezzi, la sera esca portandosi appresso il mitragliatore, per intenderci… Esistono anche persone che raccontano ciò che hanno visto davvero, che vengono realmente da una situazione pericolosa, ma tutto il resto è puro cinema, e non credo vada colpevolizzato. I video e i pezzi con quell’immaginario lì esistono da anni ovunque, ed è normale che sia così.
Emis: Esatto, non era una presa per il culo, anche perché di quello che fanno gli altri non ce ne fotte un cazzo. Se avessimo voluto prendercela con chi fa il finto gangster saremmo stati molto più espliciti e diretti.
Una traccia come No Insta, però, sembra un riferimento proprio a quel tipo di atteggiamento da finti gangster. Rime come “Più finti di SmackDown / Fra, non sono io a parlare di strada / è il mio background”, o “Da bambino sono stato solo in strada, non su Insta” sembrano dirla lunga…
Jake: In quel pezzo asseriamo che è meglio essere veri che parrucconi, con un ovvio riferimento al mondo dei social. Noi siamo gli stessi sia nella vita reale che su Instagram; anzi, forse nella vita reale siamo pure peggio!
Emis: Parlo per entrambi: quando facciamo un pezzo parlando di certe realtà non ci sentiamo a disagio o in difetto, perché tutti quelli che ci conoscono sanno da dove veniamo e che abbiamo le credenziali per raccontare ciò che raccontiamo.
Ci sono anche brani di puro storytelling, come René e Francis, in cui vi calate nei panni di due leggendari banditi come Renato Vallanzasca e Francis Turatello. Come vi è venuta l’idea, e perché avete deciso di svilupparla su un beat così contemporaneo e tamarro, anziché su qualcosa che richiamasse alle atmosfere degli anni ’70?
Emis: In realtà, al di là della cassa dritta, a me il giro di quel beat ricorda un sacco i film poliziotteschi di quegli anni. Inizialmente quel pezzo doveva essere solo su Vallanzasca, ma poi abbiamo pensato che, visto che siamo in due, fosse più originale riprendere le storie di due esponenti storici della mala milanese. Traslando il discorso in ambito rap, io e Jake abbiamo lo stesso rapporto che avevano René e Francis. E anche se si tratta di personaggi che sono entrati nel mito ormai cinquant’anni fa, siamo sicuri che anche i nostri fan più giovani capiranno il riferimento: è impossibile non rimanere affascinati dalla loro storia, se ti piace un certo immaginario.
Un altro brano che fa riferimento a un cult del passato è Amore tossico, citazione dell’omonimo film del 1983. Gioca molto sui doppi sensi, ed è difficile capire se si sta parlando dell’amore per una donna o per la droga…
Jake: Tutte le strofe sono mie: anche in questo caso potrebbe trattarsi di uno storytelling, ma è un pezzo molto personale che parla di dipendenza in senso lato, diciamo così. La cosa davvero importante per me, però, è che contiene un campione di un pezzo bellissimo di Edda dei Ritmo Tribale, Io e te, che parla del suo rapporto con l’eroina. L’ha pubblicata dopo essere sparito dalle scene per dodici anni, ed è una canzone molto significativa.

Tornando alla vostra vita personale, tutti e due avete dei figli piccoli: nel disco dite orgogliosamente che portate voi stessi i bambini all’asilo. Come vivete la dicotomia tra la figura del rapper che affronta tematiche e situazioni vietate ai minori di 18, e la vostra quotidianità da papà?
Emis: Credo che i figli crescano con l’idea del genitore che hanno in casa, e non dell’immagine pubblica: anche mio padre era un personaggio abbastanza squilibrato – era un musicista anche lui – ma l’ho scoperto tardi, quando ero adulto e non me ne fregava più niente di quello che faceva fuori. La cosa essenziale, per me, è che è stato un buon padre e ho capito sulla mia pelle che è l’unica cosa che conta. Per spiegare chi sei e cosa fai c’è sempre tempo, ma secondo me non ce n’è neanche bisogno: diventa la loro normalità in maniera molto naturale, capiscono da soli che un conto è la persona e un altro è la carriera.
Jake: Il problema di spiegare ai nostri figli cosa facciamo nella vita si paleserà tra un po’, perché ora sono molto piccoli. Da sempre la vita dell’artista, e soprattutto quella del rapper, si basa sul dualismo tra la regolarità e la sregolatezza. Nel mio caso, e credo anche in quello di Emis, io non sono più quello che ero a vent’anni: ai tempi ero davvero una specie di Bestia di Satana, adesso sono molto diverso. Quando diciamo “Io non sono un G, porto i bimbi all’asilo / ma i miei tirano ferri tipo calamite” è una metafora per dire che la nostra vita è cambiata, ma abbiamo ancora un piede dentro al mondo a cui appartenevamo.
Restando in tema di metafore e figure retoriche, in Quello che non ho, la traccia finale, Emis dice: “Volevo essere onnipotente come un dio / per poi scoprire che anche dio è niente / di fronte a un non credente”. Un tempo quasi ogni brano rap davvero significativo conteneva dei versi iconici, che rimanevano nell’immaginario come aforismi e facevano riflettere: oggi sembra quasi un’eccezione. Come mai, secondo voi?
Emis: Di recente ho ascoltato un disco di rap italiano appena uscito e mi sono reso conto che ormai è cambiato tutto: non esiste più il messaggio. Lo dico sempre e lo ripeto, quando parlo di “messaggio” non mi riferisco necessariamente a un messaggio importante: quello che intendo dire è che le parole e le rime non sono più centrali, nel concetto stesso di rap. È diventata più una questione di attitudine, di voce, di slogan tipo “Gucci”, “cash”, “eskere”… Io sono sempre stato un fanatico delle parole, e quella sensazione di esaltazione che hai quando ascolti delle barre ben riuscite ce l’ho anche quando leggo un libro, o ascolto il dialogo di un film. Ma mi rendo conto che per le nuove generazioni non è la stessa cosa. Forse anche perché, se a differenza nostra non provano quello stesso brivido a cui accennavo prima, è difficile che abbiano voglia di farlo provare a qualcun altro.
Nelle ultime settimane il rap contemporaneo, il suo linguaggio e suo immaginario sono stati accusati di diffondere una cultura tossica anche a causa di alcuni fatti di cronaca, come l’omicidio di Willy Monteiro Duarte da parte di alcuni energumeni iper-machisti. Cosa rispondereste a chi è convinto di questo?
Jake: Ovviamente non esiste una risposta universale per tutto ciò. Per come la vediamo noi, però, negli ultimi 200 anni la reazione dell’umanità di fronte ai suoi mostri è sempre stata quella di cercare un colpevole oltre al colpevole. Un tempo la musica della violenza e della droga era il rock’n’roll, oppure era la cultura del tatuaggio a essere accusata di traviare la gioventù. Purtroppo non è così semplice. Anche perché, se fosse colpa del rap, tutti i milioni di ascoltatori del genere si scannerebbero indistintamente a vicenda, ma i fatti e i numeri ci dicono che non è vero. Quella di Willy, come tanti altri episodi, è stata una vicenda orrenda, ma la colpa è solo e soltanto della testa bacata di chi ha commesso quel crimine. Non è la cultura del rap, o del tatuaggio, o delle arti marziali, o delle serie tv tipo Gomorra ad aver causato quell’omicidio: è piuttosto la mancanza di cultura, o peggio ancora, la cultura delle botte. Se quei tizi avessero speso del tempo a guardare dei film, a leggere dei libri, ad ascoltare della musica, probabilmente avrebbero avuto altro a cui pensare, anziché andare in giro a massacrare la gente.