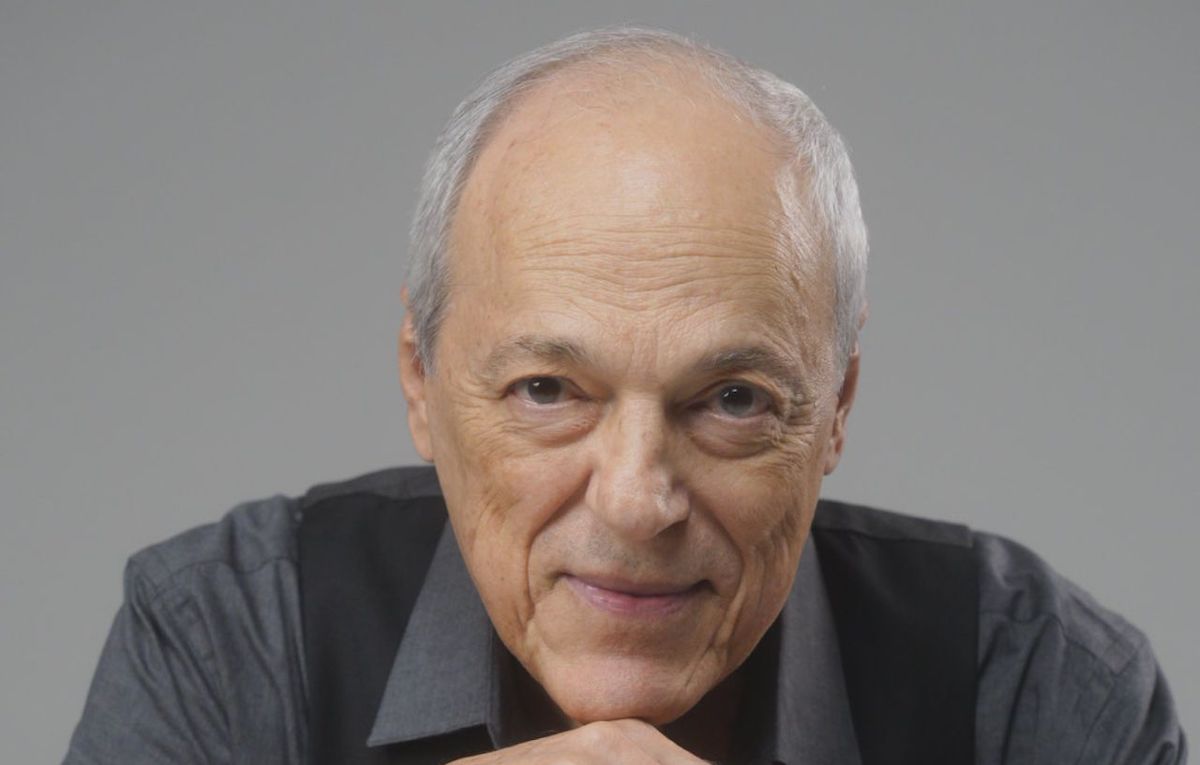Gli stereotipi sono sempre un’arma a doppio taglio, ma quello che vuole i canadesi essere gentili in modo quasi eccessivo mi è stato confermato dalla chiacchierata che ho avuto l’occasione di fare con Chester Hansen, bassista dei Badbadnotgood. La band proveniente da Toronto torna con un nuovo album, Talk Memory, cinque anni dopo l’ultima prova in studio. Un ritorno al futuro, a quell’essenza da jam band propria del loro inizi, affinatasi poi nella scoperta di un grande intuito come produttori di vere e proprie canzoni – per se stessi e per i loro innumerevoli collaboratori. Un album forse meno debitore all’hip hop e molto di più ai classici del rock e del jazz. La musica del disco suona effettivamente un po’ come un nuovo inizio. Si sente la gioia del suonare insieme, il divertimento; un modo intelligente di procedere, ripartire in questo modo, tornando alle origini e semplicemente al puro divertimento.
Il loro lavoro in studio del 2016, IV, è stato celebrato in tutto il mondo, seguito da un tour estenuante durato circa tre anni. Nel frattempo tanti sconvolgimenti, positivi e meno. Il tastierista e membro fondatore Matthew Tavares si è ritirato quasi subito dal tour, e poi qualche tempo dopo definitivamente dalla band, che nel frattempo ha accolto al suo interno in pianta stabile il sassofonista Leland Whitty. In questi anni il loro jazz-hop a tinte soul quasi psichedeliche è stato usato negli eventi e nelle produzioni musicali più importanti del pianeta: dalle sfilate Louis Vuitton ai campionamenti nei dischi di Kendrick Lamar. La lista delle collaborazioni si è poi sempre più andata ad infoltire di nomi illustri; ad oggi include Kali Uchis, Tyler The Creator, Daniel Caesar, Ghostface Killah (con il quale hanno realizzato un vero e proprio album), Kaytranada, Mick Jenkins, Khalid, Little Simz, Khalid, Denzel Curry. In questo nuovo album aggiungono alla collezione degli strumentisti eccezionali, uno su tutti la leggenda brasiliana Arthur Verocai.
Si potrebbe continuare a lungo, a dimostrare che il suono di questi ragazzi canadesi dalla faccia pulita (e dei numerosi discepoli raccolti in quesi anni in tutto il mondo) è diventato quasi egemonico per un certo modo di intendere le produzioni contemporanee di ogni tipo, sempre più incapaci di rinunciare a un elemento jazzy nel loro mix. Con Chester siamo tornati alle origini della band, delle modalità di registrazione, abbiamo parlato di collaborazioni, di momenti difficili e dell’emotività di questi ultimi due pazzi anni.
Parto dicendoti che ascoltando il nuovo album, la prima impressione che se ne trae è che
probabilmente vi siete divertiti un mondo nel registrarlo.
Sì, hai ragione. Era da un po’ che non registravamo insieme una discreta quantità di materiale,
avevamo prodotto o registrato singole canzoni spesso per altre persone ma era passato qualche
anno dal nostro ultimo album. Il posto in cui abbiamo registrato inoltre è bellissimo e super di ispirazione.
Dove avete registrato?
È uno studio a Los Angeles che era aperto già negli anni ’60 e che poi dagli anni ’80 fino ai primi 2000 è rimasto inutilizzato. Solo che nel tempo nessuno ha toccato nulla, nessuno lo ha rinnovato, quindi oggi è rimasto come era allora, quarantanni fa. È stato un posto veramente incredibile in cui registrare. Eravamo veramente eccitati all’idea di ritrovarci: stavamo fondamentale cercando di fare qualcosa di nuovo in primis per noi stessi, di nuovo tutti assieme.
Pensi che registrare lì abbia svolto un ruolo importante per la musica del disco? Ci tornerete?
Ci piacerebbe molto. Un altro fattore importante è stato l’ingegnere che lavora lì, si chiama Nic. Veramente geniale, il suo approccio ci ha aiutato molto, aiutandoci a non pensare troppo ai dettagli insignificanti ma continuare semplicemente a suonare. Registriamo la nostra performance migliore invece di preoccuparci di sistemare venti microfoni diversi per la batteria. Potremmo dire che è stato un approccio old school, molto piacevole. Poi appunto l’energia del luogo, che come dicevo non è cambiato di una virgola dagli anni ’70. Puoi fare ottima musica ovunque ma per noi come band i luoghi in cui stiamo sono importanti.
Leggendo il comunicato stampa, è specificato con forza che siete “tornati alle origini”. In che senso? Quali sono ad oggi, dopo tutti questi anni di esperienze diverse, quelle che identificate come vostre radici?
Ci siamo incontrati a una scuola di jazz, e il nostro legame è nato dal mutuo interesse per jazz ed hip hop. In questo senso l’ultimo album ha al suo interno più improvvisazione rispetto all’ultimo. Ma penso anche che la musica di Talk Memory vada ancora più indietro nel tempo, alle radici di ciascuno di noi prima che ci incontrassimo. Quando suonavamo da bambini più che altro facevamo rock; prima di registrare l’album abbiamo ascoltato molta roba sullo stile della Mahavishnu Orchestra, penso che diverse canzoni siano influenzate da quell’approccio. Poi c’è più roba in stile quasi free jazz. E poi abbiamo portato tutto a un livello più alto grazie agli splendidi arrangiamenti di Arthur Verocai e gli altri fantastici collaboratori che abbiamo avuto sul disco. Quindi sì, allo stesso tempo è un ritorno alle radici e un andarsene da qualche altra parte (ride).
Hai citato una sorta di sensibilità rock, mettiamola così, come parte delle vostre influenze più primitive. Alla luce di questo capisco meglio perché spesso si faccia riferimento alla vostra musica con l’appellativo di progressive jazz. Tu di questo neologismo e in generale di questi tentativi linguistici di sintesi musicale che ne pensi?
Sono difficili. Ognuno ha le sue idee su cosa è o cosa non è un certo genere musicale, o cosa dovrebbe essere. Io ho sempre pensato che siamo una band influenzata dal jazz ma non completamente una jazz band, non so se ha senso. Perché alla fine ci piacciono così tante cose diverse: quando scrivo sono ugualmente ispirato da colonne sonore, musica psichedelica, classic rock, musica brasiliana, così come dal jazz. Però sì, progressive jazz suona fico, non saprei come altro chiamarlo (ride).
Poco tempo fa ho chiacchierato con Emma Jean Thackray. Mi è venuta in mente perché i vostri album sono accomunati da un feeling molto analogico, quasi anni ’70. In generale hai familiarità con la scena nu jazz inglese? Penso che il vostro mondo musicale sia molto assimilabile al loro, anzi che voi stessi abbiate un po’ spianato la strada negli ultimi anni per questo tipo di approccio.
Sì, conosco abbastanza quella scena. In generale trovo difficile rimanere al passo con la musica nuova, ce n’è veramente troppa che esce di continuo, ma è un po’ di anni che le persone ci parlano di quello che accade a Londra in termini entusiastici. È interessante come siano riusciti a fare una sintesi di generi diversi che funziona molto bene su disco ma probabilmente ancor meglio nei club. È semplicemente molto eccitante. È stato fantastico osservare in questi anni la crescita di diversi artisti in tutto il mondo che non possono essere considerati veramente jazz, ma alla fine fanno parte di quel mondo. A Chicago c’è l’etichetta International Anthem che sta pubblicando delle cose incredibili.
Siete tornati alle atmosfere notturne, da jam, che erano un po’ la vostra cifra stilistica degli inizi. Come mai avete sentito il bisogno di tornarci dopo tutti questi anni e sopratutto le numerose direzioni che ha preso il progetto?
Non so penso che dopo tutto ciò che abbiamo fatto, abbiamo cercato di non pensare troppo. Anche se è divertente perché alla fine ci abbiamo comunque “pensato”, cercando di non farlo. Il nostro obiettivo finale era comunque quello di produrre una buona quantità di musica che scorresse bene insieme; abbiamo scritto la maggior parte dei brani come se fossero il continuo uno dell’altro, un flusso di brani che si mescolano senza fermarsi. Non l’avevamo mai fatto ed è stata una cosa nuova molto fica da provare. Poi ci siamo assicurati che ognuno avesse il suo spazio per improvvisare, che le canzoni fossero la versione migliore di se stesse.
Ho l’impressione che la vostra musica in questi anni, al netto delle tante direzioni diverse prese, sia accumunata sempre da un gusto melodico specifico, un dna che torna in ogni album e collaborazione. È piacevole e funzionale, perché mette a suo agio l’ascoltatore anche se magari vi state prendendo “rischi” in altri modi. È qualcosa di cui siete consci, che ricercate appositamente, viene da qualcosa in particolare?
Le melodie sono fondamentali per noi. Tutta la nostra musica preferita ha un elemento melodico che magari non è per forza catchy, ma sicuramente ti rimane incollato addosso; che riesce a provocare emozioni diverse in diversi ascoltatori. Poi magari gli accordi e i ritmi dietro sono super complicati ma comunque il risultato è una melodia piacevole, che funziona. È un approccio che ricerchiamo specificamente, con intenzione, penso sia ancora più importante oggi per il modo in cui si ascolta e si fa musica.
Cosa hai ascoltato nell’ultimo anno? Sono cambiate le tue abitudini di ascolto, magari anche a causa della pandemia? Ci sono artisti o generi specifici che hanno avuto la meglio?
Gli altri ragazzi sono stati molto attenti alla musica nuova che è uscita. Per quanto mi riguarda, anche solo per il fatto che l’ultimo periodo è stato ovviamente molto deprimente, come tante altre persone sono tornato ai classici, la musica che amo profondamente. Le cose che ti fanno stare bene insomma. Ho ascoltato un sacco di colonne sonore, library music, insomma musica molto tranquilla. E poi appunto, sono tornato anche verso la roba jazz classica, Wayne Shorter, Sam Rivers, Herbie Hancock…
Dato che hanno avuto un chiaro impatto sui tuoi ascolti, pensi che gli ultimi due anni ce l’abbiano avuto anche sul vostro nuovo disco?
La cosa divertente è che lo abbiamo finito di registrare immediatamente prima dell’inizio della pandemia. Ma proprio una questione di giorni. Però sì, in generale penso che ci siano un po’ di quei sentimenti all’interno della musica. Perché stavamo comunque già riflettendo su dei temi abbastanza pesanti, povertà, ineguaglianza, cambiamenti climatici, tutte queste crisi che ci stanno travolgendo. Quindi sì penso che come mood si inserisca comunque in quel contesto, in più tante delle registrazioni le abbiamo finite durante la quarantena.
Siete già tornati dal vivo? Com’è andata?
Abbiamo fatto un piccolissimo live a New York, un paio di settimane fa. È stata la prima cosa dal vivo che abbiamo fatto in due anni, molto divertente, era una sorta di situazione after party in un piccolo bar. È stato molto divertente, piacevole. Noi siamo stati fortunati perché abbiamo comunque continuato a suonare insieme in questi due anni, ma è stato veramente bello sentire di nuovo l’energia delle persone.
Una di quelle domande fastidiose da intervista: di tutte le collaborazioni in cui vi siete imbarcati (e ne avete fatte veramente tantissime), avete una preferita? Sia sotto il punto di vista umano che musicale.
È impossibile sceglierne solo una. Ma sicuramente una delle preferite è stata questa con Verocai. L’ascolto della sua musica è stata una delle influenze più importanti per i nostri ultimi album, forse perché è musica che combina un po’ tutto quello che amiamo. Jazz e improvvisazione ma anche elementi psichedelici e ovviamente musica tradizionale brasiliana. Musica fantastica ma anche una persona fantastica da avere intorno, ha quasi 80 anni ma è estremamente attivo: compone tutto il tempo, lavora con band nuove – oltre a noi ha appena collaborato anche con gli Hiatus Kaiyote.
Rimanendo su questo tema invece c’è qualcuno con cui invece, desiderereste moltissimo farlo, ma non avete ancora avuto modo di collaborare?
Sì certo. Volevamo che questo album fosse strumentale ma abbiamo sempre amato lavorare con cantanti e rapper, sicuramente torneremo a farlo anche di più. Un brano con Kendrick Lamar sarebbe incredibile, probabilmente è al primo posto della lista dei desideri. Lui ha campionato uno dei nostri brani (Time Moves Slow per la sua Lust, nda), ma fare un vero brano in collaborazione sarebbe pazzesco. Quest’album in uscita è molto speciale perché abbiamo lavorato con tanti strumentisti e continuare anche su questa strada sarebbe fico, magari proprio qualcuno della scena jazz londinese che dicevamo prima.
C’è mai stato un momento durante tutti questi anni così intensi in cui avete pensato che il tempo dei Badbadnotgood fosse passato? Che il progetto avesse dato tutto, sia musicalmente parlando che umanamente a voi.
È un’ottima domanda. Sì, abbastanza. Dopo IV siamo andati in tour praticamente per tre anni di fila. È stato fantastico sotto un sacco di punti di vista, ma anche estenuante per tutti. In più al tempo non stavamo lavorando a nuova musica, ci limitavamo a viaggiare e suonare i brani dell’ultimo album. Poi Matthew non era in tour con noi al tempo e qualche anno fa ha lasciato la band per perseguire la sua carriera personale. Quello, insieme al periodo in generale, è stato un momento grosso per me, in cui mi sono dett: «Sono orgoglioso di cosa abbiamo fatto fin qui e se non facciamo un altro disco come Badbadnotgood per me è ok». Ma poi dopo un po’ di tempo, sperimentando con gli altri due ragazzi abbiamo raggiunto un punto in cui ci sembrava aver senso continuare e vedere cosa sarebbe uscito fuori. Siamo tutti cresciuti dentro la band, è iniziata quando io avevo 19 anni e oggi ne ho 29. È stato un viaggio lungo, sicuramente con momenti in cui abbiamo sentito che non avevamo nient’altro da dire. Ma penso che lavorando a quest’album siamo tornati ad apprezzare il processo, è stato veramente bello. Vediamo cosa succede una volta che torneremo anche dal vivo.