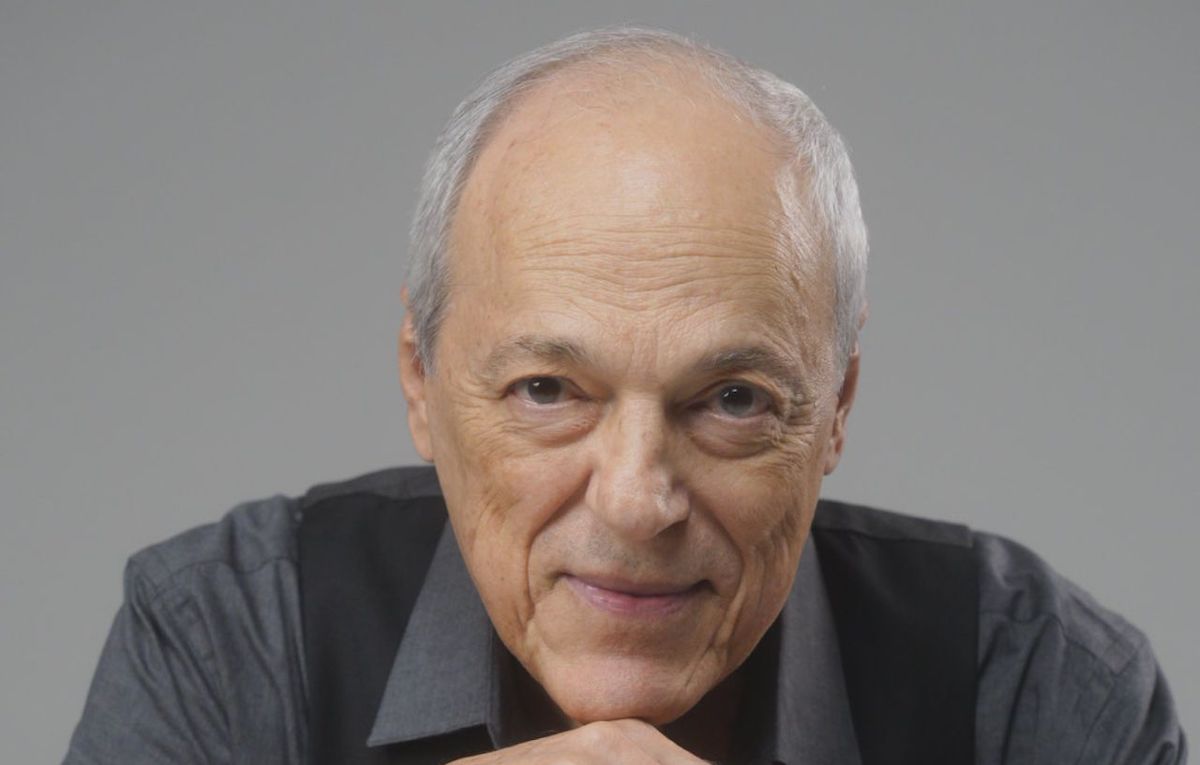Nei primi minuti di intervista io e Leon Faun ci perdiamo a parlare di film horror, una delle passioni che abbiamo in comune (l’altra l’abbiamo scoperta a pochi minuti dalla fine dell’intervista). Lui a 8 anni ha visto per la prima volta «quello che ad oggi è ancora il mio film preferito, ovvero Un lupo mannaro americano a Londra di John Landis», io alla stessa età approcciavo i miei primi Dario Argento. «Siamo cresciuti bene, dai, alla fine quelli che amano gli horror sono i più normali di tutti». La butta lì prima di raccontarmi com’è stato entrarci da protagonista, in una storia dell’orrore.
Leon Faun, all’anagrafe Leon de la Vallée, ha infatti recitato in Piove, uno dei migliori film italiani degli ultimi anni, uscito nel 2022 per la regia di Paolo Strippoli di cui questo classe 2001, con una faccia che non dispiacerebbe a un Michael Haneke, s’era artisticamente innamorato dall’uscita di quel suo altro gioiellino è A Classic Horror Story. «Piove è un horror atipico, che starebbe benissimo in piedi anche senza gli elementi del genere, perché è la storia di un conflitto famigliare e di anime cariche di rabbia, imprigionate in una Roma che assomiglia a loro: cupa, nervosa, sul punto di esplodere. Mi sono affezionato tantissimo al mio personaggio, Gianluca, che lì in mezzo è uno spiraglio di luce».
Dalla favole dark dei film che ha finora interpretato (il suo primo ruolo lo ha avuto ne La terra dei figli, tratto da una graphic novel di Gipi) ma anche del suo disco precedente, C’era una volta, Leon è passato al racconto intimo e crudo del secondo disco che porta il suo nome e che in 13 tracce racconta probabilmente meglio di qualunque intervista chi sia questo quasi 22enne innamoratosi del rap «grazie a mamma che un giorno m’ha passato un CD, dicendomi: “tiè, lo conosci questo? Era Eminem”». Da lì la folgorazione, «anche perché io ho sempre sognato di fare l’attore, e Eminem con 8 Mile ai miei occhi ha incarnato quello che sarei voluto diventare io: un musicista che fa anche cinema».
Leon in Leon, tuttavia, non si porta dietro echi di quel primo affaccio sul mondo del rap, arrivato dopo «la passione per Jimi Hendrix e per i Queen che mio padre mi faceva ascoltare di continuo», ma si tuffa, proprio come nella cover del disco, in tinozze di colori musicali diversi: ci sono gli accenni di stornello di Ragazzo normale, la cassa dritta di Anima, il pop con la batteria in quattro quarti di Meteorite, la ballad malinconia che è Genova, le chitarre “punkeggianti” di Eterno. Il rap c’è, ma non è tutto: «Ho mega rispetto per il genere, ma non mi sento un rapper al 100%, mi piace rappare ma voglio anche sperimentare altri generi, imparare a cantare meglio, divertirmi a fare musica con Duffy, il mio produttore da sempre e amico fin dall’asilo, e stavolta anche con dei musicisti che hanno impreziosito questo lavoro con una massiccia parte strumentale».
Intitolare il disco con il tuo nome è, quindi, un manifesto di intenti?
Assolutamente, penso sia il mio lavoro più intimo, e per farlo ho impiegato un anno e mezzo buono. Un tempo necessario anche a Duffy e False, i due produttori più presenti in Leon, per unicizzare ogni traccia, per andare in più direzione ma rimanendo coerenti. Duffy in particolare s’è voluto dedicare con cura assoluta a tutto, anche perché è stato parecchio stimolato dal fatto che abbiamo coinvolto musicisti molto forti che hanno arricchito i pezzi con chitarre, bassi, persino con il sax in Arte e libertà… Poi sì, scrivere di sé è una prova complessa, richiede tempo, inventare storie e mondi immaginari è decisamente meno difficile. Ma ho sentito che il momento era giusto per andare molto deep: ho scavato tanto dentro di me e arrivato alla fine del progetto gli ho dato il mio nome perché credo di essere riuscito a creare un riflesso sincero della mia persona.
A proposito di nome, in Funerale mio, uno dei singoli che ha anticipato l’uscita disco, canti: “Metà degli artisti hanno perso idee, hanno perso il lume / Hanno perso la luce, hanno perso il flow / Hanno perso il cuore, hanno perso il nome”.
È semplicemente quello che ho visto succedere, ma non c’è giudizio. Non sono più una persona arrabbiata, oggi, e nemmeno rancorosa, ma mi dispiace quando vedo certe luci offuscarsi o spegnersi.
Tra C’era una volta e Leon sono passati tre anni: cos’è successo in mezzo?
Ho avuto un momento di crisi legato alla pandemia. Il lockdown ha fatto saltare il tour che stavo aspettando con l’entusiasmo a mille, e da che avevo mille cose da fare, mi sono trovato, come tanti, bloccato in quello stallo che non sapevo quanto sarebbe durato. Non l’ho presa benissimo. Per fortuna avevo i progetti cinematografici, che m’hanno salvato da quella fase quasi depressiva, mentre la musica l’ho messa da parte per un po’, a mo’ di protezione rispetto a quella delusione.
Hai pubblicato un reel in cui ironizzi su questa figura mitologica che è il secondo disco, universalmente riconosciuto come il più difficile per ogni artista. Sentivi questa pressione?
Sì. Si insiste molto sul fatto che il secondo album sia allo stesso tempo il più complesso ma anche il più importante per un musicista, e allora ho reagito come faccio spesso di fronte alle paure e alle ansie: scherzandoci su. Con la partecipazione del grande Francesco Pezzulli (attore e doppiatore storico di Leonardo di Caprio, ma anche di James Franco e Jared Leto, nda), che mi ha onorato accettando questa collaborazione, abbiamo voluto usare un linguaggio medico-farmaceutico per raccontare gli effetti collaterali di “questo fenomeno comunemente chiamato secondo disco”.
Quali sono le tue ansie più grandi riguardo al disco?
Mi trovo a pensare parecchio al pubblico che cresce in parallelo a te, ma magari non resta ancorato al tuo progetto, perché l’offerta è tanta, escono sempre nuovi talenti mega interessanti, e la soglia dell’attenzione, in particolare tra i miei coetanei, s’è abbassata mostruosamente, molto spesso non si arriva nemmeno alla fine di un video di un minuto. Lo canto anche che “l’algoritmo ha vinto su ogni poeta”. Lo vivo un po’ come un salto nel vuoto, questo disco.

Foto press
Però il tuo non è solo un pubblico di ragazzini. Nonostante tu sia molto giovane, piaci anche ad artisti più grandi di te, penso per esempio a Caparezza con cui hai condiviso il palco, e che di te ha detto «mi piace perché ha creato una narrativa tutta sua, mi piacciono le persone che si staccano dalla massa».
Quando ti dicevo della bolla depressiva in cui ero finito quando è esploso il Covid, non ti ho detto che ad aiutarmi tanto è stato proprio un messaggio di Caparezza, che m’ha scritto appena siamo finiti tutti in lockdown. Era appena uscita Gaia, io ero molto confuso, spaesato, e il suo messaggio di apprezzamento verso la mia musica m’ha dato molta forza. Sono sono sempre stato super fan dei live di Caparezza, il suo è stato il primo concerto a cui sono andato insieme a papà, e amo tantissimo il suo saper portare un concept da costruire in parallelo alle canzone e basta, una cosa teatrale, uno spettacolo pieno. Per arrivare a quel livello ci vorrà ancora molto, ma l’intento è riuscire, un giorno, a creare quella cosa. Capa rimarrà sempre un mio maestro, e anche la frase “il secondo album è sempre il più difficile” è una citazione che ho preso da Il secondo secondo me.
C’è una cosa che colpisce tanto di questo disco, e cioè l’assenza di featuring che ormai sembrano obbligatori. Come mai ha scelto di andare da solo?
Mentre lavoravo al disco m’è venuta qualche idea per un paio di featuring, anche perché è una cosa che mi piace fare. Andare in studio con altri artisti, anche solo per delle session senza che ci sia un pezzo da far uscire, cercare quella contaminazione, quello scambio, è molto bello. In C’era una volta avevo collaborato felicemente con Madame, Ernia e Dani Faiv, tutti e tre perfetti per i pezzi che avevo proposto. Ma quello era un progetto diverso. Questo è un disco così personale che avrebbe avuto poco senso far cantare anche ad altri. Ho pensato fosse giusto così e me ne frego altamente dei numeri o delle logiche di mercato: avevo proprio bisogno che uscisse così com’è uscito, e ne vado fiero. Però in futuro tornerò assolutamente alle collaborazioni, la scena è piena di nuovi talenti che portano nuovi stili, con tanto potenziale, e per me questo è mega stimolante.
Vuoi farmi un paio di nomi?
Tra i miei preferiti c’è sicuramente Kid Yugi, che ha una penna incredibile. E poi amo Tutti Fenomeni.
Un’altra cosa che abbiamo in comune dopo gli horror.
Lui è il sommo.
Qualche giorno fa Danno dei Colle der Fomento mi raccontava di come a Roma la musica nasca spesso dalle crew, dalle comitive: tu hai mai fatto parte di questo microcosmo?
No, non è la mia storia. Il mio progetto l’ho portato quasi unicamente con Duffy, che è uno dei miei migliori amici e una delle persone con cui lavoro di più, proprio perché è una delle persone che mi conosce di più. Quando eravamo più piccolini, abbiamo fatto cose con thasup, che è di Fiumicino come noi, ma eravamo comunque solo in tre, e non ci siamo manco dati un nome da collettivo. È vero, come dice Danno, che Roma vive molto di crew, e appunto per questo già solo il fatto di venire da appena fuori non ti permettere di avere dei link forti con la città. L’unica situazione che ho mezzo vissuto, che ho, diciamo, annusato, è stata quella dell’Ara Pacis: quando si saltava scuola, ci si trovava lì per fare freestyle o ascoltare la musica degli altri. Ci bazzicava anche Lil Kvneki, per dire. Ma succedeva ogni tanto, non era un mio riferimento.
Chi o cosa è stato il tuo riferimento, nel voler diventare musicista?
La mia famiglia. Sono figlio d’arte, i miei genitori sono stati entrambi attori, principalmente di teatro, mio padre suonava chitarra, pianoforte, cantava sempre. La musica all’interno della mia famiglia è sempre stata presente, e la mia formazione “classica”, da Jimi Hendrix ai Beatles, la devo tutta a mio padre, ai dischi che ascoltava quando ancora ero bambino. Mio papà iniziò anche a farmi studiare batteria. Il rap invece è arrivato più tardi, intorno agli 11 anni, quando un giorno mia madre mi chiese: «Leon, lo conosci Eminem?». Le risposi di noi, e allora mi mise un mano un CD, dicendomi «tiè, sentite sto artista».
Folgorazione?
Sì, erano cinque anni che suonavo la batteria, e quando grazie a quel disco ho scoperto che potevo fare la stessa cosa con la bocca ed essere addirittura frontman del mio progetto, sono impazzito. Poi avendo da sempre questa voglia di unire cinema e musica, vedendo Eminem che era riuscito a farlo con 8 Mile, sono impazzito il doppio.
All’inizio della nostra chiacchierata hai accennato al fatto che in Leon hai deciso di coinvolgere dei musicisti: te li porterai anche nelle date del 10 maggio a Roma e 12 a Milano?
Sì. È un disco che si presa ad avere la band sul palco, che dà una carica diversa, una visione diversa. Non vediamo l’ora di buttarci sulle prove. Perché uno lavora due anni a un disco difficile, molto personale, scava dentro di sé con la fatica che comporta, ma quando poi sente le persone cantare all’unisono le stesse cose contro le quali ha lottato, lì si capisce che ne è valsa la pena.
Ti faccio un’ultima domanda: nei commenti sotto al video di Funerale mio in tanti ti scrivono che sei un artista troppo sottovalutato. Tu ti senti sottovalutato?
Mi fa piacere che lo scrivano, lo prendo come un complimento scritto con affetto. Se mi ci sento? Mah, forse sono stato sfigato coi tempi d’uscita, perché, come ti dicevo prima, il Covid ma un po’ tagliato le gambe. Però no, non penso di essere stato sottovalutato, non è proprio una cosa a cui abbia mai pensato. Quello di di cui sono contento, invece, è che sono uno che non ha hater, che è in pace con gli altri e se parla di qualche collega lo fa per parlarne bene.