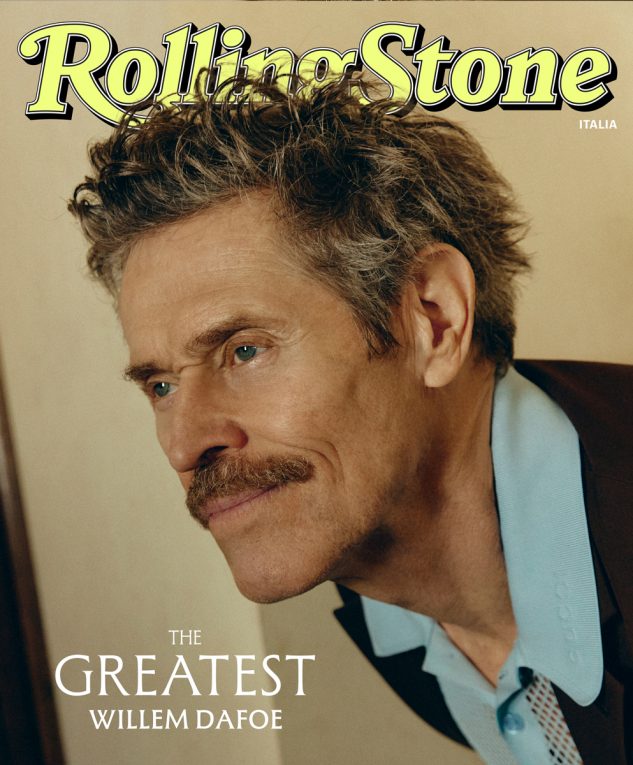È arrivato sulla scena nel 2016, aveva 19 anni e una gran voglia di piantare la bandiera della generazione Z nel suolo dell’hip hop. I tradizionalisti hanno subito bollato Lil Yachty come mumble rapper: per loro era un parvenu, un insulto all’essenza stessa dell’hip hop. La cosa non l’ha certo fermato. Mentre altri restavano al palo, insistendo su formule ormai obsolete, lui ha continuato a provare cose nuove. «Chi se ne frega», dice ora. «O la va o la spacca. Hai solo una vita, fratello. Devi fare cose».
La sua ultima scommessa è Let’s Start Here, un disco di rock psichedelico in cui è cantante d’una band assemblata con alcuni amici (dentro ci troviamo grossi nomi del mondo indie come Alex G, Mac DeMarco e uno dei tipi degli MGMT, oltre a Sadpony e Patrick Wimberly in veste di produttori esecutivi). Al telefono con Rolling, Yachty (che ora ha 25 anni) non rivela granché della genesi dell’album. Preferisce mantenere un alone di mistero. Col senno di poi, non rimpiange d’essere stato tanto aperto a inizio carriera: oggi vuole essere più riservato. «Ero giovane, non sapevo nulla».
Condivide però alcuni dettagli sul processo di registrazione durato sei mesi tra Texas, New York e altrove, che secondo lui è stato «divertente». Ha fatto ascoltare il work in progress a «pezzi grossi» come Kendrick Lamar, J. Cole, A$AP Rocky, Drake e Tyler, the Creator. «Erano tutti estasiati», dice, «e la cosa m’ha fatto sentire bene».
L’anno scorso hai detto che il titolo Let’s Start Here è un po’ il manifesto della seconda parte della tua carriera. Come definiresti la prima?
Stavo imparando divertendomi. Ero giovanissimo e stavo cercando di capire quale fosse il mio posto, il mio scopo e come funzionano le cose. È stato un bell’inizio: cercavo di imparare e intanto di godermi la vita.
Credi che l’hip hop debba essere più aperto verso i debuttanti e gli emergenti che devono crescere?
Non lo so e neanche m’interessa. Chi se ne frega. Non ho bisogno di essere accettato da nessuno. La gente cerca troppe conferme.
Cosa ti ha spinto, in prima battuta, a fare questo disco?
Una telefonata con Tyler. Ho sempre voluto farlo, ma quella è stata la scintilla. Non gli ho spiegato cosa avevo in mente, più che altro lui m’ha detto: «Qualunque cosa tu voglia fare, e lo sai nel cuore e nella mente, falla. E al meglio, senza prendere scorciatoie. Niente scorciatoie».
Cosa ricordi delle prime session?
Conoscevo i ragazzi, quindi non c’è stato alcun imbarazzo. Avevo già un sacco di canzoni con un sound simile a quello dell’album. Non mi stavo avventurando in un territorio nuovo: è musica che ascolto da quando ero piccolo. È nuova per il pubblico, non per me. È ciò che faccio… solo non sapevo come cazzo l’avremmo fatto. Pensavo che forse avevo alzato un po’ troppo l’asticella a pensare di fare la mia versione di The Dark Side of the Moon. Non è stato un disco facile da realizzare.
Nelle interviste hai menzionato le sostanze psichedeliche. Quanto sono state importanti nel processo di registrazione?
Niente. Zero. Non riesco a registrare musica da fatto. Devo essere assolutamente lucido. L’ho fatto già a sufficienza e so cosa voglio. Non devo per forza essere strafatto per far suonare questa musica.
Hai raccontato che, crescendo, hai ascoltato tutti i generi di musica. Hai mai percepito uno stigma del tipo: «questa è musica per bianchi»?
Sì, chiaro, ma non me ne frega un cazzo, fratello. È difficile colpirmi o offendermi. Faccio quel che voglio. Capisci? La gente dice che questo album è musica per bianchi? E chi se ne frega, amico! Cos’è la musica dei bianchi?
Hai detto di averlo fatto, in parte, perché volevi essere preso sul serio come artista e non volevi essere considerato solo un rapper di SoundCloud o un mumble rapper. Cosa diresti a chi pensa che i rapper di SoundCloud e i mumble rapper meritano d’essere considerati come tutti gli altri artisti?
Non posso parlare per qualcun altro. Non sono il portavoce di nessuno. Non garantisco per l’etica del lavoro o la creatività di nessun altro: solo per la mia. Voglio essere preso sul serio. Non sono un mumble rapper o un rapper di SoundCloud. E con questo, non sto parlando di tutti i rapper di SoundCloud. Sto parlando di me. Voglio che sia chiaro. Vale per me, perché non tutti hanno questa etica del lavoro, non tutti sono disposti a studiare per tutto il tempo necessario a capire un genere nuovo e come fare qualcosa al meglio.
Mi sembra che molte persone abbiano male interpretato i tuoi commenti. La gente è protettiva nei confronti dell’hip hop e ogni volta che qualcuno prova fare qualcos’altro si pensa che stia dicendo che l’hip hop è inferiore.
È assurdo. Sono proprio loro a sminuire il talento degli altri. Tipo: «Oh, amico, non sei un vero rapper. Questo non è vero rap». Non puoi accontentare tutti.
Hai detto che in un certo periodo cercavi di dimostrare di saper fare rap. Cosa ne pensi ora, col senno di poi?
Mi ha reso un uomo. Mi ha reso forte. Mi ha fatto interessare di più al mestiere. Mi ha fatto venire voglia di imparare, di migliorare, di affinare le mie doti.
Sei mai arrivato a un punto in cui la stigmatizzazione di cui dicevamo ha reso più difficile portare avanti la tua carriera?
Nulla è facile nella vita. Ci sono voluti lavoro e impegno e sento di dover lavorare ancora sui fronti del rap e della percezione di me. Anche se m’interessa meno di un tempo.
Ha a che fare col fatto che c’è una specie di stigma nei confronti dei rapper quando si parla di premi, passaggi radio e festival?
Per me vale zero. Non mi interessa nessuna di queste cose. Faccio musica di tutti i generi. Non ha niente a che fare con i frutti e i risultati che non arrivano se sei un rapper: niente di tutto questo. Mi piace fare ogni tipo di musica, tutto qui, punto. Non c’entra con il fatto di non essere amato o rispettato o di non essere invitato a una cerimonia.
Continuerai a cercare di provare qualcosa a qualcuno con ogni tuo album?
Non necessariamente. Non ho fatto questo disco per dimostrare che potevo farlo. Voglio essere preso sul serio, ma non l’ho fatto con questo scopo. Volevo solo pubblicare un gran disco, sentivo di poter dare il meglio in questo campo piuttosto che con un disco rap.

Foto: Gunner Stahl
Come vanno le cose con la tua etichetta, la Concrete Boyz?
È l’unica cosa che m’interessa al momento. Ogni giorno siamo lì, in studio, a lavorare. Abbiamo degli artisti speciali, sono volti nuovi. Voglio essere sicuro che pubblichino roba hot. Sono fortissimi, sentirete suoni freschi. È questo il mio prossimo progetto, arriverà in estate.
Stavo ascoltando la tua intervista con Zane Lowe e mi sembra di averti sentito parlare di un documentario. Ho sentito male?
Ho detto che ne ho uno, ma dubito che lo pubblicherò. Esattamente come non mi piace fare interviste, perché si svela tutto. «Chi l’ha ispirato? Di cosa avete parlato? Quando? Cosa ti ha spinto a farlo? Perché?». Rispondendo non è più un progetto speciale, perché si viene a sapere tutto. Non è più «wow, come ha fatto a fare ‘sta roba?». Ecco perché mi domando: davvero voglio spiegare tutto di quest’album? Lo priverei di tutte le particolarità, non c’è più nessuna sorpresa speciale, nessun elemento nascosto. È uno dei problemi della musica di oggi. Tutti condividono troppo. Tutto è social. Più si dà, meno una cosa diventa figa.
Gli artisti che mantenevano quell’alone di mistero erano quelli che ti incuriosivano di più quand’eri più giovane?
Be’, non c’erano i social media. Anche se concedevi un’intervista, non svelavi tutti gli elementi di un progetto. Kanye non ti raccontava ogni dettaglio su come aveva realizzato 808s & Heartbreak o My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Sapevi le cose essenziali, ma restava un bel po’ di spazio per le domande: come ha fatto a fare questa roba? Come ha creato il suono? Chissà come è stata la session. È il bello dell’arte.
Da Rolling Stone US.