Non è più soltanto il bassista dei Suede, Mat Osman, e quando lo contattiamo su Skype lo dice chiaro e tondo: «Mai avrei immaginato che la scrittura avrebbe cambiato così tanto la mia vita, e invece…».
Negli anni scorsi il 53enne inglese si era già guadagnato diverse collaborazioni come giornalista per testate quali Guardian, Observer e Independent, diventando poi chief editor dell’edizione londinese del magazine Le cool. Mentre risale al febbraio 2020 la pubblicazione di The Ruins, il suo primo libro uscito a luglio in italiano con il titolo Rovine (Edizioni di Atlantide, qui un estratto): un romanzo pieno zeppo di musica (c’è una playlist su Spotify che ne raccoglie le suggestioni sonore), il cui intreccio ruota attorno alla storia dei gemelli Adam e Brandon, il primo chiuso in se stesso e nella sua ossessione, il modellino di una città immaginaria chiamata Umbrage che occupa gran parte del suo appartamento, il secondo ex frontman dei Remote/Control, band sul punto di raggiungere il successo negli anni ’90, prima di finire nel dimenticatoio.
È attraverso il rapporto tra i due, stravolto dalla misteriosa morte di Brandon che spingerà Adam a un’indagine spericolata quanto disvelatrice, che Osman, con una scrittura in grado di travalicare i generi, immaginifica, a tratti strabordante e dai toni spesso surreali, indaga un tema intrinsecamente filosofico, quello dell’identità personale. «Nel Regno Unito il libro è uscito più di un anno e mezzo fa», afferma lui, «ma sono contento di parlarne ancora, perché a causa della pandemia non sono riuscito a promuoverlo come avrei voluto». E aggiunge: «Chissà se nei prossimi mesi avrò modo di recuperare, spero di riuscire a venire a presentarlo anche in Italia, è il mio primo romanzo e ci tengo molto. Non che non sia orgoglioso dei dischi incisi con i Suede, tutt’altro, ma si tratta di progetti a più mani, mentre questo libro appartiene solo a me: è la prima volta che pubblico un’opera che porta solo la mia firma».
Sarà la prima di una serie?
Ho già un altro romanzo pronto. L’ho scritto abbastanza velocemente: visto che a causa del Covid nei mesi scorsi avevo più tempo libero del solito, mi sono dedicato alla scrittura. E a essere sincero non so come avrei fatto senza. Senza la scrittura, come senza la musica: ormai non c’è giorno in cui non suoni o non scriva.
Che cosa ti dà la scrittura, in particolare?
Scrivendo ho trovato un nuovo modo di considerare le cose, un nuovo sguardo sul mondo. È questo che mi ha conquistato e che ha fatto sì che una volta iniziato a scrivere non sia più riuscito a smettere: la scrittura è uno strumento incredibile per conoscere se stessi nel nostro rapporto con ciò che ci circonda. Si possono buttare giù idee e appunti e ricavarne un libro, ma a parte questo è l’atto della scrittura in sé che è interessante, stimolante, perché ti porta a chiederti come la pensi e cosa provi rispetto a determinate circostanze, ti spinge a riflettere su te stesso e a capire meglio anche gli altri. Ormai, quando accade qualcosa che non riesco bene a interpretare o che mi confonde, mi metto subito a scrivere.
E di te stesso che cosa hai imparato, scrivendo Rovine?
Sai, il libro è su questi due fratelli gemelli, e ciascuno di loro rappresenta una parte di me, un lato della mia personalità. Adam è ciò che sarei diventato se non avessi mai fatto parte di una band, perché di mio sono antisociale, potrei vivere per i fatti miei senza problemi. Mentre Brandon è ciò che sarei se, invece che il bassista di un gruppo, fossi stato il frontman.
Hai già precisato di non esserti ispirato, se non vagamente, al rapporto con tuo fratello Richard Osman, noto comico e conduttore televisivo e da poco anche lui autore di un romanzo che, tra l’altro, in Gran Bretagna è diventato un bestseller, The Thursday Murder Club. Resta il dubbio che per il personaggio di Brandon tu ti sia ispirato, benché solo in parte, a Brett Anderson.
No, Brandon è una parte di me tanto quanto Adam. Il lato intrigante è che man mano che costruivo il suo personaggio mi rendevo conto di quanto, sebbene lui sia un essere umano pessimo, sicuramente peggiore di Adam, provassi simpatia nei suoi confronti; mi sono divertito un sacco a tratteggiarne il carattere. Probabilmente mi assomiglia più di quanto pensassi quando ho cominciato a immaginarmelo.
Devo dire che Brandon ha fatto godere parecchio anche me: è il tipico stronzo egocentrico da non frequentare, ma che quando parla del mondo e della società in cui viviamo è in grado di dire grandi verità.
Io la vedo così: l’unica cosa buona in Brandon è l’arte, tutto ciò che c’è di buono in lui lo mette nella musica. E scrivere questo romanzo mi ha avvicinato a questo tipo di figure: di alcuni artisti siamo soliti dire «è un bravo artista, ma è umanamente indecente»; ora, invece, quando penso a quel tipo di personaggi mi dico che forse hanno semplicemente fatto del loro meglio.

Con i Suede. Foto press
Oggi mi pare abbia vinto l’idea che un artista, per essere apprezzato in quanto tale, debba essere anche una brava persona. Non so se c’entri il fatto che i social offrono la possibilità, o almeno l’illusione, di addentrarsi nelle vite degli altri, fatto sta che un certo moralismo che un tempo era appannaggio dei media tradizionali ora è diffuso sempre più anche altrove e tra il pubblico. Che ne pensi?
Per quanto mi riguarda posso amare l’arte e detestare l’artista, non ho problemi da questo punto di vista. Voglio dire, se ascoltassi solo musica creata da ottimi esseri umani, la mia collezione di dischi sarebbe molto, molto, piccola. Ho dei limiti rispetto ad artisti che veicolano messaggi razzisti o cose del genere, in quel caso è diverso, non comprerei mai il disco di un razzista, non gli darei i miei soldi. Ma per il resto non metto paletti. Anche perché una volta che un album, un libro o un dipinto sono diventati pubblici, a quel punto appartengono a chi li fruisce. Insomma, pensiamo a John Lennon, aveva un carattere terribile, ma il meglio di se stesso lo ha messo nella musica che ci ha lasciato e il fatto che potesse essere violento non ci toglie la bellezza di Jealous Guy: quella bellezza è il meglio che poteva darci.
Dunque non ti sei ispirato a nessuno in particolare, se non a te stesso, nel costruire i personaggi di Adam e Brandon…
No, davvero, però una fonte d’ispirazione nella vita reale l’ho avuta: ho due nipoti gemelle, hanno 11 anni, e mi ha sempre affascinato il loro modo di comportarsi, perché è un po’ come se fossero forzate dalle aspettative esterne a essere diverse l’una dall’altra: una più estroversa, l’altra più timida; una più sportiva, l’altra più intellettuale… Eppure c’è un continuum, una somiglianza di fondo, la stessa che c’è tra Brandon e Adam: hanno due personalità molto diverse, ma in fondo, se vai al cuore delle cose, entrambi cercano di avere un controllo sul loro mondo.
Del resto, tutti noi – e questo è un altro tema che affiora tra le righe del tuo romanzo – abbiamo la possibilità di costruire i nostri percorsi esistenziali come se stessimo scrivendo un libro: in un certo senso scegliere che tipo di persone vogliamo essere è come assegnarsi un ruolo in una narrazione, o sbaglio?
Sono d’accordo, ci raccontiamo la nostra storia. Non so voi italiani, ma noi inglesi quando incontriamo per la prima volta una persona che non riusciamo bene a collocare chiediamo: «quindi, qual è la sua storia? (so, what’s his story?, nda). Dopodiché un primo abbozzo di idea per questo romanzo mi è venuto quando i Suede si sono sciolti, ed è stato strano.
In che senso?
Andavo per i 40 e di fronte a me ecco una vita da reinventarmi daccapo, può essere spaventoso. Ma pian piano ho compreso che quella di reinventarsi è un’opportunità che non tutti hanno, il che mi ha portato a pensare che mi sarebbe piaciuto scrivere di qualcuno a cui d’un tratto capita l’occasione di potersi mettere nei panni di qualcun altro, come accade ad Adam quando viene a sapere che suo fratello gemello è morto. La domanda che mi intrigava era: è possibile cambiare? È possibile diventare qualcun altro?
Molto pirandelliano. Com’è stato per te, cambiare vita dopo la fine dei Suede? Nel 2011 avete ripreso a incidere dischi, ma ai tempi dello scioglimento nessuno avrebbe mai ipotizzato che sarebbe potuto accadere.
Già, all’epoca, oltre a cambiare vita, ho dovuto ripensare la mia identità. Perché essere il musicista di una band era la mia identità, è ciò che accade quando la musica diventa il tuo lavoro. È stato difficile, ma a posteriori posso dire che era quanto di meglio mi potesse succedere: quell’evento mi ha costretto a riflettere su ciò in cui credo, sui miei desideri personali, e a costruirmi una mia identità in maniera autonoma. Perché, sai, quando suoni in un gruppo fai parte di una sorta di macchina guidata da un team di persone, non sei tu da solo a decidere cosa fare. Non a caso ricordo perfettamente i giorni dopo lo scioglimento: d’un tratto non avevo concerti da fare, né sessioni in studio, né altro; ero spaesato. Pian piano, però, mi sono reso conto che potevo decidere che cosa fare delle mie giornate.
A un certo punto ti sei dato al giornalismo, non solo, ma anche musicale: com’è stato? Parliamo di un mondo che molti musicisti identificano con il male…
A me piace!
Perché ora ne fai parte?
Adesso in realtà meno, anche se scrivo ancora dei pezzi; in agosto è uscita una mia intervista agli Horrors sul magazine Marvin. Ma la cosa che mi piace di più è, in generale, l’idea di mantenermi per qualcosa che esce dal mio cervello, dal lavoro della mia mente. È bello essere pagati per sviluppare le proprie idee, per chi fa musica non è così diverso: ti sbatti per guadagnare da ciò che ami fare con le tue idee, ossia canzoni e dischi. Dopodiché del lavoro di giornalista mi piacciono soprattutto le interviste, perché ti consentono di chiedere ai tuoi interlocutori di rispondere a domande anche profonde, intime, che non potresti mai rivolgere così sfacciatamente, al primo colpo, a qualcuno che hai appena conosciuto. Insomma, non hai bisogno di essere educato o formale come nella vita di tutti i giorni, puoi chiedere a qualcuno delle sue paure, delle sue inquietudini, delle sue passioni… E il dialogo che si crea è qualcosa che ti cambia, oltre a metterti al cospetto di ciò che non sai rispetto a questo o quell’altro argomento. Ciò detto, da intervistatore ho un difetto: parlo troppo (ride).
Qui sei l’intervistato e vorrei chiederti del modo in cui l’industria musicale è tratteggiata in Rovine, romanzo che è un’ode all’arte della musica che passa anche attraverso una critica alla crescente pervasività del music business nei processi creativi. E di quel music business la fascinosa popstar Kimi è il simbolo: “La sua musica si trascinava nel solco dell’implacabile logica commerciale”, osserva Brandon in uno dei testi riesumati da Adam.
Lì ciò che mi interessava esplorare, però, era il punto di vista di Brandon, il quale, avendo fallito, non avendo ottenuto successo, parla della fama di Kimi, che alla fine è quella che ha più talento, condizionato dalla propria invidia, dalle proprie frustrazioni, dal proprio sentirsi escluso. Poi, certo, ci sono aspetti del music business che non piacciono nemmeno a me, la differenza è che a Brandon non piace niente.
È solo una metà di te, lo hai detto tu stesso.
Già. Personalmente ciò che davvero non amo del mondo della musica attuale è questa cosa che ai concerti si filma e fotografa tutto con i cellulari, un’abitudine che annulla ogni possibilità di connessione profonda tra la band sul palco e gli spettatori sotto al palco. Ma alla fine il mio romanzo parla della gioia di fare musica: i libri che parlano di musica sono quasi sempre focalizzati sullo stile di vita dei musicisti, mentre a me premeva mettere al centro il fare musica in sé, la gioia che si prova a scrivere una canzone e a suonarla per un pubblico, oltre alle frustrazioni implicate in tale processo. Che poi tutto questo vale anche per gli atleti, i grandi campioni: ci raccontano sempre le storie dei loro traguardi, ma cosa prova un atleta mentre corre o nuota? Cosa si prova a segnare un gol in uno stadio pieno?
Cosa si prova a suonare in un locale affollato? Mentre leggevo Rovine mi sono ritrovata spesso a pensare che a questa domanda in Italia non possiamo nemmeno più rispondere, visto che nonostante una campagna vaccinale più che riuscita e l’estensione del Green Pass le capienze per i concerti non sono state ancora aumentate.
Mmm, nel Regno Unito siamo ripartiti, ma non ancora del tutto. Quel che posso dire è che per noi Suede non è stato facile accettare la situazione, visto che abbiamo un nuovo disco pronto che si compone di tracce brevi, aggressive, punk, molto dirette.
Tutto il contrario di The Blue Hour, il vostro album del 2018 incentrato su arrangiamenti orchestrali e una gran dose di epica.
Ogni disco è una reazione al precedente, almeno per noi. Fatto sta che avevamo in mente di presentare questo nuovo album con una serie di concerti nei club, in contesti di folla e sudore, proprio quelli che la pandemia ha reso impossibili. Lo pubblicheremo quando saremo sicuri di poter organizzare un tour di quel tipo: se The Blue Hour sarebbe stato perfetto anche per i teatri, questo disco ha uno spirito completamente diverso, per cui, sarò sincero, non so quando potrà uscire. Per ora – sarà anche un pensiero narcisistico ed egoriferito, ma è così – mi manca la folla che c’è di solito ai concerti, sentire la gente cantare assieme a te, il muoversi, ballare e saltare tutti insieme.
Non avete mai suonato nemmeno quest’estate? Mi sembra di aver visto una data.
Abbiamo fatto un solo concerto in Finlandia un mese e mezzo fa: è stato bello, ma ho la sensazione che tutta la burocrazia prevista non consenta alle persone di godersi la musica dal vivo fino in fondo. Il bello dei concerti è che sono situazioni in cui chi ci va può lasciarsi andare, abbandonarsi, perdersi, e io non ho mai amato quei live a teatro dove gli spettatori si limitano a guardare: il senso dei concerti è che le singole individualità, nel condividere quell’esperienza di amore per una certa musica, si uniscono diventando un tutt’uno.
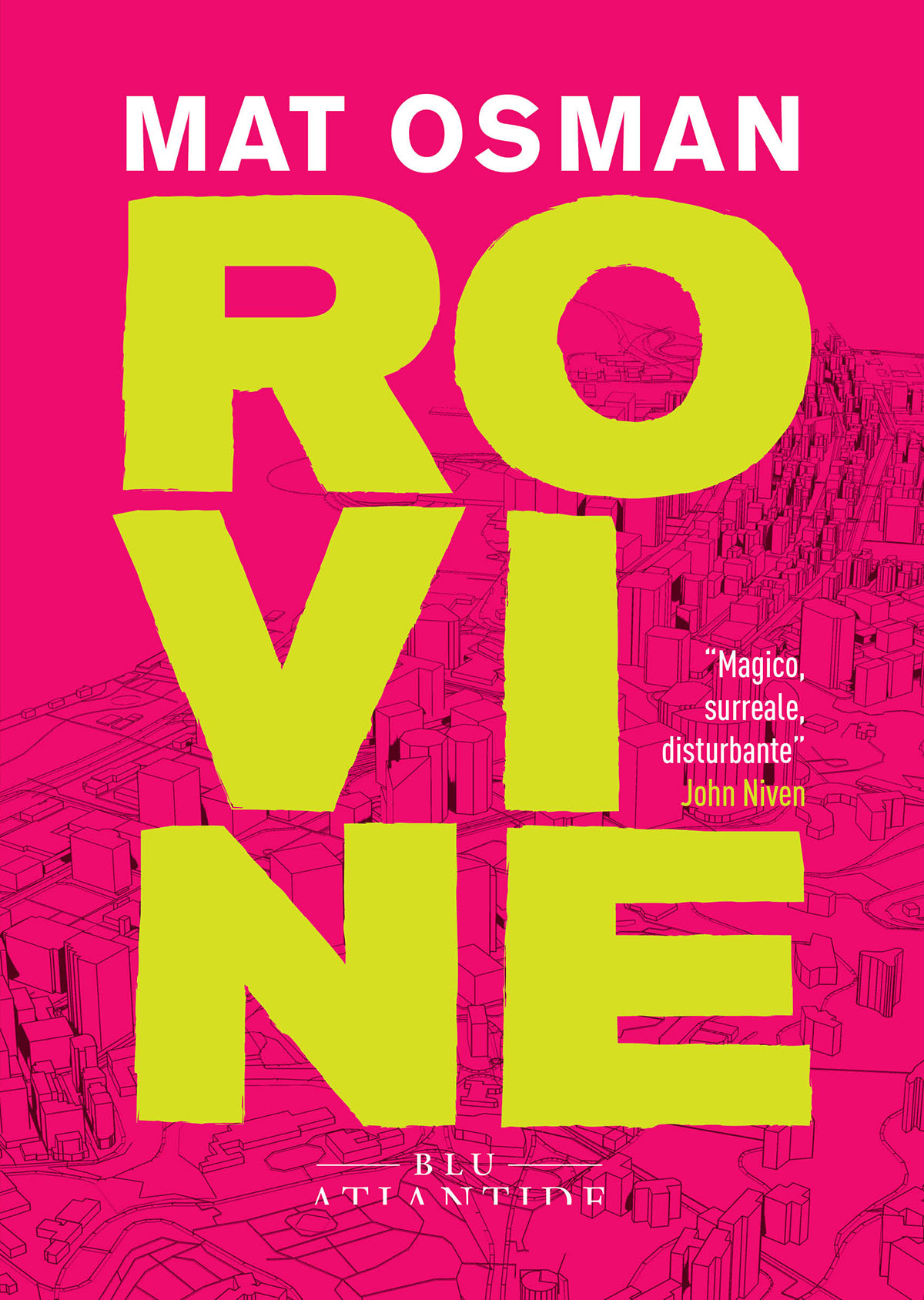
Tornando a Rovine, è un romanzo che condensa più generi, ma l’intreccio fa pensare che tu sia un appassionato di libri noir, di thriller.
In realtà spazio tra i generi e in ciascuno ho decine di autori che mi piacciono. Se si parla di crime fiction, un nome che farei è quello di Patricia Highsmith: è incredibile lei, bravissima a tratteggiare i personaggi cattivi. Per il resto mi piacciono, tra gli altri, Michael Chabon e Michel Faber, scrittori che mescolano i generi, che passano da uno stile all’altro, che sfuggono a ogni etichetta. Figurati che il mio prossimo romanzo è ambientato a Londra, nell’epoca shakesperiana.
Un altro mondo…
Esatto, è un libro lontanissimo da Rovine.
Quindi l’hai presa seriamente, questa faccenda dello scrittore.
Sì, mi piace molto, ho anche tenuto dei workshop. Non pensavo che la scrittura avrebbe avuto un impatto così forte sulla mia vita, invece è andata così e ora mi piacerebbe spingere più persone possibili a scrivere, anche solo per se stesse. Io inizialmente sono stato stimolato dal bisogno di chiudere un mio progetto da solo, era quella la mia ambizione, e scrivere un romanzo è una sfida enorme, ma poi è come se la scrittura fosse diventata parte di me tanto quanto la musica. Le due si accompagnano benissimo insieme: da musicisti si hanno molti tempi vuoti da riempire, e in quanto attività che si può portare avanti sempre e ovunque, la scrittura è perfetta sotto questo aspetto; al tempo stesso, come scrittore vivi in una dimensione solitaria, per cui fare parte di una band compensa quel senso di isolamento.
Hai trovato la combinazione perfetta, insomma.
E la consiglio a chiunque: nella vita dovremmo essere tutti bassisti e scrittori (ride)!
Se così fosse probabilmente uscirebbero solo romanzi intrisi di musica come il tuo, in cui, tra citazioni di band e dischi e ambientazioni quali backstage di concerti e studi di registrazione, c’è un album, Smile dei Beach Boys, che ricopre un ruolo essenziale. Non sveleremo nient’altro, ma perché proprio quel disco?
La cosa divertente è che non ero un così grande fan dei Beach Boys prima di scrivere il libro. Inizialmente l’idea era di far ruotare il racconto attorno a un disco underground andato perduto, ma poi mi sono reso conto che un disco finto era troppo complicato da raccontare, così mi sono chiesto se esistesse un album famoso andato perso e mi è venuto in mente Smile (registrato tra il ’66 e il ’67, ma rimasto inedito fino al 2004, quando fu pubblicato in una versione ri-registrata da Brian Wilson, laddove nel 2011 è uscita in formato cofanetto la versione dei Beach Boys ricostruita a partire dai nastri originari, nda). Da quel momento l’intreccio mi è sembrato più chiaro e Smile, che ho ascoltato e riascoltato mentre scrivevo, mi ha letteralmente conquistato.
Come mai, invece, hai ambientato Rovine nel 2010, mentre l’eruzione del vulcano islandese Eyjafjöll blocca mezzo mondo con la sua immensa nube di cenere e dopo che la crisi dei subprime ha dato il via alla recessione che tutti conosciamo? Anche se ti confesso che ci sono stati momenti, nel corso della lettura, in cui mi sono sentita catapultata in un futuro distopico.
Questo perché qua e là ho usato il linguaggio tipico della narrativa fantascientifica, lo capisco. Se ho scelto quell’ambientazione è perché all’epoca, nel 2010, mi trovavo a Londra per lavorare su uno strambo progetto interattivo e un giorno annunciarono la sospensione di tutti i voli a causa di quell’eruzione vulcanica. Improvvisamente le persone impegnate su quel progetto, creativi da ogni dove, non potevano tornare nei loro Paesi, così ebbe inizio un periodo interessante, durò una decina di giorni, ma si misero tutti a scrivere e a inventarsi cose da fare. Insomma, il punto è che ci sono dei momenti di sospensione, in cui tutto pare fermarsi e pazienza se è un’illusione, che sono l’ideale affinché una storia venga alla luce. Poi conta anche che l’idea di un mondo in decadimento è per me intrigante e un romanzo credo dovrebbe sempre prendere il via da una situazione di disequilibrio: le crisi aprono sempre la porta a qualcosa di nuovo, ti obbligano a reinventarti, no?













