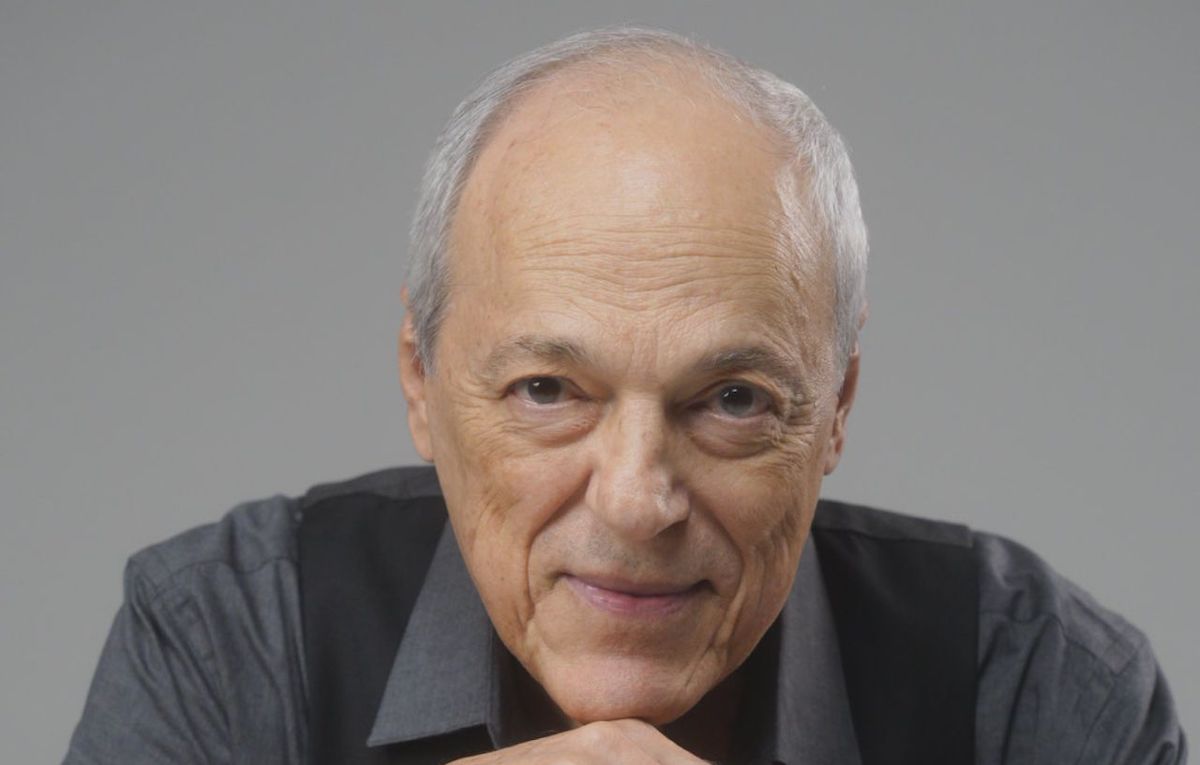«Ho sempre amato la musica tanto quanto le arti visuali»: nulla di sorprendente in questa frase, pensando a quanto incredibili siano diventati i live show audio/video del signor Max Cooper. Ma davvero: incredibili. Ci sono magari artisti più famosi, più celebrati, più pagati, certo che ci sono; però l’artista nato a Belfast nel 1980, ma residente da anni a Londra, è davvero uno di quelli capace di lasciarvi, oggi, a bocca aperta. Non sono tantissimi. Forse proprio il fatto che Cooper sia diventato sempre più sfuggente a livello stilistico (è house? È techno? È electro? È hip hop astratto? È sperimentazione? È più pop, o più visionario?) lo ha penalizzato: in qualche maniera la sua traiettoria taglia infatti a metà, anzi, in diagonale tutte quelle più convenzionali, quelle in circolazione oggi nel mercato, pardon, nel mondo della musica e cultura elettronica. Traiettorie che, diciamolo, sono ben codificate, più ancora che nel rock o nell’hip hop. La rassegna romana Videocittà – che non a caso ha nella ragione sociale proprio la voglia di indagare le frontiere più avanzate della comunicazione audiovisiva – lo porta sul palco il prossimo 22 luglio: ne abbiamo approfittato per una chiacchierata piuttosto densa sul suo modo di fare arte, sulla sua evoluzione, sulle sue scelte.
«Ho sempre amato la musica tanto quanto le arti visuali però sì, è vero, negli ultimi tempi la parte visuale dei miei live è diventata davvero una componente fortissima». Ecco. «Il salto di qualità? L’ho fatto quando mi sono reso conto che potevo valorizzare anche a fini artistici il mio background di studi scientifici, utilizzandolo nei visuals. Da lì, in un bellissimo e quasi sorprendente circolo virtuoso, l’aumentata complessità e qualità della componente visuale ha fatto alzare il livello anche alle mie idee musicali. Ma una cosa va detta chiaramente…». Vai. «È sempre un processo collaborativo. Io porto la musica e un po’ di idee, sì, ma da lì in poi entra immancabilmente in campo l’intervento di un composito gruppo di persone di cui amo circondarmi: matematici, architetti, artisti visuali. Tutti insieme ci diamo il compito di raccontare il mondo in cui viviamo vedendolo in primis sotto le lenti della scienza e della filosofia: questo è il principio base. Nell’arco di tutti questi anni i progetti si sono accumulati, e così le idee e le suggestioni: oggi credo di aver raggiunto un livello effettivamente non male in quello che posso offrire in una mia esibizione».
Non bastano solo le idee, però. Ci vuole la tecnica. Intesa in doppio senso: padronanza delle macchine sul palco, e proprio le macchine stesse. Fuori i segreti, fuori i ferri del mestiere: «Sono arrivato a crearmi un set up sul palco che mi permette ormai di lavorare molto, molto bene su visuals in 3D, da sovrapporre pure a strati. Riesco insomma a dare vita a situazioni musicalmente e visivamente complesse – come dicevo prima, le due cose si influenzano – e questo ha portato a rendere ormai realistico e non molto lontano un esito ben preciso che mi sono dato come obiettivo». Ah. Quale? «Uscirmene per certi versi dall’industria musicale, dai suoi riti e dalle sue regole, da quella che è la sua conformazione standard».
Questo punto è molto interessante. Chiediamo ovviamente di approfondirlo: «Negli anni ho fatto parte di diversi generi o scene musicali, e io stesso contribuivo a rendere chiara certa catalogazione, adattandomi di volta in volta. Oggi finalmente sento di potermi permettere di suonare qualsiasi cosa mi venga in mente senza preoccuparmi più di essere coerente rispetto a questo o quel genere musicale, rispetto a questo o quel principio di gusto o moda. È una differenza fondamentale. I visual ormai danno una ricchezza tale che, qualsiasi cosa finisca col suonare dal vivo, so che ciò che sto presentando è più o meno interessante, artisticamente denso. Posso quindi buttarci dentro di tutto: cose mie, ultime novità, vecchi classici altrui, di tutto. Col risultato finale che ormai il mio show è una specie di stranissimo ibrido – un po’ live set, un po’ dj set, un po’ performance visuale. Non si sa più come definire quello che faccio, ecco. Sia come formato, che come musica. E sai che c’è? Questa cosa non mi fa più paura. E aggiungo: se una sera mi sento dell’umore di provare a costruire creazioni e soluzioni che non ho mai tentato prima, beh, ora lo faccio senza la minima preoccupazione. Perché so che mi sono creato un set up che, tecnicamente parlando, mi permette anche di improvvisare senza il rischio di perdere la bussola. O di far all’improvviso implodere tutto quanto».
La tecnologia che libera la creatività, quindi. Vecchia utopia; peccato che proprio nel mondo dell’elettronica ormai da anni sembra succedere l’esatto contrario, o giù di lì. C’è una grande standardizzazione. Tutto è molto chiaro, delineato, codificato. Più che negli anni ’90. E questo sia tra i dj che riempiono le arene che, diciamolo, anche fra i grandi sacerdoti della sperimentazione, che ormai da anni stanno girando in tondo – magari anche bene, eh – attorno alle intuizioni degli anni ’90 e dei primi anni 2000, e alle regole di galateo artistico che queste intuizioni hanno generato e, forse inconsapevolmente, imposto. Cooper, no. È sempre più atipico. Fuori i trucchi del mestiere, Max: come fai? E intendo proprio tecnicamente parlando, quindi dammi pure una risposta da nerd. «Nei miei live uso come primo riferimento Ableton per la parte audio e Resolume per quella visuale, con device per Max For Live come interfaccia disegnati dallo sviluppatore Mattijs Kneppers. In parole povere, l’insieme di queste cose e di questi mezzi mi permette di improvvisare sia con l’audio che col video. Da un lato ho un computer con un mare di materiale sonoro a disposizione da cui pescare e da utilizzare, dall’altro la stessa cosa per il materiale video. La parte difficile? Coordinare queste due fonti: stabilire insomma in quale modo le scelte operate su una delle componenti influenzino l’altra. Per riuscirci, uso dei controller midi abbastanza standard che operano su Ableton; in questa maniera, costruisco in tempo reale il materiale audio sapendo che quello visuale in qualche modo seguirà organicamente il processo. In realtà anche i controlli per la parte visuale li tengo dentro Ableton, che in teoria è una maniera abbastanza bizzarra di operare. Ma almeno in questo modo ho tutto nello stesso posto, per quanto riguarda comandi e controlli – e questo significa che non sono mai sopraffatto dalla confusione, so sempre dove trovare velocemente le cose».
Beh, interessante. Molto. «Ma questa ovviamente è solo una parte del lavoro. Una piccola parte. Come dicevo prima c’è un sacco di creazione preliminare, invece: i frammenti audio e video da usare non nascono da soli e, per giunta, sono appunto piuttosto complessi. Io mi diverto a raccontarne la costruzione e il modo in cui vengono utilizzati, tra l’altro: se andate ad esempio a cercare sul web potete trovare parecchi miei approfondimenti a riguardo, penso a Emergence, Yearning For The Infinite o Unspoken Words. Provo comunque a riassumerti tutto quanto, che dici?». Prova. «Di solito parto da un’idea, o da un concetto; cerco chi potrebbe essere in grado di realizzarlo dal punto di vista visivo, gli mando un brief e da lì lavoriamo di pari passo, intersecando musica e parte visuale man mano che prendono forma. Qualche volta succede che arrivi prima la parte musicale, qualche volta invece arriva prima quella video, ma di solito si costruiscono e completano un po’ a vicenda. Capita che io metta molto bocca nella parte visuale, ma può anche succedere che mi limiti ad alcune indicazioni di massima e poi lascio carta bianca assoluta, attendendo il risultato finale. Non c’è una regola fissa, ecco. Di regole fisse ce n’è solo una: dobbiamo essere sicuri, io e la persona con cui sto collaborando, di essere entrambi affascinati dall’idea, dal concept che ho proposto; e dobbiamo essere sicuri di avere in comune un certo tipo di senso estetico. Una volta verificato questo, si può procedere liberamente, ogni volta in maniera diversa: perché tanto sai che le cose verranno fuori comunque bene».
E verranno fuori comunque distanti dalle catalogazioni di genere. Ad esempio, ormai lontane dalla semplificazione giornalistica – che a lungo to ha accompagnato – che la tua sia “musica da club”, musica da fruire ballando in contesti dove sono i dj a farla da padroni. «Io amo la musica da club, amo la scena della club culture. Ancora adesso. È il contesto artistico in cui sono nato e mi sono sviluppato e, in qualche modo, mi apparterrà sempre. Oggi però posso suonare sia ad un rave alle sei del mattino che in una galleria d’arte alle sei del pomeriggio, più tutti gli scenari intermedi possibili: e amo profondamente l’aver raggiunto questa versatilità. Una versatilità che in fondo nemmeno dovrebbe sorprendere: tutti noi a ben vedere siamo persone complesse e sfaccettate, no?». Eh… «Certo, mi rendo conto di una cosa: più vado avanti a rendere il processo creativo sempre più complesso come in effetti sto facendo, più mi precludo la possibilità di essere ascoltato da un ampio numero di persone. Ne sono perfettamente consapevole. In più, questo mio sfuggire alle regole di catalogazione dell’industria non può che peggiorare le cose. Lo so, lo so. Ma che dirti? Al momento, per fortuna, mi ascoltano e seguono ancora in tanti. Chissà: forse ho trovato uno zoccolo duro di persone che, esattamente come me, ama che le cose si complichino sempre di più e mi seguono, continuano a seguirmi! Diventeremo dei gran cervellotici tutti assieme e sì, staremo bene così… Perché fondo, cos’è la musica? Cosa dovrebbe essere?». Uh. Cosa dovrebbe essere, Max? «Un riflesso di noi stessi. Io ammiro tantissimo chi riesce a raccontare se stesso, ovvero la propria personalità, attraverso la propria musica: anche se magari fa musica che, di per sé, non mi piace».