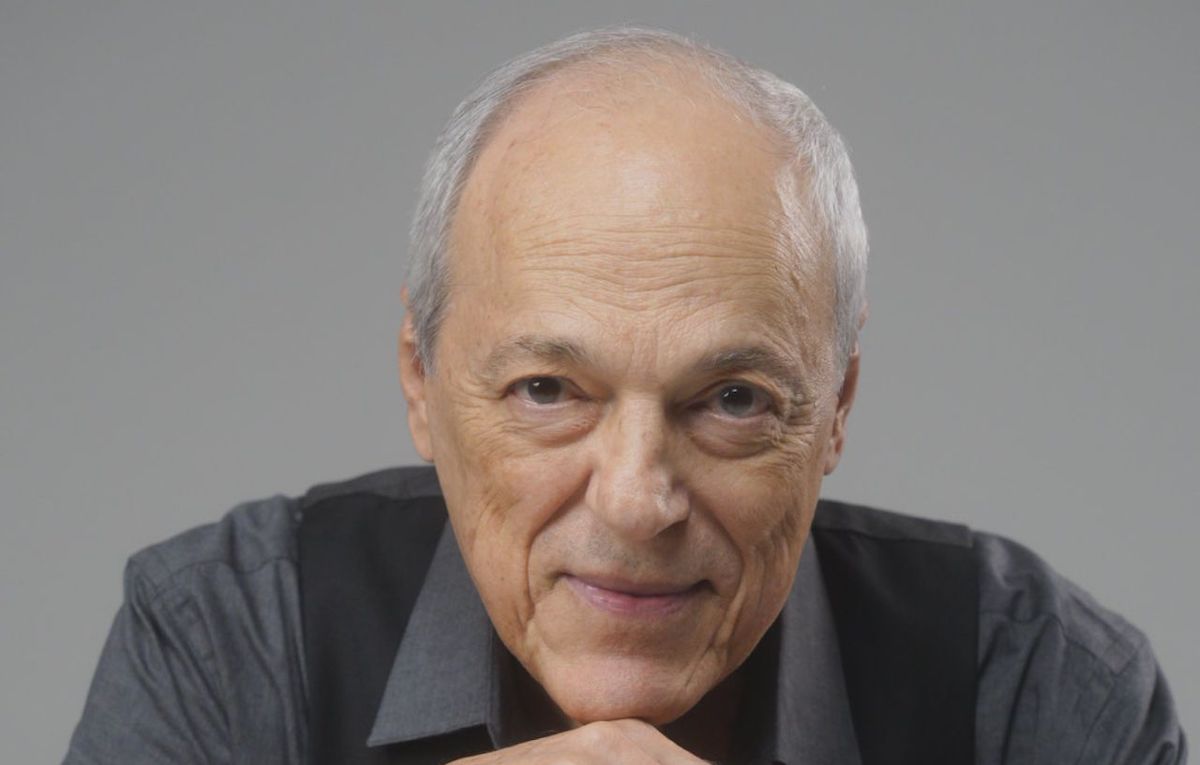Si parla tanto di transizioni. Ma nel mondo dell’arte in generale, e in quello della musica in particolare, è sempre pieno di gente che insiste molto sul tenere la linea, sull’essere un personaggio ben riconoscibile (e sul massimizzare i dividendi di questa riconoscibilità). Al massimo, se ci cambia, lo si fa sperando di avere un successo commerciale e una popolarità maggiori.
Ecco, in tutto questo gioco sentiamo che Nayt sia un po’ un’eccezione: c’è un abisso fra il Nayt degli esordi e dei primi successi e quello che invece si sente da un paio d’anni a questa parte, da quando ha fatto uscire l’accoppiata di album Mood e Doom. Una decisa svolta verso l’introspezione, un progressivo allontanamento dagli stilemi (t)rap – quelli facili, veloci & efficaci – in favore di una voce lirica non semplice, non ariosa, non crassa, non spensierata. Habitat, oggi in uscita, accentua ancora di più questo cambio di direzione. E, sinceramente, lo fa davvero bene.
Abbiamo intercettato Nayt per parlarne sopra un po’: lui in macchina, bloccato nel traffico, e infatti i primi scambi sono una seria di battute su quanto il traffico romano possa essere odioso, e su quanto però l’odio possa anche essere un propellente artistico. Si parte da lì, si finisce con Lucio Dalla e storie di cortometraggi; in mezzo, tante cose che probabilmente – se si è armati di pregiudizi – non ci si aspetterebbe mai da un rapper che fa milionate di ascolti in stream.
Insomma, se a stare nel traffico romano ti sale l’odio in Habitat invece quanto odio c’è? Quanto ce ne hai messo?
Non ce n’è. Al contrario: c’è amore. Ma essendoci l’amore, c’è anche la rabbia – la rabbia che l’amore a volte comporta. Quanto tieni a qualcosa o qualcuno e le cose non vanno bene, oppure ci sono delle ferite aperte, la rabbia non può non esserci. Ma odio, no. Quello no.
Ok. Allarghiamo l’obiettivo: nella società odierna, invece, quanto odio c’è? Perché nel disco racconti molto di te stesso, anzi essenzialmente di te stesso, pur ovviamente trattando di te stesso rispetto agli altri e rispetto alle pressioni della società: quindi le energie sono in qualche modo canalizzate. Ma nella società in generale, invece… Ecco, lì come siamo messi?
Siamo messi male. Infatti, non è un caso che in una traccia come Guerra dentro ho messo, intenzionalmente, un momento di vera e propria ira. Sono parecchio incazzato per quanto riguarda la situazione attuale, non lo nego – e scusa il francesismo. Ciò che più mi fa arrabbiare è quest’anestesia, questo vero e proprio intorpidimento che ci ha preso: non siamo nemmeno più portati ad alzare la voce. Ormai qualsiasi cosa succeda, anche la più idiota o inaccettabile, la accettiamo con un «Ah beh, vabbè…». Quando sento l’attuale Ministro dell’Istruzione e del Merito – santo cielo, “del Merito”, ci rendiamo conto? – dire che «l’umiliazione è una parte fondamentale della crescita degli individui» guarda, anche solo a pensarci ora, che sono in macchina, mi verrebbe voglia di andare a sbattere contro un muro dalla rabbia. Te l’assicuro. Mi girano veramente tanto.
Capisco.
E occhio, non voglio entrare nel politico. Perché la politica odierna la odio, visto che è diventata tutta una questione di partiti, di schieramenti. Per me la politica dovrebbe essere interesse della collettività, che tra l’altro è una prospettiva – quella della collettività, del bene collettivo – che i giovani hanno perso completamente; invece, è solo una questione di schieramenti. O sei di destra o sei di sinistra. O sei fascista o sei comunista. A me interessano i temi di etica morale. Non gli schieramenti, non i partiti. Sono una presa in giro, questi ultimi. Sono solo una facciata.
Un tema su cui le generazioni più giovani si stanno però unendo è quello dell’ambiente, mi pare stia avendo un’attenzione abbastanza trasversale. Trasversale più fra i giovani che fra i trentenni o quarantenni e oltre, a dire il vero, visto che loro pure lì ne fanno una questione di schieramento.
La grande fortuna è che in ogni epoca c’è sempre e comunque una parte di società che è interessata ai problemi della collettività, i problemi che insomma toccano tutti e non solo se stessi, non solo i propri interessi particolari. Ma al tempo stesso c’è invece sempre e comunque una parte che rema contro o che semplicemente se ne frega. Io oggi vedo mediamente più disinteresse che partecipazione: ecco perché nel mio disco c’è tanta rabbia. Almeno in alcune tracce. Sono diventato una persona più consapevole: di conseguenza, su alcune cose mi arrabbio molto di meno, sono più maturo, ma esattamente per lo stesso motivo su altre mi arrabbio invece parecchio di più, perché ho una visione nitida che prima non avevo.
Beh insomma, sei partito come rapper da battaglia, oggi quindi sei praticamente un rapper conscious, tanto per usare delle categorie un po’ anni ’90.
Nella musica oggi si sono mischiati i generi, no? Questo significa che ci sta si siano mischiate molto anche le attitudini. Non so quanto io sia conscious o meno, ma di sicuro oggi non sono uno che fa rap solo per intrattenere le persone, approccio che ha sia i suoi pro che i suoi contro, sia chiaro. Io cerco di stimolare domande e pensieri in chi mi ascolta. Questo è quello che voglio fare, oggi. Poi oh, se vengo chiamato in causa in un certo modo ti assicuro che ancora adesso ci metto un attimo a switchare nel rapper da battaglia. Ma sai cosa? Non mi interessa più granché, quella roba lì da rap game. Non più.
Oggi si sono mischiati i generi, dicevi, e ci sta; tant’è che in effetti mi pare che con questo disco tu abbia come non mai abbracciato un certo tipo di fluidità musicale, staccandoti proprio dagli stilemi puri dell’hip hop come mai in passato. Una traccia come Un’idea si appoggia su una base che è praticamente post rock, per dire. Quanto hai lavorato sull’identità sonora di questo album?
Parecchio. La cosa bella è che con 3D e Walter (Babbini, nda), i miei due principali compagni di viaggio in Habitat, più andiamo avanti più si sta creando un’alchimia speciale. Conoscendoci sempre più fra di noi siamo sempre più bravi a metterci ciascuno sempre più del suo, senza però mai sovrapporci. Io per primo sono migliorato parecchio, come visione musicale. Ho imparato tante cose. Credo che la direzione che riesco a dare oggi nel suono, nell’intenzione e nell’attitudine, sia molto più consapevole e in controllo che in passato. Questa cosa della fluidità musicale – mi piace molto come definizione – la sto rincorrendo da tanti anni, ma per arrivarci davvero ci vuole tempo, esperienza; ci vogliono anche gli errori, e io ne ho fatti tanti. Ora sento che siamo arrivati a un livello in cui abbiamo finalmente una identità nostra e solo nostra. Io cerco di ascoltare quasi tutte le cose che escono in Italia e ti dirò, sono molto contento: perché non sento nessuno che faccia quello che facciamo noi, nel bene e nel male. E questo è un traguardo che ricercavo da tanto.
Se cerchi di seguire tutte le uscite principali, non ti sarà sfuggita l’uscita poco tempo fa del disco di Silent Bob…
Eh, ho capito dove vuoi arrivare.
Che è successo?
Che ti devo dire: ci sarà stato un allineamento di pianeti, non so. Sarò sincero: non so come sia successo che ci siamo ritrovati ad avere un titolo simile…
Lui Habitat cielo, tu Habitat.
Già.
Ma non solo: è simile anche la grafica di copertina, il concept visuale.
Sì, l’associazione col cielo, infatti. Davvero: quando ho visto la copertina del suo disco mi sono detto «Incredibile, è una coincidenza davvero assurda». Quello che ti posso dire che io questa cosa dell’habitat l’ho usata sia in Mood che in Doom, l’accoppiata che precede questa uscita, quindi sono almeno due anni che è in ballo, chi mi ascolta con attenzione lo sa.
Al di là di questo, trovo sia una fase piuttosto interessante per l’hip hop dopo anni un po’ così, di gran successo ma un po’ così, pensando appunto ai dischi che stanno uscendo, al tuo, a quello di Silent Bob, o ad esempio a quello di Tedua, tanto per citare quelli più recenti: dopo la fase in cui il disimpegno pareva la regola, improvvisamente stanno venendo fuori dischi piuttosto densi a livello di contenuto, di emotività.
La wave del 2016, quella della trap per intenderci, è stata effettivamente un’epoca del disimpegno. Ma è stato un po’ come l’arrivo del punk: una ribellione alla tecnica e all’impegno ad ogni costo. Se la vedi in questa prospettiva, penso sia fondamentale ci sia stata, questa epoca. E poi scusa, noi siamo veramente bombardati da messaggi per cui il mondo si sta deteriorando, che il futuro sarà tutt’altro che roseo: come dovremmo reagire a tutto questo? E come dobbiamo reagire al fatto che appunto all’«Istruzione» ora debba unirsi il «Merito», a simboleggiare e incoraggiare una corsa perenne alla competizione? Ci rendiamo conto di che tipo di pressione e responsabilità si viene esposti, in questo modo? Come vengono divisi i nostri diritti e i nostri doveri? Abbiamo il dovere della competizione, va bene, ma dov’è invece il diritto di essere messi nella condizione di imparare a stare assieme? Perché la realtà è che i doveri, se arrivano senza i diritti, non si riuscirà mai ad affrontarli in modo sensato.
Ecco, queste sono le domande che mi faccio. E capisco perfettamente che, come reazione a tutta questa situazione e a queste dinamiche, la gente si tuffi nel disimpegno, disimpegno che ancora oggi domina nel mercato musicale. Perché non ce la facciamo più. Abbiamo troppa pressione addosso. Dobbiamo farci carico sia di un futuro che è molto incerto sia degli errori e delle storture del passato. Tutte cose che puoi affrontare e che puoi risolvere, sia chiaro: ma ci vuole impegno. E studio. Tanto studio. Ma nel momento in cui sei in un paese dove c’è un analfabetismo funzionale sempre più diffuso, che aumenta invece di diminuire, è un bel macello. Sì: tutto questo mi rende molto nervoso.
E poi arrivi tu, infatti: che all’improvviso ti sei messo a pretendere un ascolto attento e approfondito, invece di offrire un po’ di sano e disimpegnato intrattenimento.
Lo so. Se la mia musica oggi la prendi un po’ alla leggera, se pretendi da lei disimpegno e leggerezza, semplicemente skippi, passi ad altro. Lo so. Ma io non sono più motivato a parlare del nulla. E credimi, se serve parlare del nulla lo so fare ancora molto bene: in questi anni ho fatto parecchie sessioni con vari produttori, ho anche scritto testi per altri rapper. So come si fa un pezzo dove sembra che dici tutto, ma in realtà non dici niente. Li so fare. Eccome. Ma oggi, se non c’è poetica, se non c’è un obiettivo preciso in quello che vuoi comunicare, se il fine unico è quello di grattare fatturato da tutto ciò che è musica, trovo che l’esperienza musica si impoverisce. E se si impoverisce l’esperienza, io perdo interesse. E questo non deve accadere.
Prima parlavi dei giovani. Ma sei ancora un giovane, o…?
Sono in una fase di transizione iniziata già ai tempi di Mood, quindi un paio d’anni fa. Oggi ho 28 anni. Non sono pienamente un adulto, per diventarlo ho ancora tante cose da fare e da comprendere. Ma nel momento in cui esci da casa e vai all’università o a trovarti un lavoro, lì smetti di essere giovane. È lì che ti rendi conto che devi iniziare a costruire qualcosa. Io poi non solo mi sono occupato a costruire qualcosa per me stesso. Mi sono pure fatto carico di alcune cose per i miei genitori di cui di solito un figlio non si fa carico, figurati. Ma questo non basta a dire che sono già un adulto. Voglio diventarlo, questo è sicuro; e sì, voglio diventarlo nel modo più nobile e dignitoso possibile.
E il rap? Lui, riuscirà a diventare adulto? Riuscirà a diventare musica per adulti? Perché tu stesso, in una delle tracce di Habitat, dici che l’industria musicale spingerà sempre il rap per i quattordicenni…
Ma quella è l’industria musicale. E io la fotto, l’industria (risate). Quello che ti posso dire è che ultimamente l’età media del pubblico che mi segue è piuttosto aumentata e credimi, questa cosa mi fa volare. Non perché non voglia prendere i ragazzi più giovani, ovviamente. La realtà è che voglio parlare a tutti. E oggi è più facile farlo. Oggi è più facile incontrare trentenni che hanno una solida cultura in fatto di rap – o che sono disposti a farsela, senza pregiudizi. Questa, te l’assicuro, è una bella motivazione. Io infatti voglio parlare prima di tutto alle persone della mia età – inevitabile, visto che nei miei testi parlo essenzialmente di me – e vedendo che al mio crescere anagrafico corrisponde anche una crescita anagrafica del mio pubblico, beh, è una cosa che mi fa molto piacere. Mi rassicura. Magari per un quattordicenne oggi risulterò un po’ palloso? Può essere, non c’è problema: vuol dire che mi capirà meglio fra qualche anno.
Tutto bello, ma comunque il prodotto-Nayt deve funzionare. Immagino ci siano delle aspettative attorno a te: dal tuo team, ma anche e soprattutto da chi investe su di te. Quanto pesano? Quanto invece riesci a non pensarci?
Guarda che le aspettative su di me le metto essenzialmente io stesso. Mi bastano quelle, non servono altre. Io la mia visione da artista la voglio non solo condividere, la voglio in qualche modo pure imporre. Voglio insomma diffonderla il più possibile. Voglio essere ascoltato. Non ho timidezze, su questo. Tutto ciò però per un motivo ben preciso: che non è il successo in sé, ma il fatto che il tipo di persone che rappresento sente di avere davvero qualcosa di da dire, e vuole essere finalmente ascoltato. Io parlo per loro. E se non mi ascolterete abbastanza, io alzerò ancora di più la voce.
Ecco: andresti a Sanremo, a proposito di essere ascoltati il più possibile e di diffondere la propria voce sempre di più?
Solo se ci fosse il progetto giusto. (Fa una pausa, nda) E in realtà anche se ci fosse, il progetto giusto, nemmeno lì sarei sicuro di volerci andare, a essere sincero. Non è Sanremo di per sé, il problema; il problema è quello che si crea attorno ad esso, quello che a un certo punto viene richiesto dall’ambiente esterno agli artisti una volta che sono lì al festival. Oggi il pop sembra ricercare sempre più dei messaggi semplificati. Sembra ricercare quasi solo i meme, ecco. Guarda: per me i capi del mondo sono Colapesce e Dimartino, perché sono stati in grado di costruirsi una poetica che, usando intelligentemente l’ironia, gli permette di essere quasi dei meme da un lato e di veicolare invece dei messaggi molto profondi dall’altro. Lo trovo geniale. La loro è una formula perfetta per essere a Sanremo con un senso. Io se andassi al festival non riuscirei a fare altrettanto, non è la mia cifra, non ho quel tipo di ironia, di leggerezza. Non so insomma se farei bene, ad andarci. Diciamo che sarebbe da valutare, ecco…
Habitat è un disco profondamente, anzi, direi quasi ossessivamente personale, introspettivo. Lo stesso si può dire per Doom e Mood. Quand’è che invece ti verrà la voglia di raccontare qualcosa che non sia te in prima persona, i tuoi pensieri, i tuoi dubbi, le tue rabbie?
Sto iniziando a interessarmi più agli altri, credo che nelle interviste che farò prossimamente lo si noterà. In realtà è già da tempo che, a livello di testi, vorrei spostarmi di più verso l’esterno, verso il raccontare storie che non riguardino solo me stesso. Ma prima dovevo mettere le basi: raccontando in massima onestà chi sono davvero. Ora che ho imparato a farlo e l’ho messo, credo, bene in pratica, probabilmente posso essere più credibile se inizio a parlare anche di altri. È un processo ben preciso e vero, potrebbe essere arrivato il momento di iniziare a raccontare storie non più in prima persona.
E finalmente avremo una Anna e Marco di Nayt, non più solo autobiografia introspettiva…
(Sorride) Lucio Dalla è un artista immenso, una leggenda. Questo accostamento mi onora. È da vedere se ne sarò mai all’altezza.
Intanto però non ti neghi scelte controcorrente e pure un po’ ambiziose, tipo presentare l’album con un cortometraggio di piglio cinematografico e un po’ sperimentale di una quindicina di minuti…
Ci abbiamo lavorato sopra almeno un anno, e con non poche difficoltà. Ad esempio, a convincere la casa discografica dell’opportunità di una scelta del genere. Io li capisco i discografici, eh. Ma resto convinto che sia profondamente necessario ogni tanto pensare fuori dagli schemi e fuori dalle convenienze. Fare sempre e solo il compitino alla lunga appiattisce l’arte. Non sono ingenuo e non voglio dare colpe a nessuno, men che meno alla mia casa discografica: so che sarebbe stato molto più immediato ed efficace puntare, con lo stesso budget se non addirittura con un budget minore, su un video breve che fosse legato a un brano preciso del disco, quello magari con più potenziale da hit. Ma se fai sempre quello che è giusto, finisci con lo spegnerti. Io ho bisogno dello scontro, del rischio. Perché non credere: a fare un cortometraggio di 15 minuti, il rischio ce lo metto pure io. Se esce fuori male? Se è una cosa brutta? Sono io che ne rispondo. È mia la faccia che si sputtana. Credo però che inseguire la qualità sia una scelta fondamentale. Perché per espandere i numeri c’è sempre tempo. E io numeri li espando, alla lunga; solo con altre vie. Bisogna fidarsi di me.