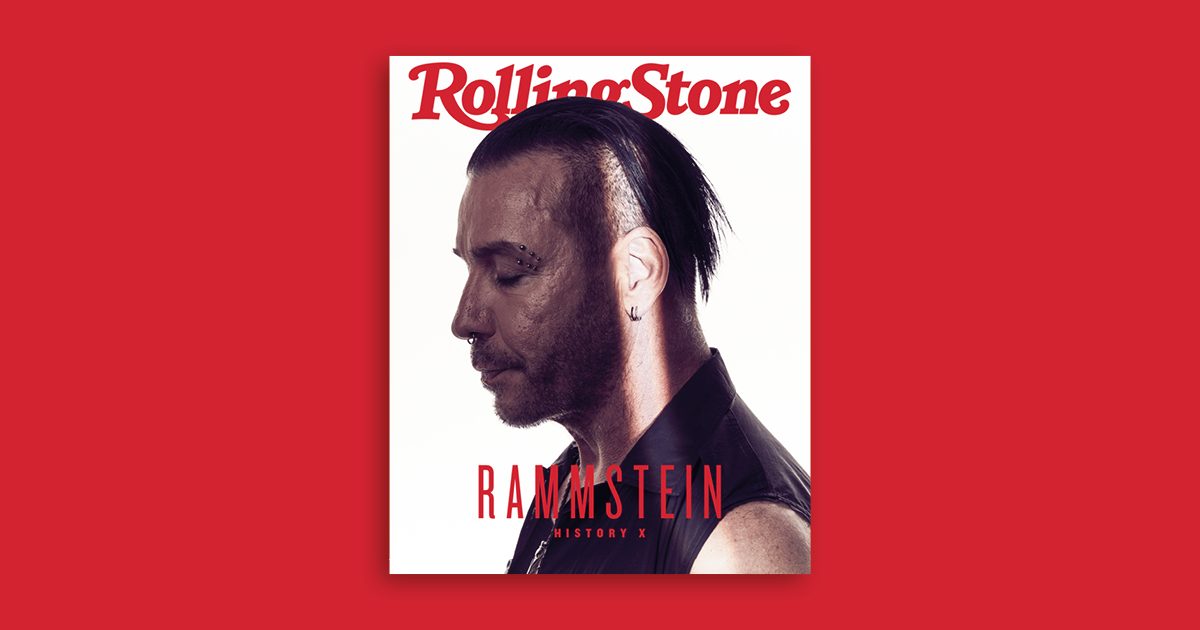State alla larga dai Rammstein, perché potreste bruciarvi. Vesciche, ustioni di terzo grado e tutto il pacchetto completo. Nel peggiore dei casi, sareste inceneriti dal lanciafiamme che Till Lindemann sfoggia normalmente sul palco. In alternativa, dalle fontane di fiamme montate sulle ali di metallo che indossa per Engel. Non è un caso che nel 2011, durante il tour di Made in Germany, la band regalasse adesivi ai fan accalcati sotto il palco: “Sono sopravvissuto alla prima fila di un concerto dei Rammstein”.
Ma che significato hanno le fiamme? Forse sono un simbolo abusato. Rammstein = fuoco. Roba brutale, lanciafiamme sul palco. In realtà, la musica che fa oggi la band più famosa e controversa della Germania ha poco a che fare con il fuoco. Semmai, parla del rischio di essere bruciati. Dell’attimo che precede l’ustione.
I Rammstein sulla copertina digitale di Rolling Stone
«Non vogliamo scioccare le persone», dirà Flake alla fine di quest’intervista. «Vogliamo provocarle, accenderle». Okay. In ogni caso, prima di incontrare i Rammstein è bene assicurarsi che da qualche parte ci sia un divieto alle fiamme libere. Nel nostro caso, uno studio fotografico a Tiergarten, Berlino, per fortuna è così. È un solare, orrendo mercoledì mattina di primavera. L’occasione è il loro settimo album, il primo dopo un decennio di attesa: eoni, per una band. Ma chiunque sia ancora (più o meno) vivo, oggi, prima o poi torna.
Tiegarten. Il cartello sulla porta dice “Shooting dei Lunik”. Un nome in codice: i rider sanno dove andare, gli Instagrammer no. Nemmeno i giornalisti: questa intervista è un’occasione rara, perché i Rammstein sono noti per non amare la stampa. Ormai comunicano con il loro pubblico direttamente, con documentari, making of, eccetera. I tour promozionali di una volta, con tutte quelle interviste a raffica, finivano per snervarli, spiega Flake prima di incenerire il buffet della colazione. È un peccato, perché messi all’angolo i Rammstein sono eccezionali narratori di loro stessi.
Il primo ad arrivare è Paul Landers, chitarrista, co-fondatore della band antenata dei Rammstein, i Feeling B. Ex ragazzino della Germania Est, ora, a 54 anni, è il più vecchio del gruppo dopo Lindemann. Nello studio suona il rock ‘n roll di Little Richard e Jerry Lee Lewis. Sul suo piatto della colazione svetta una pila di carne macinata e crostini. Tanti crostini. Ne mangia un pacco al giorno, una leccornia extra croccante che importa dalla svizzera. Un vizio innocente. «Mi tatuerei un crostino sulla schiena», dice coperto di briciole. Per fortuna, non ci sente nessuno.
Prima domanda. Cosa avete fatto per tutto questo tempo? «Ci eravamo presi un anno di pausa. Sai, per non andare fuori di testa, per vivere», attacca Landers. «Poi ci siamo ritrovati e ci siamo detti: Dai, un altro anno». Il secondo tentativo non andrà a buon fine. «Problemi personali, tasti dolenti. Era difficile stare nella stessa stanza tutti insieme». Quando si vedono per la terza volta, era già il 2015. «Tra me e me pensavo, Gesù, sarebbe bello farla finita adesso», dice. «Ma non potevamo fermarci. Volevamo dare al mondo almeno un altro album».
Così hanno cambiato tutto: produttore, studio, approccio e via dicendo. Un ritorno alle radici, all’antica ragion d’essere. Sedie a semicerchio tipo alcolisti anonimi, o Beatles 1969. «Ci è voluta un’eternità, è stato tutto abbastanza estenuante».
L’album omonimo suona come una catechesi. Un viaggio verso l’oscurità, una corsa a ostacoli. Roba già sentita, dirà qualcuno. In realtà, Rammstein è un distillato, qualcosa che arriva al punto come mai prima. Ci sono i classici: la mistificazione della violenza religiosa (Zeig Dich), la carne e la bellezza (Tattoo), i traumi infantili (Puppe), il sesso (beh, Sex). C’è tanta trasgressione e tante perversioni fisiche e mentali, divagazioni. Ci sono uomini che diventano animali, a volte per un attimo, a volte per sempre. Le novità: il rapporto con la patria (Deutschland, ci arriveremo), l’infanzia nella Germania Est (Radio, la versione socialista dei Queen). Rammstein è un’autobiografia del presente, di un dolore che viene da lontano. Till Lindemann canta le litigate nelle birrerie, le proteste, i social, la patria, l’identità, l’abuso di potere. In Mein Land canta di migrazioni, nazionalismo. Non esiste una prospettiva confortante da cui ascoltare le canzoni dei Rammstein. È una discesa nell’abisso, nel regno del narcisismo.
La copertina del nuovo album raffigura un fiammifero su sfondo bianco. Spento. Può sembrare un’intimidazione, un avvertimento. Ma il fuoco non c’entra. Qui c’entra il pericolo. La minaccia con cui tutti dobbiamo fare i conti, come singoli e società, finché esisteranno i fiammiferi.
Forse è il loro lavoro migliore, ma se ne accorgeranno in pochi: attorno ai Rammstein c’è un disagio, una scomodità che sconfina nell’ansia politica. Per l’opposizione sono una band marziale, machista, con chiare simpatie verso l’immaginario del totalitarismo. Succede quando ci si occupa della violenza e delle sue conseguenze non in maniera introspettiva, ma con grandi gesti, atteggiamento sovversivo, travestimenti e bizzarrie varie. «I Rammstein non alimentano l’ideologia del totalitarismo con l’ironia», scrisse il filosofo neo-marxista Slavoj Žižek in un famoso articolo per Die Zeit. «Affrontano quei rituali con una fisicità oscena, rendendoli innocui». Potremmo aggiungere che chi critica l’arte dei Rammstein dimentica due cose. La prima: l’artista e la sua maschera non sono la stessa cosa. La seconda: mai pensare che il pubblico sia più stupido di te.
Richard Z. Kruspe sta fumando una sigaretta alla finestra del suo minuscolo camerino. La Marlboro brilla nel buio. «Questo album ci ha riportato dove abbiamo iniziato», dice. «Abbiamo fatto un giro completo. È la fine, e un nuovo inizio. Quello che manca adesso è una prospettiva positiva, una speranza. Ma al momento non c’è. Magari le cose cambieranno. Il mondo si muove in fretta».
«Ai Rammstein manca un elemento: la leggerezza, proprio quello che Olsen [il nuovo produttore, in passato fonico live della band, ndr] ha portato a questo disco», dice. La differenza si sente. Il sound è più fresco, e sembra che a suonare ci sia una vera band. In passato, guardando i video e i concerti, si riusciva a cogliere solo l’ironia, i giochi e gli eccessi della scena metal e gotica tedesca anni ‘90. Ora la loro musica ha una dimensione intima, anche se per trovarla bisogna impegnarsi un pochino.
C’è una canzone, nel disco, che ha richiesto una cura particolare. Un classico “a là Rammstein”, ma con una vena stranamente malinconica. Nella demo, Kruspe urla “Madre!”. Pensava alla sua famiglia, mentre la scriveva. Quel dettaglio è rimasto, ma la band aveva già pubblicato una canzone intitolata Mutter, nel 2001. «A un certo punto, qualcuno ha detto di cantare la parola “Germania”, di trasformarla in una canzone sul nostro paese», dice Christoph Schneider. «Ci siamo detti: possiamo fare una canzone del genere? Funzionerà? Non è facile, ma Till ce l’ha fatta».
Foto di Jens Koch
Oggi, Deutschland non ha bisogno di presentazioni. 57 milioni di visualizzazioni su YouTube, 38 milioni di stream su Spotify. Se ne parla alle feste, ai pic-nic, al bar. In questo momento, qualcuno starà per schiacciare il tasto play su una qualsiasi piattaforma streaming. “Il tuo amore è una maledizione e una benedizione. Germania, non posso darti il mio amore”.
Non serve spiegare perché una canzone del genere, scritta dai Rammstein, abbia fatto scattare così tanti campanelli d’allarme. Pensate al video di Stripped, 22 anni fa, con gli estratti dei film di Leni Riefenstahl [La regista che firmò buona parte del cinema di propaganda nazista, ndt]. La questione del totalitarismo nell’arte, su quanto un musicista debba prendere le distanze dalle sue opere, riemerge di continuo, di solito dalla penna di filosofi e vecchi intellettuali imbolsiti. Per i Rammstein, è storia vecchia. Negli anni ‘90, all’inizio della carriera, l’etichetta Motor Music chiese alla band di aggiungere all’artwork del CD un simbolo di “divieto di svastica”. La band rifiutò. Perché avrebbero dovuto scusarsi per qualcosa con cui non avevano nulla a che fare? Oggi anche una celebrità di serie C ottiene buona pubblicità con qualche foto in una campagna anti-nazista. I Rammstein non possono essere accusati del contrario.
“Vuoi che il mio cuore sia al posto giusto / Ma guardo giù, e batte a sinistra”, cantava Lindemann in risposta allo scandalo Riefenstahl. Una dichiarazione necessaria. Così come Deutschland, la canzone di una band di Berlino Est che, dopo un lungo periodo di pausa, osserva una nazione in cui i neo-nazisti organizzano cortei protetti dalla polizia, gli ebrei temono per le loro vite e c’è chi fa e poi ritratta dichiarazioni incredibili. In altre parole, la Germania del 2019 è un soggetto perfetto per le canzoni dei Rammstein. «Una cosa è chiara: abbiamo toccato un nervo scoperto, abbiamo mosso qualcosa», dice Schneider. «Penso che sia un bene che venga vista come un brano a se stante. E sono contento che il disco non si chiami Deutschland».
Prendo il telefono e chiamo Specter Berlin. È un noto creativo di Berlino: nel 2001 ha fondato l’etichetta Aggro Berlin e, per farla breve, ha inventato l’identità visiva del rap tedesco. Poi, all’inizio del 2019, ha girato il suo primo video rock: Deutschland dei Rammstein. «Quando l’ho sentita la prima volta sono scoppiato in una risata nervosa», dice. «Ho pensato: questa è la canzone che stanno tutti aspettando sull’impossibilità di amare la Germania». Girare il video è stato difficile. Mettere insieme i vari elementi storici – la battaglia di Teutoburgo, le crociate, il Terzo Reich, la RAF, la Germania dell’Est, la Stasi – ha richiesto settimane di lavoro. Poi, quando Specter ha presentato il concept, la band era su di giri.
L’unica preoccupazione era sulla guerriera che doveva rappresentare lo spirito tedesco. Nella prima bozza di sceneggiatura era una bionda, occhi azzurri, stereotipo della donna teutonica. L’idea di trasformarla in una afro-tedesca ha messo fine a tutte le preoccupazioni di Specter. Prima di pubblicare, ha suggerito di postare un teaser con la scena del campo di concentramento. «Quando gli artisti citano le sofferenze delle vittime della guerra in questo modo, per me è un segnale enorme», dice. «Alla fine appare la parola Deutschland, come un necrologio. Non so come la gente possa interpretare male il significato».
È successo. La clip, 35 secondi, mostra la band con la divisa di un campo di concentramento, sul petto la stella di David dei prigionieri ebrei e il triangolo rosa di quelli omosessuali. Alla fine appare la parola Deutschland. Questo è tutto. Rappresenta una nazione inestricabilmente legata all’atrocità e al senso di colpa. Ma è anche una campagna pubblicitaria. «Perché i membri della band non indossano le uniformi delle SS?», si chiedeva il direttore dell’International Auschwitz Committe. Non aveva modo di sapere che era esattamente ciò che i Rammstein avrebbero fatto nel video completo. Molti commentatori, dal Concilio Ebraico Centrale di Germania all’osservatorio sull’antisemitismo, non hanno provato neanche a decifrarne il significato. Non importava a nessuno: non è mai accettabile usare un simbolo pesante come l’Olocausto per pubblicizzare una cosa leggera come una canzone.
«Non pensavo che ci sarebbe stato questo clamore», dice Schneider. «La scena non si prende gioco di niente. Per qualcuno vedere i Rammstein sulla forca è una provocazione. A posteriori, ne abbiamo discusso. Era giusto? Potevamo fare diversamente? Per me no».
Due giorni dopo, quando è uscito il video completo, la risposta del pubblico è stata molto più positiva. Alcuni erano entusiasti per la bellezza della regia, altri per l’intelligenza con cui i Rammstein citavano i topos della storia tedesca ribaltandoli con particolari alienanti e disturbanti. Una delle poche stroncature è arrivata dal quotidiano di estrema destra Junge Freiheit: «Non c’è nulla di più sbagliato che accusare i Rammstein di germanomania. Non sono in grado di rapportarsi alle proprie radici in maniera normale». Per lo Zeit Online, invece, «persecutori e vittime, crudeltà ed empatia, freddo cinismo e umiltà, fascismo e antifascismo si uniscono in una cosa sola».
La musica dei Rammstein non regala quella sublime quanto inutile sensazione di benessere che deriva da chi si sente al 100% nel giusto. Apprezzarla è insidioso. Potevano evitare di pubblicare la scena del campo di concentramento, così da evitare che la gente pensasse che si fossero rappresentati come vittime? Certo, ma non avrebbe aiutato. Il loro coraggio, la loro capacità di prendersi dei rischi fa parte della loro identità artistica. Finché saranno gli unici a esserne danneggiati, i Rammstein non faranno concessioni a nessuno. È così che vogliono essere visti. Giocano coi fiammiferi finché tutti non si rendono conto di quanto sia vicino il fuoco.
Tiegarten. Flake Lorenz prende posto in camerino. Nei concerti fa la spalla comica del macellaio Till Lindemann. È uno che pensa alle cose in profondità. «Quel trailer era importante per mostrare al pubblico quanto sia facile indignarsi senza conoscere il contesto», dice. «Non è male chiedersi, ogni tanto, perché siamo tutti così suscettibili quando si parla di Germania. È questo che volevamo dimostrare».
Ma perché la Germania? Perché adesso? «Il video mostra perché abbiamo un rapporto controverso con il nostro paese. Non volevamo fare una canzone banale, i Rammstein non chiamano i poliziotti maiali, non urlano fanculo alla Germania! Siamo artisti, giochiamo con questi temi costruendo metafore, non slogan».
Il fatto che siano originari della Germania Est dà al pezzo una nota sofferente unica nel genere. «Siamo cresciuti come cittadini di una nazione che non esiste più: c’è una ferita nelle nostre biografie», dice Flake. «Per questo siamo andati a fondo: non è un problema solo nostro. Questa ricerca d’identità è comune a tutta la Germania. Se la osservi da vicino, questa è una storia di violenza, guerre, sofferenza. È interessante, soprattutto se pensi che oggi la gente va per le strade di Chemnitz a urlare slogan nazionalisti» [Chemnitz, un tempo parte della Germania Est, è stata al centro di una dura manifestazione dell’estrema destra: caccia all’immigrato e danneggiamenti di massa inclusi, ndt]
Con i Rammstein funziona così. Da una parte la loro arte è più concreta di quanto vorresti. Scelgono parole cariche di significati pesantissimi e le trattano come giocolieri, esponendosi alle critiche. Hanno un immaginario mitologico, troppo controverso. Dall’altra, come diceva Freud, usano il gioco per rielaborare esperienze negative. Pongono domande, indicano contraddizioni, ma non offrono risposte certe. Una band perfetta per tempi infuocati, insomma. «Il nostro non è intrattenimento, è l’opposto», dice Flake. «L’intrattenimento è la fine dell’arte. Meglio smettere».
Ma il terreno delle provocazioni, oggi, non è diventato troppo insidioso? «È sempre stato così», dice Flake. «Lo facevano gli Stones. Lo facciamo noi. Tra 25 anni ci sarà qualcun altro». Al centro del rogo, incolume. Con la lingua nelle fiamme, senza dolore.
***
Crediti
Fotografo: Jens Koch
Stylist: Alexandra Heckel
Assistente Stylist: Maya Lu
Traduzione dal tedesco: Lucy Jones
Traduzione dall’inglese: Marta Blumi Tripodi
Editing: Andrea Coclite e Claudio Biazzetti