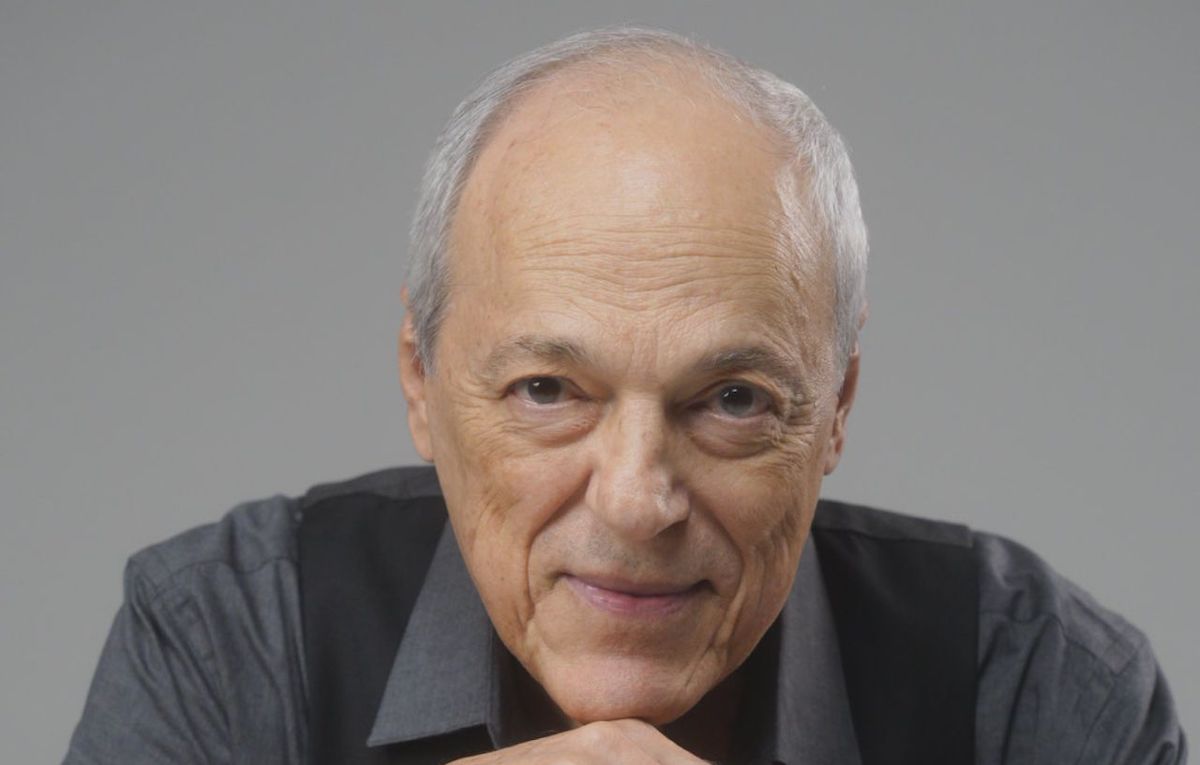Roma, i gabbiani hanno rimpiazzato i piccioni, sono passati quarant’anni ma Antonello Venditti è sempre qui. Con i capelli lunghi, gli occhiali a goccia, le sigarette, la casa nel cuore di Trastevere. Suona la tastiera con la stessa forza di quando da ragazzo si presentò da solo al Folkstudio, col pianoforte sulla spalla e uno stile tutto suo, irriproducibile e sghembo.
«Il segreto? Non aver mai suonato in maniera classica. Senza questo stile nulla sarebbe stato così, nessuna di queste canzoni sarebbe nata. Al Folk ero un pianista che doveva trovare sintonia con un gruppo di chitarristi. Con la voce robusta perché quel piano era poco amplificato. Inventai un mio modo, adattando la tecnica alla voce, un finger picking da tastiera, un piccolo trucco nei rivolti degli accordi. Tutto cominciò così».
E allora eccoci qua, quarant’anni dopo Sotto il Segno dei Pesci, album iconico, uscito l’8 Marzo 1978, otto giorni prima del rapimento Moro, in pieni Anni di Piombo. Da subito un successo straordinario.
Ricordo le file nei negozi di dischi e il fermento di quegli anni difficili. Al Giulio Cesare c’era la polizia tutti i giorni. Gli inseguimenti, la coda di una guerra civile mai avvenuta. Io avevo dei lineamenti particolari e i poliziotti mi fermavano quasi tutte le sere. Barba e capelli lunghi. A Roma dicevo “So’ Antonello”, al nord “Sono Venditti”, e dopo qualche minuto mi lasciavano andare. Quel clima comincia nel 1974. Ma dopo il rapimento Moro, contemporaneo all’uscita del disco, la tensione cresce ancora di più. Io intanto stavo diventando famoso.
Merito soprattutto della canzone che dà il titolo al disco. Ho sempre pensato a Sotto il Segno come alla tua Thunder Road, uno dei tuoi simboli assieme a Notte Prima degli Esami e Compagno di Scuola. È così?
Certo. Nel gruppo metterei anche Che fantastica storia è la vita. Sono le canzoni che hanno uno snodo generazionale, che legano l’attualità al passato e per questo piacciono soprattutto ai ragazzi di oggi. In Sotto il segno c’era la voglia di cambiare e l’inquietudine di quella generazione. La piazza reale, non quella virtuale dei social network di oggi, con i loro processi sommari e le loro improvvise bufere.
Già, in quegli anni non c’erano gli haters ma in compenso dovevi sfidare la censura. Ti hanno anche dato sei mesi di condanna.
È successo nel 1974. Una storia che oggi sembra piuttosto ridicola. Sei mesi per aver scritto, nella canzone A Cristo: “Ammazzate Gesù Cri’, quanto sei fico”. Tra l’altro in quel periodo dovevo andare in America per incidere Buona Domenica. Ce so’ arrivato comunque, attraverso altre frontiere, messicane…
Pensa quando avranno sentito Sara…
Quello fu un doppio tabù. Erano gli anni del femminismo duro e puro. La canzone si prese molte critiche proprio da quegli ambienti. Alcuni la interpretavano come un’espressione di maschilismo. Per me era il contrario. Sara è dalla parte delle donne e della loro libertà. Quella di portare a termine la gravidanza anche se non sei sposata e non sai se quel figlio avrà un padre. È tratta da una storia vera. Sara la conosco bene, è ancora viva, non si chiama così, ha avuto tre figli con tre uomini diversi e ho il fondato sospetto che sia felice.
Io però sono pazzo di Giulia e dei suoi occhiali sul naso. Anche lei è realmente esistita?
Certo, e anche lei poteva essere censurata, ma fortunatamente non l’hanno capita. Era una femminista, mia rivale nell’amore di una ragazza. Ovviamente io ho perso e lei ha vinto. La ragazza che amavo scelse lei. “Giulia ci sa fare, Giulia è intelligente, ha qualcosa di più”. E poi ancora, “Ti prego non portarla via da me”. Finì proprio così, ma del resto noi non capivamo niente, di amore, di sesso. Era tutto tentativi ed errori. Comunque la canzone che dovevano censurare veramente arrivò qualche anno dopo. Invece la lasciarono in pace. Era Dimmelo tu cos’è.
Ah già, “scopare bene, questa è la prima cosa…”
Figurati. Roba assurda per quegli anni. Ma era così vera che nessuno la toccò. Mi ricordo che quando Falcão arrivò in Italia, lui che veniva dal cattolicissimo Brasile, era piuttosto sorpreso. “Antonello, ma che strano Paese l’Italia, si può dire, “scobare bene?”.
Nel disco c’è anche Francesco, dedicata a De Gregori. C’è una lunga letteratura sui vostri rapporti, tra amicizia e rivalità.
Francesco lo frequento da anni. Ultimamente in maniera molto assidua e affettuosa. Abbiamo avuto varie fasi, ma la telefonata e l’affetto non sono mai mancati. La stampa ha contribuito a un sacco di leggende metropolitane, tipo Coppi e Bartali. Per esempio, il pianista di Pianobar non sono io. Chiedeteglielo pure.
Cosa ti piace di lui?
Tutto. Soprattutto le canzoni nascoste tipo Atlantide o Pezzi di vetro. Hanno una struttura complessa, come Modena o Lo stambecco ferito. Con Francesco ho vissuto una vita parallela, abbiamo discusso e ci siamo chiariti, l’ho portato allo stadio tante volte, abbiamo visto il mitico derby del 5-1, quello del cucchiaio di Totti, in camera mia perché il televisore in salotto si era impallato.
Che cos’è per te la squadra? E quanto sono importanti le canzoni che le hai dedicato? La Roma è un fatto di famiglia. Mio zio fu uno dei fondatori. Quando è morto a nemmeno 50 anni sentii il bisogno di esternare la mia passione. E poi della Roma amo il legame con la città, l’identificazione, il nome. Nel 1900 quelli che fondarono la Lazio potevano chiamarsi “Roma” ma non lo fecero. Il punto è tutto lì. Lo dico col massimo rispetto per gli amici laziali, ne ho moltissimi. Li ritengo fratelli, non cugini. Ovviamente Roma capoccia non è una canzone per la squadra, ma per la città. Roma Roma e Grazie Roma invece sì. Di Grazie Roma mi piace il doppio binario. C’è una prima parte per tutti, poi comincio a parlare romano e dico tutta la verità. “Me fa sentì importante anche se nun conto gnente”. Ecco, la Roma è una famiglia, è davvero il rumore delle campane la domenica mattina.
E la città come se la passa?
La bellezza di Roma rimane travolgente, un luogo dell’anima, irrinunciabile. Ma dobbiamo darci da fare, averne cura, così come Roma deve avere cura di noi. Qui nessuno rispetta niente. La sporcano tutti. Bisogna farla rinascere da cittadini, senza appartenenze. E osservarla. Ormai sono un aruspice. Come un antico romano, ho i presagi. Odiavamo i piccioni, che ormai sono spariti. I gabbiani se li sono mangiati. Roma deve rinascere ogni giorno dalle piccole cose. Per esempio, so che è una piccola cosa, ma sono orgoglioso di aver fatto mettere una targa qui dietro, per Lucio Dalla, a Vicolo del Buco, dove ha vissuto fino al 1986. Ce l’ho fatta in un anno, sconfiggendo la burocrazia. È venuta la Raggi a inaugurarla. È stato bello. E ogni anno qui, il 4 marzo, faccio una festa dedicata a Lucio.
La politica ti appassiona ancora?
La politica è una sovrastruttura. Io ho delle idee, non dei riferimenti partitici. Continuo a pensare che quando un bimbo nasce non si domandi di che colore sia o che passaporto abbia. E non capisce come la Terra possa avere padroni o frontiere. Pensa a Imagine di Lennon. Senza religioni, senza confini. È la filosofia della Terra Madre. È stato ucciso per questo, ha subito le conseguenze della politica, con la sua cappa opprimente. Quanto a me, credo solo nel futuro e non ho paura. Non sono nessuno. Non ho bisogno di un leader, non voglio adepti. Ho idee. Chi ci sta, sta con me.
C’è qualcuno dei politici di oggi a cui potresti dedicare una canzone, come facesti con Dolce Enrico per Berlinguer?
No, per una ragione tecnica. A Berlinguer l’ho dedicata anni dopo la morte. Oggi non ci sono termini storici per dedicare qualcosa a qualcuno. Me lo auguro, in fondo, perché vorrebbe dire che qualcuno nei prossimi anni sarà in grado di far crescere davvero questo Paese. Enrico era dolce ma aveva carattere, un vero leader, capace di tenere la schiena dritta anche a Mosca. Un visionario, assieme ad Aldo Moro, che pagò con la vita.
La canzone politica ha ancora senso?
Certo. I rapper fanno canzoni politiche, a Roma ce ne saranno cento di buon successo. Tutto quello che racconta la realtà è politica e va molto veloce, molto più dei partiti. Per esempio io credo che il popolo della sinistra esista ancora. Ma chi lo rappresenta non ha niente a che vedere con quella realtà. Il PCI e i DS, già parecchi anni fa, rinunciarono alle periferie.
Torniamo al disco. Altre tracce mitiche. Bomba o Non Bomba, Chen il Cinese, il Telegiornale.
Cominciamo da Chen, che racconta il passaggio dalla marijuana, droga leggera, “conviviale”, alla disperazione solitaria dell’eroina. Fu uno dei passaggi più tremendi di quella generazione. Il Telegiornale è divertente perché è una canzone ironica e preveggente sul ruolo dell’informazione h24 e il suo peso. In Odeon, un programma molto seguito, mi divertii a disturbare Mario Pastore, conduttore del TG2. Quanto a Bomba non Bomba, hai mezz’ora di tempo per parlarne?
Certo, da dove cominciamo?
Partiamo in due, io e De Gregori, per un viaggio reale e metaforico. L’obiettivo era la rivoluzione e la musica. A Sasso Marconi incontrammo una ragazza. È il mondo radicale, quello che il PCI del tempo guardava con sospetto. Io invece sono sempre con loro. Molte delle nostre libertà civili le dobbiamo al Partito Radicale, vedi anche in questi giorni quello che sta facendo Cappato sul fine vita. A Roncobilaccio ci venne incontro un vecchio partigiano, “qui non è una passeggiata”, attenti alle vostre rivoluzioni. A Firenze c’era quell’intellettuale con la faccia giusta. Una preveggenza del renzismo? Chissà. Man mano nella canzone la rivoluzione prende forza, cominciamo ad attirare le simpatie del Sindaco, “noi siamo tutti con voi”, fino all’arrivo a Roma, dove finalmente ci fecero suonare, con il vino rosso e l’utopia di una fratellanza vera.
L’utopia e la felicità, violenta e tenera.Il cane mi salta addosso. Vuole giocare. Dalla finestra il traffico lento del Lungotevere. Fuori piove. Dentro Antonello pesta il piano, rivolta gli accordi e canta, come sempre.