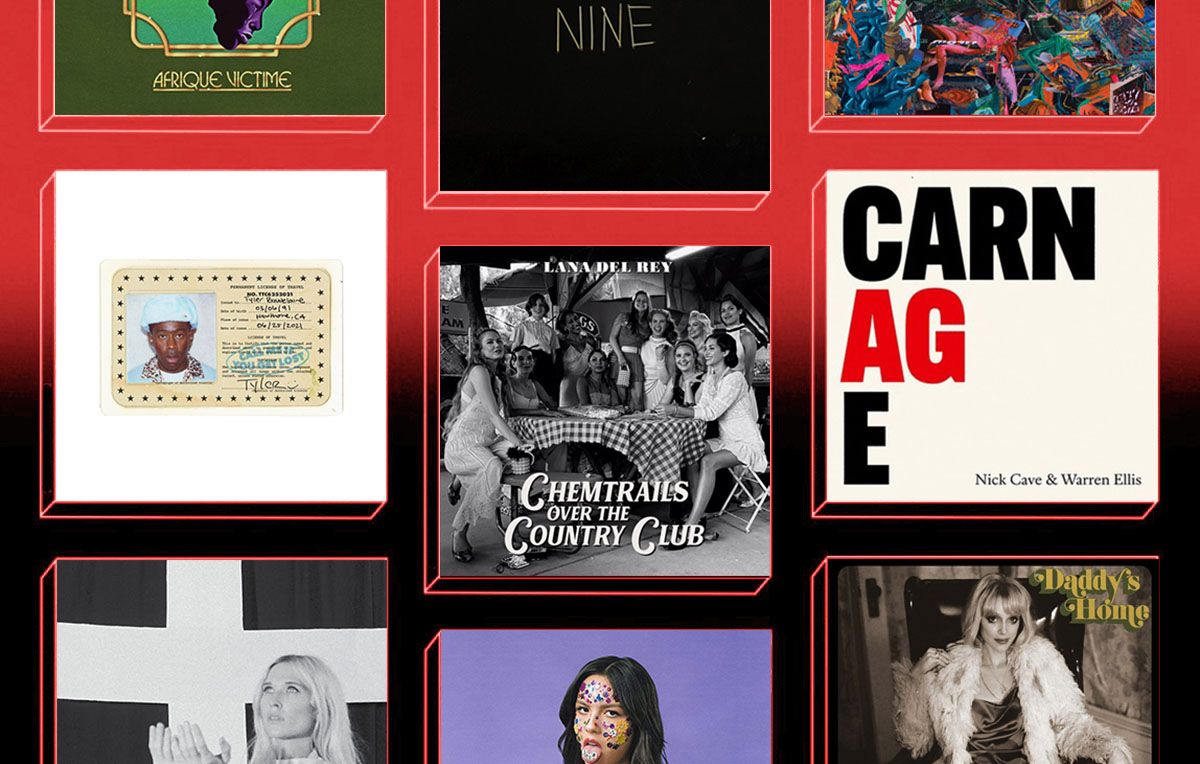Come già era successo ai Black Country, New Road, anche per gli Squid il secondo album (uscito lo scorso venerdì) marca un distacco molto netto rispetto al primo. La cosa curiosa che ancora accomuna le due band è la loro appartenenza un po’ lasca al cosiddetto filone del revival post punk; e se per i dischi d’esordio la definizione andava un po’ stretta a entrambi, tali e tante erano le influenze che li segnavano, per i successivi possiamo archiviarla senza troppi retropensieri.
La differenza sostanziale tra le due band è che se nel caso dei Black Country, New Road il cambio stilistico era inevitabile, poiché dovuto al fatto che il leader Isaac Wood, cantante e compositore principale, aveva lasciato il gruppo, per gli Squid si tratta all’apparenza di un processo evolutivo del tutto naturale. O Monolith, che esce come il precedente su Warp, è molto più ombroso e riflessivo, e per certi versi più ostico, rispetto a Bright Green Field, e vira in chiave psichedelica le intuizioni nervose e urgenti dell’esordio. La band che sembrava avere una marcia in più tra tutte quelle della scena post punk è praticamente diventata un’altra cosa, e gioca in un altro campionato. Ed è proprio da questa constatazione che iniziamo l’intervista a Louis Borlase, uno dei chitarristi della band.
Louis, ormai credo che si possa dire che l’etichetta post punk per gli Squid sia stata un misunderstanding sin dall’inizio.
Sì, sicuramente suona come un termine fin troppo abusato, buttato lì per semplificare. Posso supporre che ogni tipo di classificazione sia usato per creare un collegamento tra la gente e la vasta rete di musiche con le quali è coinvolta. In questo senso le capisco, ma troppo spesso diventano un modo per eccedere in semplificazioni e mettere insieme le musiche più disparate, che magari non c’entrano nulla una con l’altra.
Ho sempre pensato che più che al post punk, termine usato per classificare un sound che richiama grosso modo Fall, Joy Division e Gang of Four, gli Squid potrebbero eventualmente essere ricondotti a un termine molto più generale come new wave.
Magari sì, ma questa abitudine di convogliare per comodità artisti diversi in una stessa scena comporta il rischio di perdersi dei pezzi. Il fatto è che il pubblico è una cosa, i performer sono un’altra. Ci sono molte false credenze in giro. Ad esempio, la gente dice sempre che gli Squid si sono fatti le ossa nella scena di Windmill, cosa che è vera solo in parte: ancor prima di suonare a Londra (la band è originaria di Brighton, ndr), abbiamo suonato a lungo in jam interminabili con altri amici, anch’essi musicisti, e con un’impostazione completamente diversa da quella di Windmill. Nei primissimi giorni in cui suonavamo, l’esperienza era molto più collaborativa e c’era molta condivisione della musica tra gente con capacità completamente diverse, senza gerarchie, giusto per il gusto di partecipare e di jammare insieme.
Veniamo allora alla musica degli Squid e a quella di O Monolith in particolare. Una cosa che si nota subito come marchio di fabbrica è l’impiego di ritmiche sovrapposte e molto particolari, tempi dispari e così via. A me questo piace molto, ma non pensate che mettere in apertura una canzone in 7/8 possa essere un po’ disorientante?
Sì, in effetti Swing (In A Dream) ha questa ritmica in sette che può apparire inconsueta, ma quello che ci interessava era proprio portare un elemento nuovo nel pezzo, in aggiunta a un classico pattern in quattro. I poliritmi ti danno una sorta di illusione che il pezzo sia stato costruito con un beat elettronico per il dancefloor, avendo al contempo un setup tradizionale di un pezzo in sette, e verso la fine c’è una specie di grande rilascio e la struttura passa in 6/8. Il progetto deriva dalla nostra fascinazione per certe poliritmie e la modulazione metrica come aspetto centrale, provando poi a renderle accessibili all’ascolto. Ci può venire in mente una cosa del tipo «non abbiamo mai provato a fare un pezzo in 5/4, vogliamo vedere come viene?».
Certo, ma quello che fate molto bene è rendere queste ritmiche senza dare l’impressione di avere a che fare con un pezzo troppo ostico o inaccessibile. C’è la sensazione di una qualche stranezza, ma non al punto di rendere l’assimilazione difficoltosa.
Mi fa piacere sentire quel che dici, vuol dire che siamo riusciti nel nostro intento. Non abbiamo l’intenzione di creare qualcosa di sofisticato per il gusto di farlo, a nostro parere il math rock non ha creato niente di così interessante, di fatto. Invece ci chiediamo: riusciamo a sviluppare un buon groove all’interno di strutture metriche inusuali? La sfida è quella.
I tempi dispari nel rock sono una caratteristica tipica del progressive e viene subito da pensare a quella particolare epoca degli anni ’70. In realtà nel vostro caso non mi sembra di percepire questa influenza; c’è forse un rimando in Devil’s Den, che potrebbe essere catalogato come folk-prog, mentre Green Light ricorda i King Crimson di Discipline, che però di fatto era più un disco new wave che non prog. Quindi, da dove vengono queste ritmiche particolari?
È una domanda interessante perché io sono cresciuto ascoltando molto prog, che è il genere preferito di mio padre, ma avendo sempre la sensazione che si trattasse di qualcosa di elitario, che non capivo del tutto. Allo stesso tempo mi sembrava che fosse musica genuina, che rappresentava bene la sua epoca. Come musicista mi spaventava, non mi sarei mai sentito in grado di affrontare ritmi e armonie così complesse, ero confuso. Credo però che adesso certe complessità siano diventate contemporanee. Vedo delle band intorno a noi in cui echeggiano questi suoni, quel modo di comporre, che però è ricontestualizzato e affiancato da testi attuali e moderni. È questo che ci influenza.
Forse anche gli ascoltatori sono cresciuti e non hanno più la stessa sensazione di complessità. Quello che una volta era molto complicato adesso, dopo l’esposizione a migliaia di ore di ascolto di qualsiasi cosa, è diventato fruibile.
Sì, assolutamente.
Un altro aspetto che trovo molto interessante nel vostro sound è la presenza dei fiati, della tromba in particolare, e di altre strumentazioni inusuali, come ad esempio il Fairlight (ad esempio in After The Flash). L’impiego di queste soluzioni inconsuete sarà un riferimento anche per il futuro, un modo per allargare al massimo la prospettiva?
Questo è quello che si dibatte durante il processo di progettazione di un disco, mentre si sta scrivendo, qualche settimana o mese prima di registrare. È il momento in cui ognuno rivendica le sue esigenze, ma l’aspetto cruciale è un altro. Personalmente la sfida che porto avanti è quella di trovare una convergenza tra un aspetto di sperimentazione e delle canzoni che abbiano una grande scrittura e una struttura interessante. Onestamente, penso che ci sia veramente poca musica che mi eccita e che abbia tutte queste caratteristiche. Magari c’è qualcosa che trovo molto interessante strutturalmente ma che non mi dà emozioni; e viceversa. Per tutti noi, la sfida per scrivere canzoni che ci facciano divertire è innanzitutto avere un minimo di fiducia reciproca, in modo che ciascuno possa dare il suo contributo per creare un “mostro” sul quale si possa poi lavorare.
Ho notato, su O Monolith, un certo calo della componente funky del vostro sound. Ci possono essere un paio di eccezioni, come il midtempo di Undergrowth e alcune sezioni di The Blades, però in generale mi sembra che il livello di funk sia diminuito.
Credo che dipenda da un diverso approccio alle sincopi e alle spezzature ritmiche, che in genere sono quelle che conferiscono il mood funky alla musica. Per questo disco al contrario ci siamo interessati a ritmiche di tipo motorik, più dritte e monotone, che non a beat sincopati. Questo ci ha permesso di lavorare di più su contrappunti e melodie, invece di lasciare in maggiore evidenza basso e batteria. Inoltre questo disco è stato mixato da John McEntire, mentre il precedente lo aveva mixato il produttore, Dan Carey, che notoriamente è un grande fan di basso e batteria e ama metterli in evidenza. Invece questa volta abbiamo voluto dare più spazialità alle chitarre, per esempio, e questo probabilmente ha ridotto un po’ il lato funky degli strumenti ritmici.
Un’altra dimensione importante della vostra band è il live (la data italiana sarà a Milano, in Santeria, il prossimo 19 settembre). Mi chiedo quanto sia difficile trasporre dal vivo le vostre canzoni, che come si è detto non sono semplicissime.
Molte canzoni in realtà sono già state suonate dal vivo: erano state scritte da tempo e i live sono stati utilizzati come test. In questo modo è il live che orienta la canzone dall’inizio, così non dovrà essere “ricreata” rispetto alla versione in studio. Ovviamente questo non esclude che suonare certi pezzi dal vivo sia semplice, anzi; in particolare per Ollie (Judge, il cantante-batterista, ndr), coordinarsi per suonare un tempo in sette alla batteria e cantare simultaneamente… buona fortuna! Comunque, se per Ollie è soprattutto una questione di allenamento, un altro problema è quello di trasporre dal vivo tutte le finezze di suono che abbiamo creato in studio: gli impasti corali, i legni, certe percussioni, eccetera. Lo risolviamo in genere con dei campionamenti, e confidando sul fatto che il pubblico si aspetti che non riproduciamo le versioni registrate nota per nota…
Un cenno a proposito dei testi. Rispetto al primo disco, che toccava temi anche sul piano sociale e politico, mi sembra che questa volta abbiano acquisito una dimensione più sognante, molto più personale. Che ne pensi?
Sì senz’altro, i testi di questo disco hanno una dimensione molto più spirituale, mentre Bright Green Field era uno sguardo oggettivo sulla società intorno a noi da parte dei giovani adulti che eravamo al tempo. Un aspetto positivo è stato che Ollie, che scrive la maggioranza dei testi, ha avuto una sorta di blocco dello scrittore che l’ha costretto a guardare dentro se stesso e scoprire quindi temi a un altro livello di profondità, magari nelle piccole cose, invece che sui grandi temi sociali.
Non so se dipende da questa ricerca interiore, ma l’atmosfera del disco nel complesso non è certo serena, anzi appare piuttosto inquietante. Alcuni pezzi, penso a The Blades o al break in After The Flash, sono quasi terrorizzanti. Anche questo è un cambiamento notevole rispetto al disco precedente.
Capisco quello che vuoi dire, l’atmosfera è in un perenne stato di sospensione, di forza trattenuta. Soprattutto non volevamo creare un mood troppo energico o esplicitamente urlato. E quindi è uscito questo umore buio, notturno, solo tu e nessun’altro, una sensazione di solitudine. Che forse al momento è quella che ci rappresenta meglio.