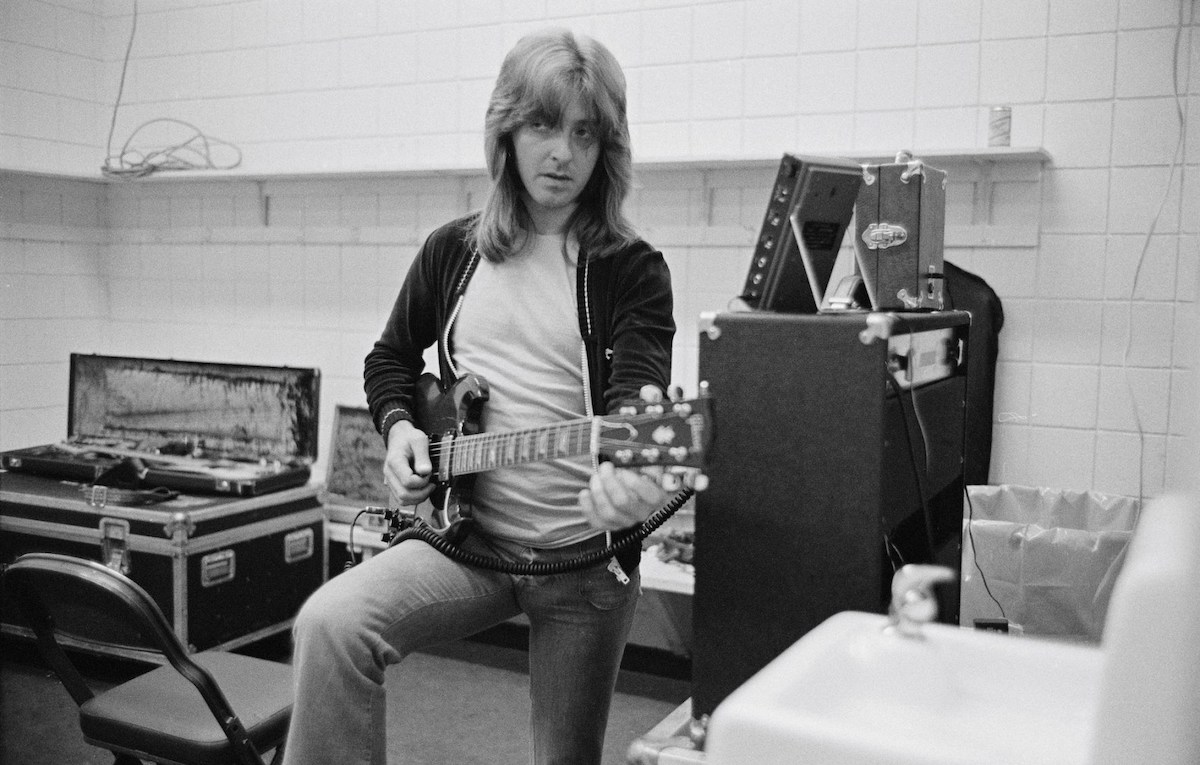Quando Tom Petty ha chiesto a Steve Ferrone di unirsi agli Heartbreakers in tour, il batterista non pensava che fosse una buona idea. È vero che aveva appena finito di lavorare con loro a Wildflowers, ma la band non era mai salita sul palco senza Stan Lynch dietro le pelli e Ferrone non sapeva come stessero le cose.
«Ho detto a Tom che mi sembrava divertente», dice Ferrone, «e gli ho chiesto che cosa stava succedendo con Stan. Gliene avevano parlato? Tom ha detto di no, che in quel periodo non andavano d’accordo. Gli ho detto che ero lusingato dalla proposta, ma avrei accettato solo quando le cose si fossero chiarite con Stan. Un paio d’ore dopo è squillato il telefono. Era Tom: “L’anno prossimo sei con noi”».
Ci è rimasto per ventidue anni: Ferrone ha suonato in tutti i dischi e concerti degli Heartbreakers fino alla morte improvvisa di Petty nel 2017. La collaborazione rappresenta una parte importante della sua carriera, ma il batterista ha suonato anche con George Harrison, Eric Clapton, Duran Duran, Paul Simon e tanti altri artisti di quel livello. Gli abbiamo telefonato, e dalla sua casa di Los Angeles ci ha raccontato il suo viaggio.
Come va la quarantena?
Bene. Ogni tanto vado al supermarket con la mia ragazza e facciamo un giro in macchina. Tutto qui. Ho capito molto presto cosa stava succedendo. Ero a New York a suonare per Seth Meyers quando tutto è andato a rotoli. È incredibile che abbia deciso, appena tornato, di fare delle migliorie al mio studio casalingo in modo da poter lavorare mentre il mio fonico è a casa sua, a Long Beach. Si è liberato dello spazio, ora posso ospitare tre o quattro persone e suonare con mascherine e distanziamento.
Partiamo dall’inizio: cosa ti ha portato a suonare la batteria?
Il tip-tap. Quando avevo 3 anni, seduto sul seggiolone battevo il cucchiaio a tempo con la musica della radio. Mio nonno, mia nonna e mia madre hanno capito che dovevano fare qualcosa. Mia nonna era una grande fan di Fred Astaire, e ha deciso di farmi fare tip-tap. È iniziato tutto così.
Chi erano i tuoi batteristi preferiti?
Non ero così fissato con la batteria. Mi piacevano i gruppi. Ascoltavo la musica. Grazie al tip-tap conoscevo gli standard come Old Black Magic e Begin the Beguine. Poi, ovviamente, sono arrivati i Beatles e i Rolling Stones. Sapevo chi ci suonava e mi piaceva la musica. Mi piacevano le canzoni. Non ero particolarmente concentrato sul batterista. Ho iniziato a interessarmene a 12 anni, quando ho ballato a un campo estivo. C’era una celebrità inglese, un tizio chiamato Max Bygraves. Faceva qualche canzone, e all’epoca il fenomeno era The Twist. Io facevo parte del coro e durante quel pezzo eravamo sul palco. Una sera ho guardato nel buco dell’orchestra e ho visto cosa faceva il batterista. Usava le due mani in modi diversi. È l’unico modo che ho per spiegarlo. Nel camerino ho cercato di imitarlo, era più difficile del previsto.
Come sei finito a suonare su Hearts and Bones di Paul Simon? Adoro quel disco.
Mi ha chiamato Nile Rodgers, voleva che andassi al Power Station. Stavano lavorando a Think Too Much. Siamo andati in studio e c’era anche Bernard Edwards (il bassista degli Chic). Praticamente vivevamo lì, all’epoca. Sono andato in studio e la batteria era pronta. L’abbiamo suonato e siamo tornati in regia per riascoltarla. Paul era dietro il banco, aveva le braccia incrociate e il mento poggiato sulla mano, come se scrutasse qualcosa in lontananza. C’era un gran silenzio. Gli ho detto che avrei potuto suonarla diversamente o qualcosa del genere. Lui ha alzato gli occhi e si è girato lentamente verso di me. «Un attimo», ho detto e me la sono svignata. Pensavo fosse finita. Bernard Edwards mi ha detto: «No, non stai come funzionano le cose qui. Succede. Resta. Non è finita».
Ero seduto fuori e sentivo che dentro stavano registrando la chitarra, c’erano un sacco di suoni strani perché la chitarra ritmica era effettata. Erano incasinati con una parte di chitarra che non era a tempo con la batteria. Poi ho sentito Nile Rodgers che usciva dallo studio gridando: «È impossibile, non ce la farà mai!». Viene verso di me e mi grida di tornare in studio, era di pessimo umore. Dovevo risuonare quella parte, insieme alla chitarra con gli effetti.
Io gli ho detto: «Neil, hai un senso del ritmo fantastico. Non sarà difficile» (ride). Sono tornato dentro e ce l’ho fatta. Quel pezzo mi è sempre piaciuto per questo motivo. Apprezzo anche Train in the Distance, mi piace come viene gestita la tensione in quella canzone.
Raccontami dei Duran Duran. Ci hai suonato all’epoca di Notorious.
Avevo un tecnico della batteria che si chiamava Artie Smith. Lavorava per me, Steve Gadd e altri batteristi. Era forte come un bue. L’ho visto sollevare un organo Hammond e gettarlo dentro un van. Sembrava un orso. Era anche un amico, non solo un tecnico. Un giorno mi ha chiamato e mi ha detto che stava lavorando in studio con John Taylor dei Duran Duran. Taylor ha detto che la band stava per tornare insieme, ma che non sapeva chi avrebbe suonato la batteria. Artie allora ha fatto il mio nome.
Sono andato in Inghilterra e in studio ci siamo messi a improvvisare, io, Taylor e Nick Rhodes. Avevamo tre o quattro pezzi. Era divertente. Me la sono goduta, ma non era il tipico sound dei Duran Duran. Poi è arrivato Simon Le Bon. Ha preso quelle canzoni, ha cambiato qualcosa negli accordi e nelle ritmiche, ha cantato e voilà, erano i Duran Duran.
Raccontami del tour. Non eri abituato a quel tipo di pubblico, ai fan urlanti…
Sì, esatto. Avevo 35 anni, ero il teen idol più vecchio in circolazione. A tutti i concerti c’erano un sacco di ragazze con i cartelloni. Quando abbiamo fatto il Madison Square Garden ce n’era una con un cartello che diceva: “Scopami, John” (ride).
Piuttosto esplicita.
Non riuscivo a capire come avesse fatto a entrare con quell’affare enorme. Me la immagino mentre si prepara a uscire con i suoi amici, poi passa davanti al papà che guarda la tv. «Dove stai andando tesoro?». «Oh, al concerto dei Duran Duran». «Passa una bella serata. Che hai sotto il braccio?». «oh, niente, è un cartello che dice: scopami John» (ride).
Poi hai cambiato un’altra volta e sei finito in tour con Eric Clapton. Com’è successo?
Bob Geldof è diventato cavaliere e sono andato alla festa in suo onore all’Hard Rock Cafe di Londra. Ero con i Duran Duran, eravamo tutti in tiro, con vestiti alla moda. La cosa assurda è che c’erano anche i loro rivali, come si chiamano?
Spandau Ballet.
Ecco, gli Spandau Ballet! Ogni volta che li incontravi ti facevano i complimenti per com’eri vestito. Ti prendevano per il culo. Comunque, erano tutti lì e a un certo punto è arrivato Phil Collins. “Ehi, Steve, come va?”. Abbiamo iniziato a chiacchierare e poi mi ha detto: “Conosci Eric Clapton?”. Io gli ho raccontato che l’avevo salutato dopo un concerto con la Average White Band, e lui ha insistito per farmelo conoscere quella sera.
Un paio di settimane dopo ho ricevuto una telefonata da gente che lavorava con Clapton, mi hanno chiesto di incontrarlo e suonare con lui. «Ci saranno il tastierista Greg Phillinganes, il bassista Nathan East, tu ed Eric, un quartetto. Suonerete in un piccolo club di Boston». È così che ho iniziato a suonare con lui. È stato uno dei periodi più impegnativi della mia vita. Quell’anno sarò stato a casa sì e no tre settimane.
Raccontami del tour del 1991 con George Harrison. Era roba grossa, non suonava dal vivo dal 1974.
Con Clapton abbiamo fatto le 24 serate alla Royal Albert Hall e George veniva spesso. Era amichevole e divertente. In camerino ha detto che gli avevano chiesto di suonare in Giappone. Eric gli ha domandato se avrebbe accettato. «Non ho una band». Ed Eric: «Perché non usi la mia? Io farò una pausa».
George ci ha chiesto se fossimo disposti a partire in Giappone con lui. È iniziato tutto così. È venuto anche Eric, ma non sembrava tanto contento. In quel tour era isolato e infelice. Pensava di prendersi una pausa, ma per qualche ragione è venuto con noi.
Per un fan dei Beatles dev’essere stato pazzesco suonare canzoni come Taxman e Something.
È stato ancora meglio! Durante le prove è arrivato anche Ringo, e il percussionista Ray Cooper aveva un secondo kit. Allora ho proposto a Ringo di suonare insieme. Insomma, ero sul palco con due dei Beatles. Con Ringo e George c’era una connessione particolare. È stata una rivelazione.
Ti piaceva la musica di Tom Petty prima di ricevere la chiamata per Wildflowers?
Non ero un grande fan, avevo visto un paio di video su MTV. Credo fossero Learning to Fly e I Won’t Back Down. Mi piaceva la sua musica, ma preferivo jazz e r&b. Anche il rock. Andavo a sentire i Led Zeppelin, ma preferivo altri tipi di musica. Comunque, gli Heartbreakers erano fighi.
Quelle session sono durate anni.
La prima metà è iniziata a ottobre 1992. Sono tornato a giugno del 1993 e abbiamo fatto la seconda parte. Ero felice di tornare in studio, in una situazione da band. Ma con gli Heartbreakers ho dovuto imparare a lavorare in maniera diversa, perché la cosa più importante era la canzone. La scrittura di Tom era così forte che preferivano limitarsi a presentare i brani, a fare le cose semplici. Ogni tanto potevo aggiungere qualcosa, ma era sempre tutto essenziale.
Mi sono divertito tantissimo. Lui tirava fuori una canzone dopo l’altra. E ne scartava tantissime. Wildflowers era diverso dalle altre cose di Tom Petty. Aveva un suono diverso. Ogni tanto se ne usciva con una canzone che mi sembrava più nel suo stile, la suonavamo tre o quattro volte e poi la scartava. Non capivo cosa stesse facendo, perché erano grandi canzoni.
Mi piace molto anche l’album Echo. Tom mi ha raccontato che non riusciva ad ascoltarlo perché gli ricordava troppe cose dolorose. Tu ci riesci?
Sì, ho imparato ad apprezzarlo. È stato come togliere un dente. Molto più difficile da registrare di Wildflowers. La title track all’inizio durava 27 minuti. L’abbiamo suonata per quattro giorni, ma non veniva fuori. È stato difficile far funzionare le cose. L’abbiamo registrato a casa di Mike Campbell, è stato divertente. Ma per lui era difficile, e questo ha rallentato tutto.
Avete suonato insieme per più di vent’anni, ma i miei concerti preferiti sono quelli al Beacon Theater del 2013. Dev’essere stato divertente suonare una scaletta diversa, con un’atmosfera rilassata…
Era sempre divertente. Non sapevamo cosa sarebbe successo tra l’inizio e la fine dello show. Facevamo delle prove leggere, lavoravamo su delle cose, ma niente era scolpito nella pietra. Alla fine di quel tour sapevamo cosa stavamo facendo. L’idea era: inizia con qualcosa che il pubblico conosce, metti quello che ti pare nel mezzo, e alla fine dagli due cose che amano, noi saremo felici e loro pure. Per Tom era un modo per vivacizzare le cose. E funzionava.
Una volta Tom mi ha detto che chi suona negli stadi è quasi obbligato a suonare le hit. Il vostro problema è che ne avevate troppe, si prendevano quasi tutto il set.
Era assurdo. Ho sempre detto che gli Heartbreakers potevano fare una scaletta con solo hit. Tom era un autore prolifico. Era fortissimo.
Nel 2004 hai suonato While My Guitar Gently Weeps con Prince. Sapevi cosa avrebbe fatto?
No! Ci ha spaventati tutti. È stato strano. Non sapevo nemmeno che sarebbe stato sul palco. Noi avevamo già provato a Los Angeles. Poi siamo andati a New York e alle tastiere c’erano Steve Winwood e Jeff Young. Conoscevo Steve da anni. Prince è apparso all’improvviso, così ho chiesto a Steve cosa ci facesse lì. «Credo che suonerà con noi», ha risposto.
Gli organizzatori volevano che Prince si esibisse con noi, mentre Olivia Harrison avrebbe preferito vedere sul palco solo musicisti che conoscevano George di persona. Alla fine l’hanno convinta, e Tom e gli altri hanno accettato.
È stato strano. Sono andato a salutarlo e presentarmi. Lui mi fa: «So chi sei», perché avevo suonato su I Feel for You di Chaka Khan, un suo pezzo. Gli ho detto: «Non vedo l’ora di suonare con te. Non sapevo che ci saresti stato anche tu». Torno da Winwood e lui mi chiede com’era andata. «È stato molto carino, vai a salutarlo», gli ho detto. Abbiamo provato il pezzo e lui ha aggiunto un piccolo assolo. Ma quando siamo saliti sul palco per suonarlo davvero, ne ha fatto un’altro completamente diverso e si è spostato al centro del palco. Si è girato spalle al pubblico ed è caduto di sotto. Abbiamo tutti trattenuto il respiro (ride). Un tizio gigantesco che c’era di sotto l’ha rispinto sul palco. Alla fine ha gettato in aria la chitarra e se n’è andato. All’inizio era difficile capire cosa fosse successo. Io non l’ho mai capito. Ho cominciato a chiedermi dove diavolo fosse finita la chitarra ge aveva tirato in alto: si era forse incastrata nell’impalcatura? È stato divertente, come se si fosse esibito più per noi che per il pubblico. Era uno showman e quell’assolo era pazzesco.
Su YouTube il video è stato visto 90 milioni di volte.
Davvero? Wow. Qualche volta l’ho fatto anche io, sono uno di quei 90 milioni. È un assolo fenomenale, un grande tributo a George.
Ho visto un po’ di concerti dell’ultimo tour di Tom, nel 2017. Suonavate tutti davvero bene. So che Tom soffriva molto, ma sul palco non si vedeva.
Si spostava dal camerino al backstage con un’auto da golf. A un certo punto avevo dolori al ginocchio e mi hanno messo sulla sedia a rotelle. Lui era sempre dietro di noi. Eravamo sempre vicini prima di salire sul palco. Mi metteva la mano sulla spalla e diceva: «Andiamo lassù». Salivamo le scale insieme, zoppicando.
Prendeva l’ossicodone solo per fare i concerti. Calcolava i tempi, così che facesse effetto al momento giusto. Io gli chiedevo se era pronto e lui diceva: «Portami lassù e starò bene». Le medicine eliminavano il dolore e riusciva a suonare. Quando facevamo la prima pausa, mentre tutti facevano le loro cose, a volte riusciva a camminare da solo. Altre chiedeva il mio aiuto. Mi metteva il braccio sulla spalla e risalivamo le scale insieme.
Pensi che gli Heartbreakers torneranno mai a suonare insieme? Un concerto tributo per Wildflowers?
Sai, ne ho parlato un po’ con Mike. Lui ha sempre detto: «Tom ci farà sapere quando arriverà il momento giusto». E sappiamo che il periodo successivo alla sua morte è stato complicato. Non credo che la band sia disposta a fare qualcosa di diverso da quello che desiderava Tom.
L’altro aspetto difficile è che Tom era parte integrale della band, era anche il chitarrista. Non era solo il frontman. Era parte del gruppo. Si divertiva a suonare con noi tanto quanto a cantare i suoi testi. Credo che fosse per questo che amava così tanto il gruppo.
È sempre stato un leader, mai un capo. Non ci sono dubbi. Ma era parte della band. Era molto orgoglioso del fatto di essere un chitarrista. Con la sua scomparsa la band ha perso un pezzo importante, fondamentale. Certo, potremmo trovare qualcuno che canti al suo posto. Non credo che sarebbe il problema. Ma chi suonerà la chitarra?
È difficile da immaginare, ma potrebbero esserci Eddie Vedder e Lucinda Williams…
Assolutamente. Sai una cosa? Quando è morto, i fan sono stati incredibilmente sensibili e dolci. Sono ancora in contatto con alcuni di loro. È brava gente. Tom amava i suoi fan e i suoi fan amavano lui. Non credo che sarebbe giusto restare con le mani in mano.
Quand’è l’ultima volta che l’hai visto?
Dopo l’ultimo concerto all’Hollywood Bowl. Sono andato a trovarlo nella sua stanza al Beverly Hills Hotel. Lui e Dana sembravano felici, innamorati. Abbiamo ordinato da mangiare e siamo rimasti insieme. Mi ha detto che avremmo fatto qualcosa, ma che i grandi tour erano finiti. Ha anche detto che gli sarebbe piaciuto fare qualcosa con Wildflowers. Voleva farsi sistemare la gamba, lavorare ancora con le Webb Sisters.
Volevamo fare tante cose. Quando sono uscito e l’ho abbracciato, ci hanno scattato una foto. È la fotografia a cui tengo di più. È il momento in cui gli ho detto addio. È quello che voglio ricordare, non quando ero in ospedale e lui era attaccato alle macchine.
I fan mi chiedono sempre che tipo era. Io rispondo che era esattamente come se lo immaginano, era quel tipo di persona.
Tom voleva davvero fare il tour di Wildflowers, l’ha detto anche a me.
Sì. Diceva: «Faremo Wildflowers e poi il secondo album di Wildflowers insieme ad altri cantanti». Credo si riferisse a Eddie Vedder, Steve Winwood e Stevie Nicks. Sarebbe stato davvero divertente. Ma non mi sembra una cosa tanto piccola, non credi? (Ride)
No. Sarebbe enorme. E catartico per i fan. Saremmo tutti lì per celebrarlo.
Assolutamente. Sarebbe fantastico. Vedremo cosa succederà. La perdita di Tom ha rappresentato una grossa ferita per la band. A volte viene fuori qualche proposta, ma poi penso a Tom e mi viene da piangere. So che Mike e Benmont la pensano allo stesso modo. Sicuramente anche Scott. Credo piacerebbe a tutti, ma abbiamo ancora tante emozioni da affrontare. È difficile entrare nei club senza di lui. Ti manca qualcosa.
Sarebbe difficile, ma non impossibile. Credo che possiamo farcela. Ma non so, magari mi illudo. Pregherò per questo. Che dici?
Dico che dovresti scrivere un libro. Parliamo da un’ora e ho a malapena scalfito la superficie.
Ne ho parlato con un amico. Farlo sarebbe divertente, ma anche difficile. Ma un po’ di dolore non ha mai ucciso nessuno.
Questo articolo è stato tradotto da Rolling Stone US.