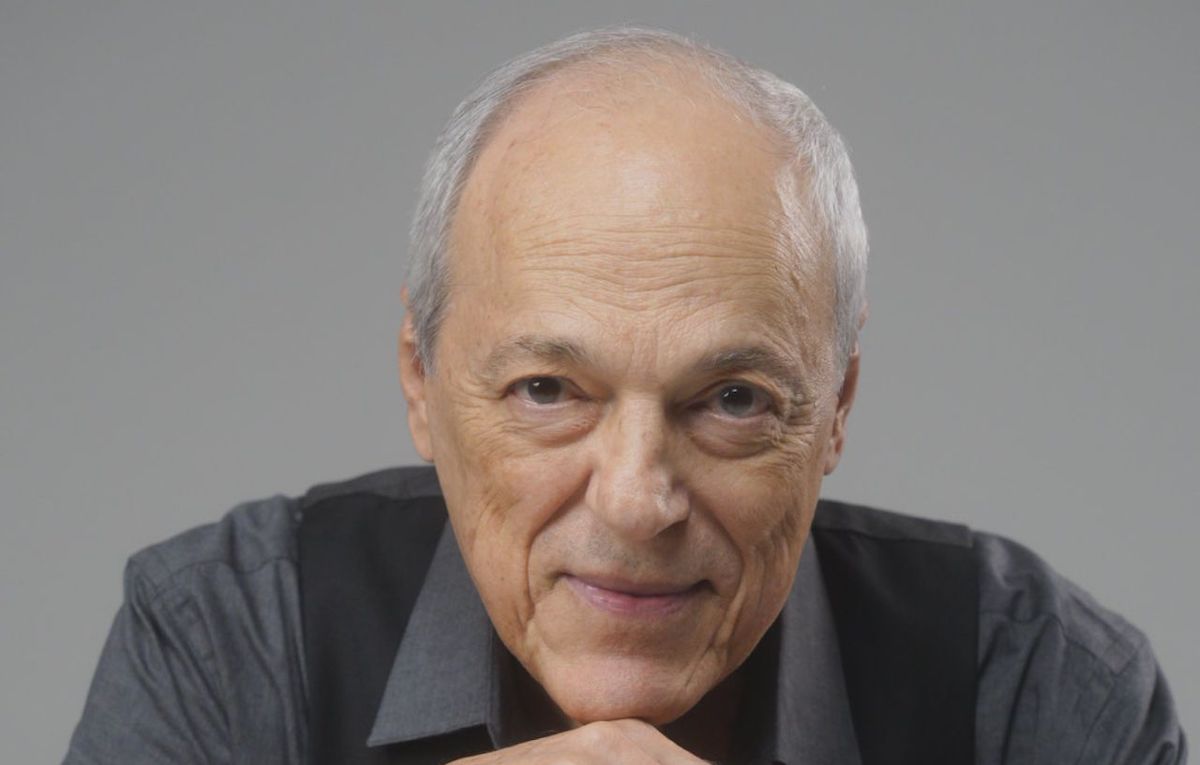Fino a oggi, Tinashe non era certo nota per le idee politiche. Non che non ne avesse, ma cercare di avere una carriera incidendo per una casa discografica che non è progettata per farti avere successo è un lavoro a tempo pieno. Nel 2019 si è separata da RCA, l’etichetta che l’aveva ingaggiata sette anni prima. Se negli ultimi anni si è dedicata alla ricerca di una nuova libertà creativa e contrattuale, il suo 2020 è all’insegna della trasparenza. Intervistata al telefono, la cantante di Songs for You parla appassionatamente di eliminare il razzismo sistemico dell’industria discografica e delle manifestazioni di Black Lives Matter. «Sono sempre stata così, ce l’ho dentro», dice. «Sono convinta che la libertà tipica delle persone creative aiuti a superare la paura di fare le mosse sbagliate, perché realizzi che hai una responsabilità».
«Libertà significa anche schierarsi per ciò in cui credo, parlare apertamente delle cose che penso siano importanti. È importante mettersi alle spalle la paura di farlo, è questo terrore irrazionale che ferma le persone, ma non ne vale la pena», continua. «È molto più importante essere onesti, soprattutto in questo momento».
Rascal, il suo ultimo singolo, ha un che di ribelle. “Non conoscono la strada su cui camminiamo”, canta. “Non è uno scherzo, stronza, sono un nemico”. In effetti, per i dirigenti delle multinazionali Tinashe è davvero una nemica del sistema delle major. Per tutti gli altri, è un’artista che è uscita dagli ingranaggi di quella macchina e che ora racconta di quel che serve per non farsi annientare.
Com’è la tua giornata tipo nel 2020?
Difficile dirlo, ogni settimana è diversa. Cerco di tirare fuori il meglio da ogni situazione. All’inizio della quarantena mi sono concentrata sulla creatività e sulla mia nuova musica, è stato bello perché in casa ho uno studio. Poi quando è esploso Black Lives Matter ho preso parte alle proteste e mi ha preso un sacco di tempo. Ora, invece, sto tornando verso una fase più creativa.
Come suona la tua nuova musica?
Volevo scrivere qualcosa che fosse felice e portasse gioia, perché mi sentivo depressa. Siamo bloccati a casa. È un tipo di depressione che non ha precedenti e l’abbiamo sentita tutti, come collettività, prima di normalizzarla. Volevo scrivere canzoni che trasmettessero speranza, che fossero divertenti, eccitanti. Per questo ci sono tanti beat su cui ballare, è roba che ti fa sentire bene. E non volevo scrivere direttamente della quarantena.
Che cosa hai pensato della risposta delle major alle proteste contro il razzismo degli ultimi mesi?
Credo sia fantastico. Sono ancora i primi passi, ma ci sono senz’altro alcune persone e alcune aziende straordinarie che spingono per il progresso. È anche divertente. C’è tanta strada da fare e il razzismo è davvero profondo e sistemico nell’industria discografica e nelle major, tanto che a volte mi sembrano sordi, fuori fase. E c’è anche un po’ di falso attivismo, alcuni non hanno davvero affrontato i problemi. Ovviamente non so cosa succede dietro le quinte, ma quel che ho visto suggerisce speranza in una completa ristrutturazione del sistema.
Sembra che abbiano messo un cerotto su una ferita enorme, o che abbiano costruito una casa su fondamenta marce. Non mi fido molto di quello che ho letto…
È divertente, non li prendo molto sul serio. Non mi sembrano seri.
Cosa pensi della questione del genere urban? Pensi che si possa trovare una soluzione?
Sì, penso di sì, ma vorrei spingermi oltre e dire che dovremmo abolire tutti i generi. Sono nati e prosperati in un sistema basato sulla razza, sulla segregazione della musica basata sulla razza. Mettere un artista nella categoria urban, rap o r&b – o uno di questi termini ombrello che usiamo per definire i generi – crea un grande senso d’isolamento per chi vuole sperimentare, soprattutto per chi non si riconosce in alcun genere, come me. Quando ho iniziato non volevo essere etichettata come la nuova ragazza r&b. Non perché odiassi l’r&b, ma perché vedevo che il lavoro per spingere gli artisti urban era diverso da quello che succedeva coi cantanti pop. Io volevo quei palchi, quelle stazioni radio. Ho sempre pensato che il mio materiale e la mia musica appartenessero a un’altra categoria.
Non aveva senso per me incasellarmi in un genere a cui per di più era assegnato un budget limitato. Pop e r&b erano letteralmente su piani diversi, non comunicavano tra di loro. Non si lavorava mai assieme per promuovere una canzone o un’artista. Erano due team diversi. È una situazione pericolosa per chi si ritrova in mezzo a due generi, come è successo a me. E sono sicura di non essere l’unica. Insomma, sono abbastanza fortunata da aver avuto un’occasione e di aver provato a far funzionare le cose. Ma questo modo segregato di lavorare ha radici profonde nelle etichette. Non è pensato per gli artisti che non appartengono a una categoria.
In più, penso che cambiare il nome da urban contemporary a r&b o altro sia solo un modo per dare un nuovo titolo allo stesso film. Non elimina il problema di chi finisce etichettato in un genere dove si fa meno promozione e dove non c’è il rispetto che deriva dal mainstream. È una cosa più profonda. E non si tratta solo delle case discografiche, c’entrano anche le radio. C’entra cosa viene pubblicato, chi organizza i concerti, i premi. Tutte queste cose hanno un ruolo fondamentale per il successo mainstream di un artista, e non avere le stesse possibilità e lo stesso supporto è davvero dannoso.
Parli di un problema sistemico, ma specificamente come vengono esclusi gli artisti neri, e soprattutto le donne?
Nel mio caso dipendeva molto dalle canzoni che finivano in Top 40. Ma chi è che determina quei risultati? Ci sono tantissimi artisti straordinari che non non fanno musica da Top 40. Davvero tanti. E sono incredibilmente sottorappresentati. Non c’è alcuna diversità, è ovvio. Vediamo ogni anno gli stessi artisti e non lo dico perché voglio liberarmi di loro. Sono straordinari e meritano quel che hanno, ma ci dovrebbe essere spazio anche per gli altri. C’è molta più diversità nella musica di quanto si veda dal mainstream.
Dopo gli eventi di quest’anno, lavoreresti ancora con una major?
Appena diventata indipendente ero più aperta all’idea che avrei trovato qualcuno che mi avrebbe aiutata e capita e supportata. Poi ho capito che quando lasci che altra gente interferisca con la tua creatività e dica la sua sul tuo lavoro ha un impatto notevole. Ora che so quanto è negativo e creativamente frustrante, non credo che tornerei a lavorare con una major, non voglio rischiare.
Quali sono le sfide che hai affrontato lasciando una major? Che consigli daresti ad altri musicisti nella tua situazione?
La cosa migliore da fare è pubblicare costantemente contenuti di qualità: dipende tutto da questo. Il business della musica è fondato su questo. Dipende dalla musica che scriviamo, dalla nostra arte. Bisogna scrivere cose fighe, continuare a farlo, non fermarsi e continuare a insistere. Il punto è come finanziare tutto questo. Trovare il budget per realizzare i contenuti è complicato, bisogna avere una strategia. Si lavora un progetto per volta, si evitano di pensare al lungo perioco. Trovate i soldi, lavorate alla vostra arte. Non lasciate che gli altri influenzino la vostra visione e trovate un team che vi supporti, perché è difficile fare tutto da soli. Servono altre persone che combattano per la tua visione.
Che speranze hai per il futuro tuo e di chi vive una situazione simile?
Penso alle artiste donne, spero che un giorno vivremo in un mondo in cui non saremo incasellate in base al sound e all’aspetto. Vorrei lo stesso tipo di rispetto e promozione che hanno i colleghi maschi e bianchi. Fa una differenza enorme. Vorrei vedere più diversità in radio e in tv. Nella musica c’è spazio per tutti.
Questo articolo è stato tradotto da Rolling Stone US.