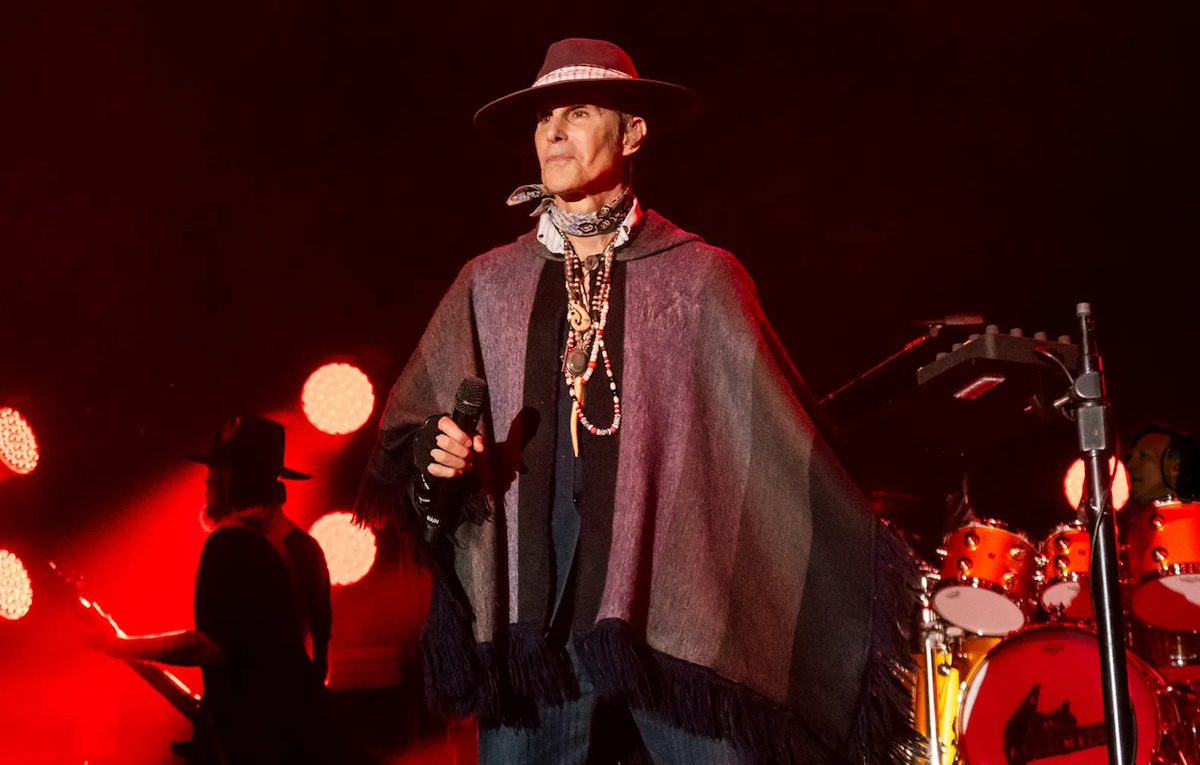Mi sento ispirata e ho un sorriso ebete stampato sul volto: effetto Van Dyke Parks. Non che sia facile stare dietro la sua dialettica originale, ricca di salti pindarici e aneddoti su personaggi leggendari. Figura della controcultura californiana dagli anni ‘60, compositore di musica per film e televisione, pianista (per un breve periodo) per Frank Zappa & The Mothers of Inventions, Van Dyke Parks ha persino rifiutato le offerte di diventare membro sia dei Byrds che di Crosby, Stills, Nash & Young. Produttore per Randy Newman e Joanna Newsom e pioniere dei sintetizzatori Moog («gli ho insegnato a dire mama»), Parks ha dato nuova forma al pop contemporaneo grazie ai suoi arrangiamenti orchestrali. «Non posso stare senza far niente, non ho altri hobby oltre la musica» confessa, in camicia hawaiana nella sua casa di Los Angeles. «Ieri ho imparato al piano una mazurka di Chopin. È stupenda e quando la suono mia moglie si scioglie come un panetto di burro». La pandemia ha impedito il nostro incontro, ma quando gli telefono, lui dirotta subito verso la videochiamata perché «ci hanno già tolto tutto: gli sguardi, i suoni, le strette di mano, l’aroma del contatto umano».
Orange Crate Art è l’album che ha scritto e prodotto nel 1995, interamente cantato dall’amico Brian Wilson. Omnivore Recordings pubblicherà il 19 giugno la ristampa (per la prima volta anche in vinile), che include cover inedite di classici come What a Wonderful World e versioni strumentali. «Brian Wilson da californiano sapeva pronunciare la parola “orange” molto meglio di me», ammette Parks, originario del Mississippi. I motivi della genesi dell’album sono in realtà più profondi e risalgono al 1966, quando Parks scrive insieme ai Beach Boys Smile, l’album che notoriamente non avrebbe visto la luce fino al 2011. In questo senso, Orange Crate Art nasce da un conto in sospeso, ovvero dal desiderio di Parks di tornare a lavorare con Wilson dopo gli eventi sfortunati di Smile. «Anche se allora lo studio di registrazione era l’ultimo posto dove Brian voleva andare. Se ne stava chiuso in casa a guardare la televisione, senza far nulla». Orange Crate Art è un concept album la cui idea è lanciare uno sguardo sognante alla California di un tempo come metafora di giovinezza e semplicità. «Ma con un senso di rimpianto più che nostalgia».
Le canzoni di Orange Crate Art le ha pensate sin dal principio per la voce di Brian Wilson?
Sì. Ero in debito con Brian, lui mi aveva onorato in passato. Tutto è iniziato quando scrissi per i Beach Boys il testo di Heroes and Villains: bang! Eccomi entrato nel peculiare mondo della cosiddetta industria discografica, dove sono rimasto per parecchi anni. Orange Crate Art è stata la mia occasione per dirgli che gli ero grato: lui non era in vena di scrivere ma avrebbe cantato se lo avessi guidato. Questo disco è una faccenda personale. Ma anche una provocazione: è un detergente per la musica di massa. Non è un album che segue le mode ed è stato realizzato con una completa libertà creativa. Nel 1995 si prendevano ancora grosse cifre per realizzare un disco, sull’ordine di migliaia di dollari e in genere gli artisti ne avrebbero spesi 20 e con il resto si sarebbero comprati una casa. Io però non ragionavo così, volevo far lavorare i musicisti e per Orange Crate Art ho speso tantissimo denaro e altrettanto tempo per arrangiarlo. Volevo creare qualcosa di bello, era il mio ultimo disco con Warner Bros e volevo andarmene con un una certa gloria.
Com’è riuscito a motivare Brian Wilson se in quel periodo non aveva interessi?
Non si trattava di convincerlo, non credo fosse in grado di prendere decisioni in quel momento, ha più che altro seguito le circostanze. Ho chiamato una limousine per andarlo a prendere e portarlo in studio. Per prima cosa ha voluto un face freeze, ovvero un secchio pieno di ghiaccio dove infilare la testa, serve a dare energia. Poi ha chiesto un’insalata cinese di pollo e un pacco da sei di Coca Cola light. Riusciva a tirare in aria la lattina di Coca da dietro la schiena, farla atterrare sulla mano e aprirla con un solo gesto. Poi avrebbe bevuto e l’avrebbe buttata nel cestino senza perdere un beat. Dopo quei rituali sembrò più a suo agio, ma quando indossò le cuffie per registrare mi chiese: «Perché non le canti tu queste canzoni?» Gli risposi dalla camera di controllo che francamente non mi piace il suono della mia voce. Lui mi rispose: «Non posso biasimarti!». Così è filata liscia la prima sessione e quando consegnai il risultato ai boss dell’etichetta ne rimasero entusiasti. Mi sono offerto di pagare di tasca mia Brian e di continuare a lavorare insieme per tutte le altre canzoni dell’album. Siamo andati avanti perché non abbiamo “trovato la retromarcia”, proprio come dice il motto dei taxisti di Liverpool.
Il risultato è un disco con un suono fuori dal tempo…
È il mio tributo a una sensibilità pop che ha definito un’era. Un’era che Brian mi ha fatto amare grazie alla sua musica appunto fuori dal tempo, in modo simile a quella di Joni Mitchell e Harry Nilsson. Ho cercato di ricreare la sua magia portando musicisti che sanno celebrare questo sound, come l’armonicista virtuoso Tommy Morgan che aveva già suonato in molti brani storici di Brian. È lo stesso sound che mi fece pensare fosse ok avere sia i Beach Boys che i Beatles, invece che solo i Beatles.
A quale era si riferisce esattamente Orange Crate Art?
Vedo una vecchia pubblicità della Coca Cola, una pompa di benzina nel Sud. È l’estate del 1942, vedo i primi film e la realtà, l’esperienza del dopoguerra appartiene alle nostre vite. Tra me e Brian passa solo un anno, lui è più vecchio di me e non sono in molti a poterlo dire.
Perché l’artwork dell’album è pieno di dipinti presi in prestito da musei che non sono riconducibili alla “orange crate art”? (raffigurazioni di carattere pubblicitario, nda)
È un sotterfugio, ai musicisti è consentito essere ingannevoli. I maghi e i giocolieri lo sono. È un modo per distrarre il pubblico. Utilizzare quelle immagini ci è costato 15 mila dollari, pagati direttamente ai musei che li possedevano, su e giù per la California. Sono realizzate in un solo giorno, i pittori hanno posizionato il cavalletto e via. Erano la risposta californiana alla scuola impressionista.

Lei ha dichiarato che solo per l’intro di Movies Is Magic ha speso una cifra ridicola…
Dovevo avere un’orchestra di 63 membri. Tra l’altro nell’intro di quel brano ci sono due citazioni, una al tema di Via col vento e una a Strauss, ma le ho suonate in maniera “sbagliata”. Così non solo avevo insultato due publisher in un colpo solo, ma nessuno poteva accusarmi di plagio. È questa la ricompensa del sotterfugio, reagire al potere dopo avere firmato un mega contratto per portare musica alle masse. Movies Is Magic è basata su una storia vera: Elvis Presley si era innamorato della sorella di mia moglie.
Ce la racconta?
Elvis si era fissato che voleva portare a ballare la mia futura cognata. Aveva appena conquistato la sua prima hit e possedeva una Cadillac Eldorado bianca decappottabile con gli interni maculati, in pelle di leopardo. Così aveva preso a presentarsi con la sua auto davanti casa della famiglia di mia moglie a Memphis, e se ne stava lì seduto col motore spento. Non riuscì mai a portarla al ballo, ma una volta sono andati al parco giochi insieme ai fratelli di lei per giocare con le macchine a scontro. Era una storia buffa e l’ho voluta infilare nei testi anche se non riguarda la California.
Ci sono molte leggende sugli scontri tra lei e i Beach Boys durante le session di Smile…
C’è stato fango, melma, situazioni comiche e sfortunate collisioni… ma con Brian abbiamo avuto anche le nostre vittorie. Mi riferisco a quando abbiamo scritto insieme Sail On Sailor (nel 1972, nda) un giorno in cui mi sono presentato a casa sua con un walkman dove avevo registrato alcune idee. Sono stato il primo a Los Angeles ad avere un walkman, me lo aveva spedito il presidente della Warner Bros giapponese. Era un oggetto così affascinante, segreto, lo potevi portare ovunque a differenza di quei cosi enormi a cui eravamo abituati.
Siete ancora in contatto con Brian Wilson?
Non lo vedo da almeno 10 anni, viviamo universi paralleli.
A cosa sta lavorando al momento?
Sono impegnato a orchestrare un’artista dello Yucatan, della cultura mesoamericana e indiana. È un’arpista, fa roba eccezionale.
La mole del suo lavoro è impressionante, a volte sorprendente. Mi riferisco alla collaborazione con il DJ Skrillex: nessuno se l’aspettava.
Il mio approccio al lavoro si potrebbe definire calvinista: pensi di essere troppo bravo per collaborare con un dj? Ti sbagli! Non sei superiore a nulla, sveglia! Quando Skrillex mi ha chiamato al telefono non avevo idea di chi fosse. Voleva che arrangiassi un brano per una grande orchestra. Gli chiesi qualche informazione sul suo conto e lui mi disse che in quel momento si trovava in Europa per un concerto. Così accesi il mio portatile e lo vidi su YouTube mentre si esibiva di fronte a 250 mila persone, rovesciava una birra sul computer e il pubblico reagiva con un’erezione di massa. «Signor Parks, distruggeremo il mondo!», mi disse. Ho pensato che quei 250 mila erano la gioventù disillusa d’Europa, o meglio il volto dell’Europa. Sono agitati perché non hanno più speranza. Ho trattato quella collaborazione come se fosse un evento di vita e grazie alla mia disciplina ho creato i suoni più selvaggi e potenti che potessi. Lavoro sodo nella mia musica, non sono uno che riesce a creare senza sforzi.
Da ragazzino l’abbiamo vista al cinema a fianco di Grace Kelly (The Swan, 1956, nda), poi ha preferito comporre musica per film e tv piuttosto che recitare. Però di tanto in tanto la vediamo dilettarsi in qualche cameo…
Da ragazzino mi piaceva recitare ma poi ho lasciato perdere perché volevo essere considerato un musicista serio. Ho accettato di partecipare a Twin Peaks perché era uno show diretto da un amico. Ho fatto la parte di Jack Racine, il procuratore. Per una settimana intera ho custodito il segreto che il resto d’America non sapeva: chi ha ucciso Laura Palmer. Camminavo per strada e pensavo: io so quello che tutti voi vorreste sapere. Il fatto curioso è che conoscevo anche l’attore nella parte del giudice perché avevamo lavorato insieme 40 anni prima quand’ero un bambino attore a New York. È stato surreale ritrovarlo sul set. Buffo che anche Jack Nicholson mi abbia chiesto di fare un cameo in una parte molto simile, quella del procuratore in Il grande inganno.
Per il film diretto da Jack Nicholson lei ha scritto anche la musica…
Avrei solo dovuto scrivere la musica. Avevo rifiutato il cameo ma quando mia moglie mi ha scoperto, mi ha convinto a telefonarli di nuovo e ad accettare la parte. Il fatto è che non sono bravo a ricordarmi le battute, ho una pessima memoria, per questo non me la prendevo mai con Brian Wilson. Mi ci è voluto un intero weekend per imparare il copione, ma appena arrivato sul set l’assistente di Jack Nicholson me ne ha dato un nuovo da assorbire all’istante. Non potevo crederci.
Lei era anche presente la notte del cosiddetto “lost weekend”, nel 1974, quando John Lennon e Harry Nilsson furono cacciati dal Troubadour. Cosa ricorda?
Che loro erano in giro per locali da tre giorni, io sono durato solo due. John era una persona acuta, molto intelligente e sapeva essere spigoloso, ma con me è sempre stato molto carino, forse l’ho beccato nei giorni giusti. Harry aveva un carattere simile e quella sera si stavano divertendo, ma per loro si trattava pur sempre di alcolismo funzionale, legato all’uso di cocaina che girava parecchio in quegli anni. Ricordo che i buttafuori del locale erano molto ostili, anche io sono stato scaraventato contro il muro e il mio corpo non prese bene il colpo, perché da piccolo mi sono fratturato una vertebra mentre andavo a cavallo con Grace Kelly. Quella notte ero rimasto a dormire nella guest house di Harry e la mattina seguente, sfogliando il giornale ho trovato un articolo che diceva che John Lennon era stato cacciato dal Troubadour. Harry disse: «Era la mia notte e questo scansafatiche si prende tutta l’attenzione!». Neppure io ero stato menzionato nell’articolo e così gli ho detto: «Benvenuto nel club». È stato tragico il modo in cui sia John che Harry se ne sono andati, che grande perdita. In un certo senso, sono entrambi vittime della propria celebrità.
La sua vita ha sempre gravitato intorno alle celebrità: le è mai importato essere famoso?
Dall’assassinio di JFK nel 1963 mi sono reso conto che essere famosi ha i suoi pericoli e non mi sono mai lasciato distrarre da quella curva rischi-benefici. Ora però capisco che nella musica sopravvive solo chi riesce a trasformare il proprio nome in un brand, come il rock da arena. Gli altri soffrono, vivono un isolamento simile a quello creato da una pandemia, con il mondo delle royalties che è completamente andato. Ma i giganti saranno dannati.