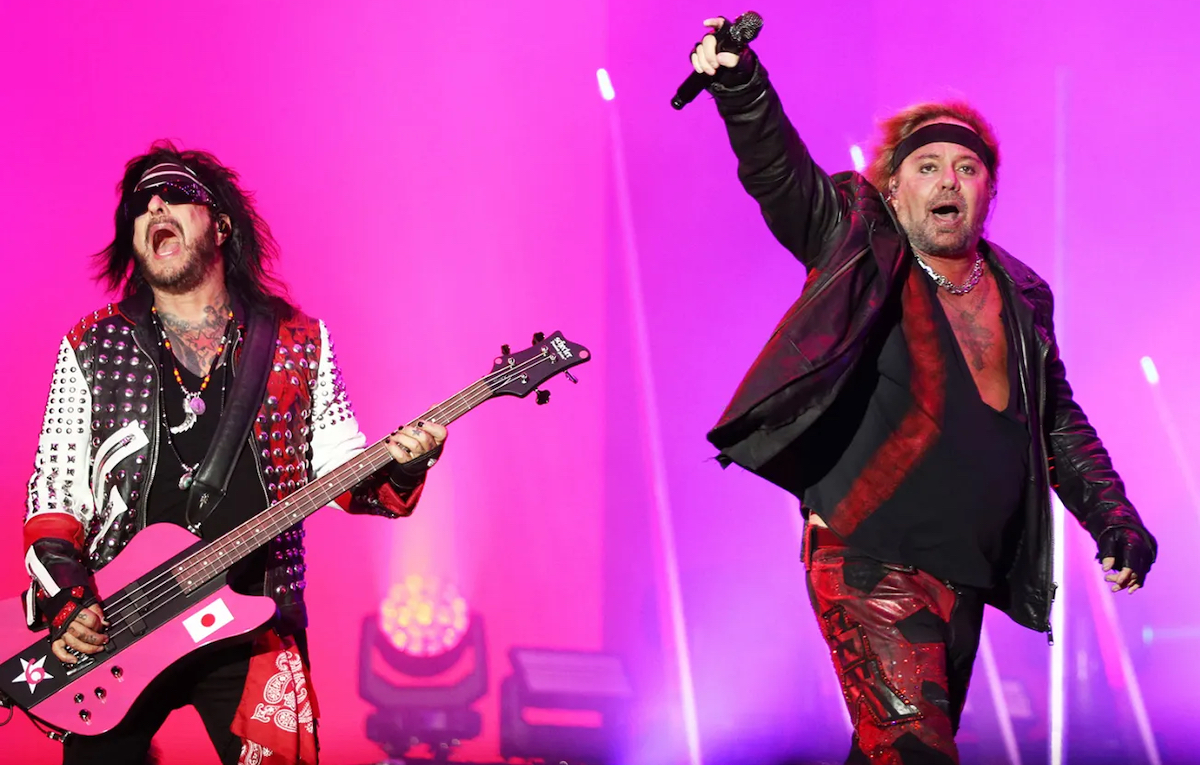Cuoio e pelle nera. Borchie scintillanti. Fruste e manette. Occhiali da sole a specchio. Chitarre Flying V. Doppia cassa mitragliante. Ingressi sul palco a cavallo di Harley Davidson. Ghiaccio secco a go-go. Probabilmente i Judas Priest sono da sempre l’epitome e i poster boy dell’immagine “heavy metal” – nel bene e nel male, ovviamente.
Ma non sono campioni solo a livello di look: i Priest hanno scritto la storia di un genere quando era ancora tutto da inventare, iniziando a muovere i primi passi fra il 1969 e il 1970, pubblicando il primo album nel 1974 e rimanendo attivi fino a oggi fra successi, flop, coming out, abbandoni, rientri, crisi di mezza età, annunci di tour d’addio, smentite di tour d’addio, malattie (il povero Glenn Tipton, a cui è stato diagnosticato il Parkinson nel 2018) e revival.
Possono piacere o meno, nella loro incarnazione di gruppo heavy metal puro e incontaminato, ma è innegabile l’influenza che hanno avuto nel gettare le fondamenta del genere. In fondo hanno sfornato dischi divenuti classiconi (Sin After Sin, Stained Class, British Steel, Screaming for Vengeance, Defenders of the Faith). Poi sono arrivati gli anni ’80 e la voglia/necessità di sfondare alla grande negli Stati Uniti, con la conseguente adozione di un approccio più radio friendly. Morale: i pezzi si fanno più “leggeri”, arrivano i tastieroni e le chitarre synth (canto delle sirene a cui avrebbero ceduto anche gli Iron Maiden, con Somewhere in Time), i fan più duri storcono il naso, ma le vendite aumentano fino all’anno dell’apice: 1990, con l’uscita di Painkiller.
Un picco da cui i Priest precipitano, facendo un gran volo in caduta libera. I tempi sono cambiati, il grunge è alle porte, la band affronta l’abbandono del cantante Rob Halford (che sarebbe poi tornato all’ovile). Insomma, da qui inizia l’ordinaria amministrazione, ossia la vita dopo la vita dei Priest, che restano dignitosamente (salvo qualche orribile scivolone nel nu metal/groove metal) a galla fino a oggi, forti di un passato glorioso che garantisce un presente magari poco sapido e impregnato di revival, ma attivo. Se tutto ciò abbia senso o meno è un quesito difficile a cui rispondere. Diciamo che 50 anni di rock sulle spalle sono un peso non indifferente e l’età (ormai non più verde) non gioca a favore del presentarsi in tutine di pelle e pose stereotipate.
Uno sguardo da insider sul mondo dei Priest è offerto dal libro Heavy Duty, scritto dal chitarrista della band (fra il 1970 e il 2011) K.K. Downing e appena tradotto in italiano da Tsunami Edizioni. Un’autobiografia paradossalmente leggera, nonostante l’ambito heavy, da cui traspaiono soprattutto due sensazioni nette: la prima è che la diplomazia iper British dell’autore (o il timore degli avvocati dietro l’angolo) ha vinto sulla possibilità di raccontare gli aspetti più torbidi della vita di un gruppo al top negli anni ’80. La seconda è che lasciare i Priest per K.K. è stato un colpo durissimo, ma anche la conseguenza diretta di un malessere protrattosi per molti anni, compresi quelli d’oro. È proprio con lui che abbiamo fatto una chiacchierata, per ficcare un po’ il naso nelle dinamiche della band e farci raccontare meglio il suo punto di vista.
K.K., il tuo libro è una lettura veloce e agile, ma mi è mancata la dose di lordura e pazzie che mi aspettavo: in fondo sei stato nei Judas Priest negli anni più folli e di maggiore successo della band… che fine ha fatto la roba zozza?
(Ride) Vedi, il motivo principale che mi ha spinto a scrivere questo libro è che pensavo sarebbe stata una buona cosa. Dopo tanti decenni, ho immaginato che sarebbe stato bello farlo per concedere ai fan uno sguardo su di me, su come sono e sulla mia personalità – volevo che mi conoscessero un po’ meglio. Perché in fondo mi conoscono a livello di immagine, ma non sanno nulla di me. L’idea era anche di dare, nella maniera più diplomatica possibile, risposte a molte domande che i fan si sono posti a riguardo di alcune situazioni che si sono verificate, soprattutto il mio abbandono della band, che è stata davvero la cosa più difficile che abbia fatto in vita mia.
In effetti il gruppo è stato la tua vita per tanti anni.
Sì. Ma ho imparato sulla mia pelle che ognuno ha un punto di rottura. Ed è per questo che ho voluto scriverne, per farlo capire ai fan. È stato un processo maturato nel corso di un lungo tempo… io mi sono impegnato al massimo e in effetti non posso dire che ci siano stati solo lati negativi, ovviamente. Anzi: ho vissuto tante cose bellissime con e grazie ai Priest. Ma sai, quando le relazioni interpersonali arrivano a logorarsi così tanto, bisogna mollare il colpo.
A un certo punto nel libro scrivi, riferendoti al tuo abbandono: “Avrebbe potuto accadere in qualunque momento, a partire dal 1978”. In pratica hai sopportato per 33 anni la situazione, prima che saltasse il tappo. Come hai fatto?
Ovviamente credo di avercela fatta a tenere duro perché desideravo tantissimo il successo e far parte di una band così. E poi ognuno, in qualche modo, ha fatto la propria parte per tenere insieme le cose il più possibile. In più devo confessare che è molto difficile abbandonare una nave per tuffarsi in acque gelide e profonde… è molto più comodo rimanere a bordo, al caldo (ride). Ed è quello che ho fatto io, trovando nella mia passione per la musica e nel rapporto coi fan la forza di continuare.
Ma alla fine si è rotto qualcosa. E in maniera irreparabile.
Esattamente. Perché è difficilissimo avere a che fare con gente che costantemente desidera solo per sé una cosa a cui tu partecipi dando tutto te stesso. Combatti in continuazione con qualcuno che vuole il controllo al 100%, brama avere tutto in mano. E allora a un certo punto devi dire: “Vaffanculo, prenditi quello che vuoi: tieni, è tutto tuo”, e te ne vai. Credo proprio sia ciò che è successo a me coi Priest. Nella mia lunga lettera di dimissioni indirizzata alla band ho scritto: “Dite pure ai fan che mi avete spezzato, portandomi oltre il punto di non ritorno”.
Mi ha molto divertito leggere della mancata partecipazione alla colonna sonora di Top Gun. Deve essere stata una bella botta…
Eravamo a Los Angeles per mixare i pezzi di Turbo. Venimmo a sapere che era in lavorazione la colonna sonora per un film intitolato Top Gun e la produzione era interessata a un nostro pezzo. Così Glenn Tipton e la nostra manager Jayne Andrews (che era la sua compagna, nda) andarono a parlare con questa gente. Uscì fuori che desideravano Reckless, ma Glenn e Jayne rifiutarono ogni offerta perché volevano davvero tenere la canzone per il nostro album. Li lasciammo fare. Il film, dalla descrizione che ce ne fecero, sembrava un progetto del tutto trascurabile. E poi all’epoca pochi conoscevano Tom Cruise, io, ad esempio, non sapevo assolutamente chi diavolo fosse (ride). Ad ogni modo, furono Glenn e Jayne a gestire tutta la faccenda e io ero troppo occupato a lavorare in studio per il disco. Credo, col senno di poi, che sia stato un grave errore mancare una simile occasione: sarebbe stato figo avere una nostra canzone in quel film, che è stato un grandissimo blockbuster.
È evidente, dalle tue memorie, che non sei mai stato un amante delle droghe, al massimo qualche drink. Eppure negli anni ’80 eri in una band di grande successo, per cui devi averne viste di tutti i colori. Come ti sentivi a frequentare quel giro di persone?
Ammetto che spesso mi sono sentito a disagio o in imbarazzo. Ed era anche una situazione pericolosa: se in America ti beccavano per un reato collegato alla droga, erano guai seri e rischiavi di non poter tornare nel Paese e quindi non potevi più suonarci. Tutti intorno a me prendevano droghe, ma ho sempre pensato che almeno una persona con un po’ di sale in zucca doveva esserci: qualcuno che mantenesse il controllo e, nel caso, fosse in grado anche solo di guidare. Era una situazione molto frustrante, perché io non ero in quel giro e mi sentivo spesso sotto pressione. Sai, se eravamo in un club, in auto o in una stanza d’albergo e tutti prendevano droghe era molto rischioso. Perché c’era il pericolo tangibile di trovarsi la polizia addosso. Se fosse accaduto, sarebbe stato un gran casino. Pessima pubblicità, guai con le autorità, difficoltà a lavorare…
Poi a un certo punto vi siete trovati addosso gli occhi del PMRC.
Proprio prima dell’uscita di Turbo ci stavano col fiato sul collo ed eravamo fra i loro bersagli. Ricordo che eravamo a Los Angeles in studio ai Record Plant per il mixaggio e tutte le sere il PMRC aveva ampio spazio nei notiziari della CNN. Erano ovunque. Era un momento folle. È un dato di fatto che ci sono sempre stati – e sempre ci saranno – movimenti che tentano di limitare la libertà delle persone, ma credo che attaccare la musica e i testi delle canzoni sia stata una cosa davvero pessima. Specialmente in America dove, sulla carta almeno, la libertà di pensiero e di parola sono sacrosante.
Non molto tempo dopo è arrivato il processo di Reno, dove eravate accusati di istigazione al suicidio per via di presunti messaggi subliminali in un vostro brano.
Già: tutto è iniziato con le grane con il PMRC. Poi c’è stato il processo di Reno e fu davvero una disdetta. Sfortuna nera. Il fatto è che in quel momento erano tutti in cerca di un capro espiatorio, volevano a ogni costo qualcuno su cui sfogarsi. Per anni si erano accaniti su Ozzy Osbourne per via del pezzo Suicide Solution, ma non ce l’avevano fatta. Allora è venuto il nostro turno. Ci trovammo gli avvocati alle calcagna, volevano le nostre teste. Ma hanno avuto ciò che meritavano. È stato un periodo molto difficile, anche perché avevamo appena finito di mixare Painkiller e saremmo dovuti partire in tour. Però dovemmo fermarci per un mese intero e andare alle udienze del processo, in aula, a Reno. Alla fine ce l’abbiamo fatta, fummo assolti e – a quanto ne so – non è più accaduto nulla del genere, in seguito. È stato come se, da quel momento, qualcuno avesse deciso di lasciare in pace i musicisti. Forse i Judas Priest affrontando quel processo e venendo assolti hanno fatto un gran servizio a tutta la comunità dei musicisti, creando un precedente positivo.
Da quando te ne sei andato dai Priest nel 2011 dici di non avere più prestato attenzione a ciò che facevano. Sei davvero così disgustato dalla faccenda?
Sì, credo proprio sia così. Le cose sono finite male, nonostante io per i Judas Priest abbia praticamente dato la mia vita. Penso di avere, però, dimostrato molto rispetto per loro, mentre la band nei miei confronti non è stata così diplomatica, né democratica.
I Judas Priest hanno compiuto 50 anni. Avevo letto della possibilità di una celebrazione che ti coinvolgesse, ma ho l’impressione che la faccenda sia sfumata. C’è ancora spazio per una cosa simile, secondo te?
A quanto ne so io, è una faccenda chiusa. Andata. Io ho ricominciato a suonare lo scorso anno e non ho mai perso di vista Richie Faulkner, che aveva detto chiaramente che avrebbe avuto piacere di rivedermi nel gruppo per i 50 anni. Allora ho chiesto anche agli altri se si potesse fare, ma hanno risposto di no. Ok: come desiderano… è un peccato davvero, perché sarebbe stato bello.

So che hai ricominciato a suonare con una band, i KK Priest.
Sì, e abbiamo un album finito, pronto per uscire. Credo che arriverà nel giro di qualche mese. In questo momento l’etichetta si sta guardando intorno per capire come si evolveranno le cose, a causa della pandemia. L’idea è di farlo uscire quando ci saranno le condizioni minime per promuoverlo suonando. Ne stiamo parlando in questo periodo. Comunque se la faccenda andrà per le lunghe, credo che faremo dei video e magari dei live in streaming nel 2021.
Poi dirmi qualcosa dell’album?
Credo molto in questo disco, per me è fantastico. Puoi stare certo che non potrei mai dare in pasto ai fan delle stronzate: loro si meritano del vero heavy metal e possono contare su di me al 100% per averlo. Non è uno di quegli album con due-tre pezzi decenti e poi pieni di cazzate riempitive: è un disco solido, completo, tutto è ottimo. E devo dire che è stato facile, per me, scriverlo: ho composto tutti i pezzi in appena quattro settimane. E adesso non vedo l’ora che i fan ascoltino il mio disco: voglio che il mondo veda chi è il vero dio del metal!