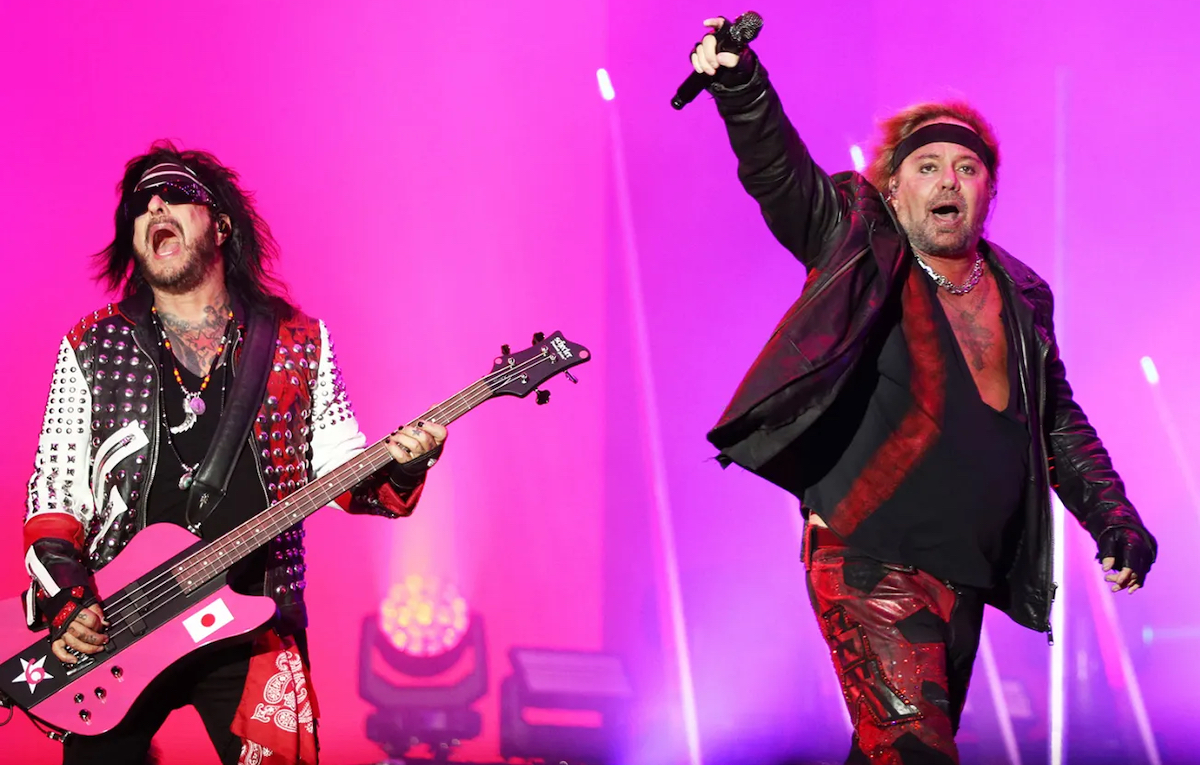Mentre eravamo in tour con i Kiss, la CBS ha pubblicato l’album Unleashed in the East. Non avevamo idea di come sarebbe andato – non avevamo niente con cui confrontarlo – quindi siamo rimasti sbalorditi quando è arrivato nella top 10 in Gran Bretagna, ed è persino entrato nella Billboard 200 in America!
Un album live? Davvero? Sembrava che qualunque cosa toccassimo si trasformasse in oro. Era quasi difficile da concepire.
Ma stavo per fare un’esperienza ancora più difficile da metabolizzare. Dopo la fine delle date con i Kiss, abbiamo fatto dei concerti importanti nei teatri e nelle arene del Texas, del Canada e più a ovest, per poi concludere con uno spettacolo in un posto a noi noto: il Palladium di New York.
La CBS aveva organizzato per noi una festa di fine tour riservata agli addetti ai lavori dell’industria musicale, era in un nightclub chiamato Mudd Club, dove avevamo già suonato. Abbiamo fatto un breve set passata la mezzanotte, e mentre cantavo non ho potuto fare a meno di notare un uomo che scattava foto proprio davanti a me.
Era un tipo minuto, più vecchio di noi, con i capelli ossigenati. Aveva una piccolissima macchina fotografica Olympus, e sembrava la copia sputata di…
“Un momento, non assomiglia a lui. È lui! Andy Warhol!”.
Sapevo tutto di Warhol, ed ero un grande fan della sua pop art e del suo cinema d’avanguardia. Per me, lui era New York nella sua essenza più pura e artistica. A essere sincero, quando me lo hanno presentato dopo il concerto, ero in preda all’emozione.
«Ciao, Andy!», ho esordito. «Grazie di essere venuto! Bel posto, vero? Abbiamo già suonato al Mudd Club una volta!».
«Ah, davvero?», ha biascicato Andy, continuando a fotografarmi mentre parlavo.
CLICK!
«Sì! E stasera abbiamo fatto sold out al Palladium!».
«Ah, davvero?». CLICK!
«Sì. E sono un grande fan del tuo lavoro! Lo adoro!».
«Ah, davvero?». CLICK!
Avevo bevuto un paio di drink, e il suo stile di conversazione monosillabico iniziava a starmi sulle palle. Avevo sempre sentito dire che Warhol era molto impacciato nelle interazioni sociali, e parlava pochissimo, e questo era chiaramente uno di quei casi. Ma anche così… cazzo, stavo parlando con Andy Warhol!
Ho cercato di cambiare argomento. «Mi piace sempre venire a New York!».
«Ah, davvero?». CLICK!
E va bene. Era troppo! Ne avevo abbastanza! Oltre alla frusta, di recente avevo aggiunto al mio costume di scena delle manette, e ne avevo un paio appese alla cintura borchiata. Per qualche strana ragione, le ho prese, ne ho messa una al mio polso e l’altra al polso di Warhol.
Mi ha guardato e ha riso nervosamente.
«Ho una brutta notizia, Andy», gli ho detto.
«Ah, davvero?».
«Ho perso la chiave!».
«AH, DAVVERO?». Erano le stesse parole, ma stavolta la sua voce era salita di tono e intensità.
«No, sto scherzando, amico! Ce l’ho qui!», ho detto, prendendola dalla tasca. Warhol sembrava molto sollevato.
«Ah, davvero!», ha sorriso.
Poi ha variato la sua conversazione quel tanto che bastava da suggerire che andassimo allo Studio 54. Siamo usciti insieme, abbiamo chiamato un taxi, e mi sono seduto dietro con lui mentre attraversavamo il traffico delle prime ore del mattino di Manhattan.
Ho guardato fuori dal finestrino mentre realizzavo dove mi trovavo e con chi. Stava succedendo davvero? Non ero più in Kansas – o a Bloxwich! Quando siamo arrivati allo Studio 54, Andy Warhol è rimasto con me per un paio di minuti… poi se ne è andato. Svanito nella folla. Non l’ho mai più rivisto.
Ho ancora delle foto di quella famosa notte, e quando le guardo mi salta agli occhi una cosa. La mia t-shirt. Aveva stampata sopra l’opera di un famoso artista erotico gay, Tom of Finland, un’orgia omosessuale in piena regola: un tripudio di cazzi eretti, culi, fellatio e penetrazione anale.
Ora mi chiedo: che diavolo mi passava per la testa? Ero ancora fermamente non dichiarato, e terrorizzato all’idea di farlo, eppure quella maglietta era come un’insegna al neon che lampeggiava sopra la mia testa: «SONO GAY!».
Per avere un’idea dell’angoscia e dell’agitazione che mi hanno tormentato per decenni di Judas Priest, non c’è niente di meglio di quelle foto di me e Warhol. Desideravo profondamente uscire allo scoperto e smetterla di vivere nella menzogna, ma non vedevo come potesse accadere.
Non c’è da stupirsi che bevessi, cazzo…
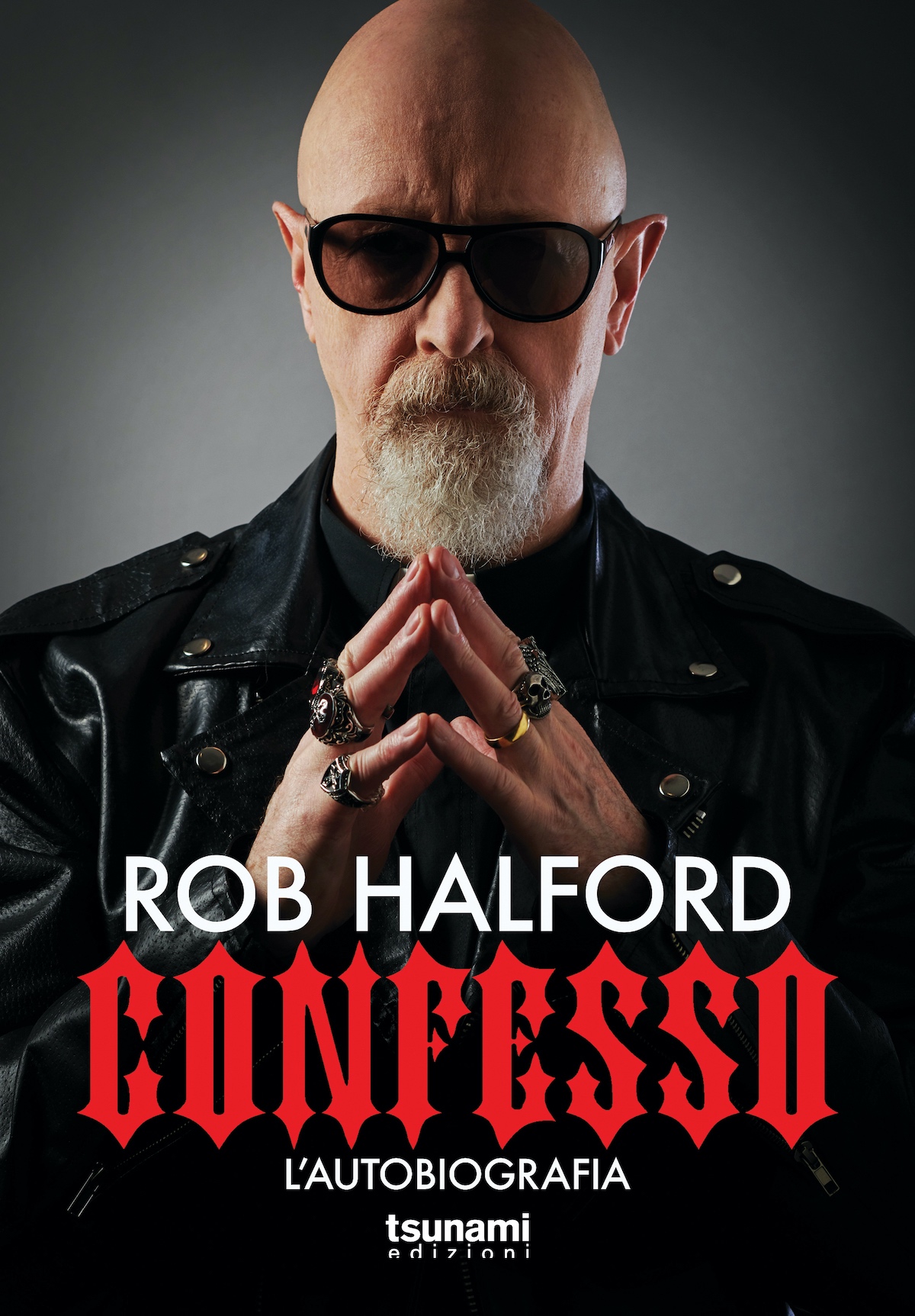
Il nostro anno in tour stava per finire. Ho passato meno di una settimana a Larchwood Road, chiacchierando con Nick, Michael e Denise dell’incontro con Cher e di essermi ammanettato ad Andy Warhol, prima che arrivasse il momento dell’ultima tappa della nostra odissea: andare in Europa come gruppo spalla degli AC/DC per il loro tour a supporto di Highway to Hell.
Era una cosa grossa per noi. Eravamo grandi fan dei rocker australiani, che erano già famosissimi. E, come per il tour dei Kiss, sapevamo che era un’opportunità di presentarci a centinaia di migliaia di fan del metal che probabilmente ancora non ci conoscevano. Dovevamo sfruttare questa occasione. Invece di sprecare denaro con gli hotel, abbiamo deciso di affittare un tour bus per questo viaggio attraverso Belgio, Olanda, Germania – UN SACCO di date in Germania – e Francia. Ne abbiamo preso uno abbastanza grande per la band, la crew e l’attrezzatura.
Sarebbe giusto descrivere questa decisione come un falso risparmio. Va bene stare in giro così per due o tre giorni, ma vivere ammassati uno sull’altro per settimane finisce per darti sui nervi. Eravamo come animali in trappola, stipati dentro quel bus, e abbiamo iniziato ad andare fuori di testa.
Odiavamo quel cazzo di tour bus.
Stavamo andando bene con i fan degli AC/DC, ma non vedevamo molto gli headliner. Di solito finivamo il nostro set e poi dovevamo metterci in marcia tutta la notte verso la città successiva. Dopo alcuni giorni, Angus Young è venuto a cercarci.
«Non vi siamo simpatici?», ci ha chiesto.
«Eh? In che senso?».
«Non state mai con noi!».
«Oh, ci piacerebbe!», gli abbiamo assicurato. «Non è niente di personale! Ma dobbiamo andarcene subito dopo gli spettacoli perché viaggiamo su uno stupido maledetto tour bus!».
«Oh, lasciatelo perdere!», ha detto Angus. «Venite con noi sul nostro bus, e facciamoci una birra!».
Quando ci siamo resi conto che il loro “tour bus” era un mezzo di gran lusso, con aria condizionata e ogni genere di comfort, abbiamo accettato senza esitazione.
Quindi abbiamo iniziato a fare così quasi tutte le sere. Gli AC/DC erano fantastici, ragazzi davvero generosi, una piacevole compagnia. Io e Bon Scott ci intendevamo alla grande, due cantanti che parlavano a ruota libera sul loro tour bus (che era davvero molto più lussuoso del nostro).
Angus Young difficilmente beveva. Gli ho chiesto perché non toccasse mai un goccio di alcol. «Perché se bevo un solo drink, vado fuori di testa», mi ha risposto. Non sapevo se stesse scherzando, ma poi una sera ho visto con i miei occhi che era vero. Aveva bevuto letteralmente un solo bicchiere di champagne e nel giro di pochi secondi era ubriaco fradicio. L’ho visto cambiare in un attimo.
Bon Scott era l’opposto. Lui beveva in continuazione: era un pozzo senza fondo per l’alcol. Beveva fino a crollare sul letto e perdere i sensi, poi il giorno dopo usciva dalla sua cuccetta e saliva dritto sul palco. Lui funzionava così.
E dopo quelle serate non era mai uno straccio. Sembrava indistruttibile. Alla fine del tour per Highway to Hell, gli AC/DC e i Priest si sono abbracciati e hanno promesso che avrebbero fatto un nuovo tour insieme. Quattro settimane dopo, Bon è andato in overdose ed è morto. Ne siamo rimasti davvero sconvolti.
I Priest hanno concluso il 1979 esausti ma euforici. Che anno! L’album e i singoli erano stati un successo, eravamo stati in tournée in tutto il mondo con alcuni dei più grandi gruppi rock, avevamo conquistato innumerevoli nuovi fan… e io mi ero ammanettato ad Andy Warhol.
Ricordo di aver pensato che era difficile immaginare che le cose potessero andare meglio di così. Quanto mi sbagliavo. Perché stavamo per realizzare l’album che ci avrebbe fatto esplodere come una supernova.
Tratto da Confesso – L’autobiografia di Rob Halford
, traduzione di Valeria Presti Danisi, Tsunami Edizioni