In principio c’erano i Panic e provavano nel garage della famiglia Ginn. Poi si accorsero che già esisteva un’altra band con lo stesso nome: bisognava cambiare ragione sociale. In loro soccorso arrivò il fratello di Greg Ginn, chitarrista e leader della formazione. Fu, infatti, Raymond Pettibon (all’anagrafe Raymond Ginn, classe 1957) a suggerire di chiamarsi Black Flag. E a disegnare il logo minimale destinato a diventare un’icona punk (e non solo).
Pettibon – che deve il suo nome d’arte al soprannome con cui il papà lo chiamava da bambino: “Petit Bon” – è oggi un artista quotato. Ha rischiato di diventare un insegnante di matematica, ma il punk rock, spingendolo a disegnare copertine per dischi e volantini di concerti, gli ha dato la spinta decisiva per concentrarsi sulla sua arte, con un successo che sembrava impensabile. Ora è un disegnatore di fama mondiale, con una passione non esattamente condivisibile (per non dire illegale e riprovevole): alleva pitbull e molossi da combattimento.
Tutto il contrario del fratello Greg che, dopo l’implosione dei Black Flag e l’ibernazione della SST Records (a causa della bancarotta del distributore DNA), oltre a suonare con una miriade di progetti e in una discutibile reunion dei Black Flag, si è votato alla causa felina, sostenendo organizzazioni che si occupano di gatti randagi – pare sia arrivato ad averne circa 80 lui stesso, tutti salvati dalla strada. Cani e gatti. Così come cane e gatto sono i due Ginn, che da anni hanno rotto i rapporti.
Ma torniamo all’età dell’oro, alla seconda metà degli anni Settanta, quando i Black Flag iniziano a suonare nel sobborgo di Hermosa Beach e Raymond, già appassionato d’illustrazione, diviene colui che cura tutto l’aspetto grafico della loro comunicazione: sembra che solo lui riesca a tradurre in disegni e slogan il nichilismo e l’attitudine “contro tutto” della band, che coniuga un suono punk estremizzato – precursore dell’hardcore – e testi abrasivi come “I wanna live / I wish I was dead” oppure “Depression’s got a hold on me / Depression / Gotta break free”.
A Pettibon, come si accennava, si deve il nome del gruppo, così come il logo. Black Flag, bandiera nera, è anche il nome di un noto insetticida, oltre a richiamare i Black Sabbath – una delle formazioni preferite di Ginn. Il logo è un vero colpo di genio, una specie di uovo di Colombo del punk: si tratta della rappresentazione grafica stilizzata di una bandiera nera, resa con quattro barre sfalsate. E nient’altro. Il significato l’ha illustrato in poche parole l’autore stesso spiegando: “Se una bandiera bianca significa resa, una nera rappresenta l’anarchia”. Liberi tutti, quindi, e nessun compromesso – figurarsi una resa.
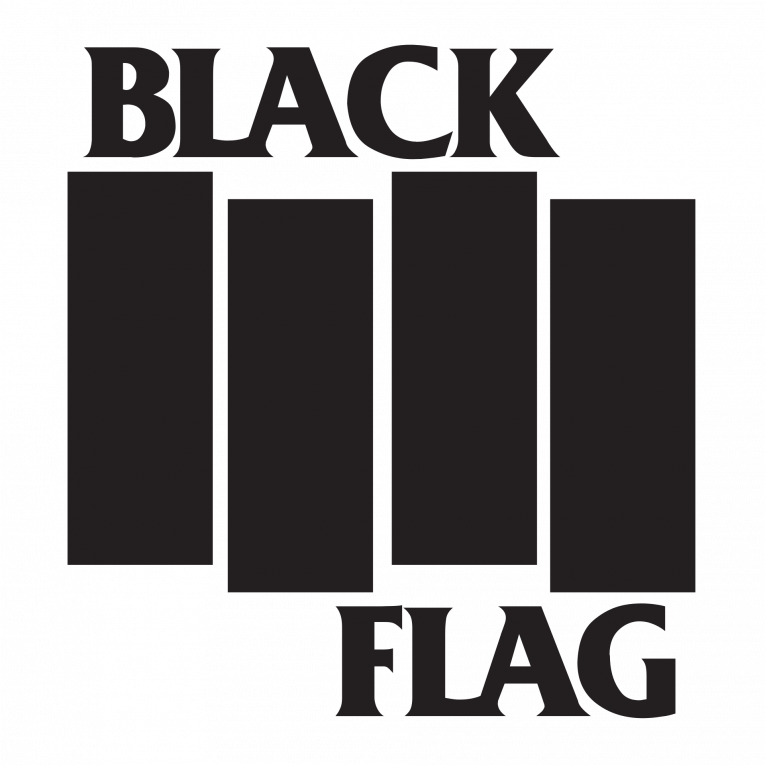
Il logo disegnato da Raymond Pettibon, via Wikimedia commons
In un’intervista del 2005 rilasciata alla testata online The Believer, Pettibon approfondisce il rapporto fra la propria arte e il punk – spesso visti, da occhi esterni, come elementi complementari. In effetti non è proprio così: “La musica era una cosa, l’arte un’altra, e non avevo alcuno standard di riferimento per ciò che facevo. Se osservi le copertine dei vecchi dischi punk, vedrai spesso immagini del costruttivismo sovietico o collage di Heartsfield. Non c’era uno stile o un’immagine punk definita. Almeno non dal punto di vista artistico. Forse c’era a livello di moda e look. Il mio lavoro consisteva per lo più in disegni, più o meno gli stessi che ancora faccio. Non erano realizzati con la minima aspirazione da parte mia a divenire parte di quella scena. Non erano punk. Erano solo raccolte di disegni e alcuni li fotocopiavo e li vendevo. E neppure si può dire che io li smerciassi nella scena punk: quello era un pubblico troppo difficile da conquistare. Vendevo a chiunque li volesse. Ma non ho mai avuto la minima intenzione di tirar su soldi col punk. Non avrei mai potuto fare l’artista commerciale. Non ne ero in grado allora e non lo sono ancora oggi, perché non ne ho il temperamento e non mi interessa disegnare o fare arte per qualunque scopo diverso dal mio diletto personale. Preferirei fare qualsiasi altra cosa, piuttosto che arte commerciale”.
Ad ogni modo, Raymond era l’artista “unofficial”, ma “resident”, dei Black Flag e della loro etichetta, la SST. E fin dal primo giorno i Black Flag e i loro accoliti presero a disegnare in giro le quattro barre nere su muri e superfici di ogni tipo, contribuendo a creare una sorta di culto che alimentava la nascente leggenda della band.
Nella sua semplicità disarmante, la bandiera nera stilizzata era ed è di una potenza irresistibile: incarna l’idea di ribellione e l’urgenza della grafica punk, ma soprattutto è riproducibile con pochi tratti da parte di chiunque, fatto che ne contribuisce la diffusione a macchia d’olio – ai giorni nostri si parlerebbe di “viralizzazione”.
A questo proposito è impossibile non citare il dato per cui le quattro barre dei Black Flag ideate da Pettibon sono uno dei tatuaggi più diffusi nella community legata agli appassionati di punk, hardcore e derivati. Questo è il chiaro segnale della forza di questo logo e di come si sia trasformato, col tempo, in un’icona. Anzi, per dirla con Stewart Dean Ebersole, è diventato la “punk rock’s secret handshake”, ossia una specie di segnale per iniziati del circolo punk rock la cui vista rende subito riconoscibili i membri di una “tribù”.
Ebersole in questo campo è decisamente una voce attendibile, in quanto autore di Barred For Life – un libro che raccoglie fotografie scattate in tutto il mondo, Italia compresa, di gente con tatuaggi dei Black Flag (le barre in particolare). Il volume, pubblicato nel 2013 da PM Press, è il risultato di cinque anni di viaggi per il pianeta a scattare foto e intervistare persone, fra cui anche alcuni ex Black Flag (manco a dirlo, Henry Rollins e i fratelli Ginn non hanno acconsentito a partecipare).
L’idea è nata proprio dall’osservazione di quanto questo logo sia popolare come tatuaggio. Stando a quanto afferma Ebersole, oltre a migliaia di fan nel mondo, hanno impresso sulla loro pelle le quattro barre anche diverse celebrity apparentemente insospettabili: nomi del calibro di Bryan Adams (sì, il rocker/balladeer canadese, quello di Run To You), l’attore Edward Norton (pare le abbia sulla schiena), il “pirata dei Caraibi” e non solo Johnny Depp, la star hollywoodiana Angelina Jolie (anche se non è confermato al 100%). Chissà cosa ne pensa Henry Rollins – cantante della band dal 1981 fino allo scioglimento – che intervistato, nel 1982, alla domanda “cosa penseresti se una ragazzina di 15 anni si facesse un tatuaggio dei Black Flag sulla fronte?” rispondeva: “Figo. Le darei un coltello, un po’ di acido, la punterei verso ovest e le direi: ‘Uccidi, uccidi!’”.
Uno dei primi a fissare la bandiera nera stilizzata sulla propria epidermide con aghi e inchiostro è invece stato proprio un componente della band, ossia Dez Cadena. Nel libro di Ebersole racconta: “Ho fatto le barre nel 1980. C’era qualcuno nel giro punk rock con dei tatuaggi, ma erano quasi tutti cuori spezzati trafitti da una freccia, pistole, sirene o soggetti tradizionali. Non vedevi quasi nessuno con un tatuaggio – per esempio – dei Sex Pistols. Henry [Rollins] non era ancora nella band e quando si è unito al gruppo non aveva un tatuaggio dei Black Flag. A dire il vero non aveva neppure un tatuaggio. Per quanto ne so io, non avevo mai visto nessuno prima di me con un tatuaggio così. Avevo invece visto qualche tatuaggio dei Germs, i cerchi blu, che erano l’evoluzione delle bruciature di sigaretta che le persone del giro dei Germs si facevano sulla pelle per riconoscersi”.
Pettibon, in un certo senso, ora rinnega il suo legame coi Black Flag – o, quantomeno, lo identifica maggiormente come un problema, piuttosto che come elemento positivo. È arrivato a dire, a Huck Magazine nel 2014: “Essere bollato come artista punk e in particolare artista punk che fa copertine di dischi non è stato il modo migliore per affacciarmi al mondo dell’arte. Io in realtà facevo solo dei disegni e non li concepivo perché diventassero copertine dei dischi dei Black Flag – loro li sceglievano e li usavano. Onestamente, credo che questa faccenda mi abbia tenuto al palo per almeno una decina d’anni, perché mi piazzavano nella categoria degli illustratori o degli artisti punk – e succede ancora”.
Eppure, ironia della sorte, Raymond rischia ogni giorno d’incontrare per strada – magari a New York, dove vive, o in qualche altro angolo di mondo – persone con la sua bandiera nera stilizzata marchiata sulla pelle a eterno ricordo di quella scena punk in cui si è trovato a muovere i primi passi. Ma soprattutto come reminder incancellabile dell’impatto che quattro semplici sbarre nere hanno avuto su intere generazioni e sottoculture giovanili – con effetti che ancora oggi, a 40 anni abbondanti di distanza, si fanno sentire inequivocabilmente.











