Siamo nel 2020, anno in cui, situazione corrente a parte, dovremmo avere il tanto sperato futuro fatto d’innovazioni, salti in avanti, pionierismo assoluto. Se non nella società (cosa alla quale oramai crediamo poco) almeno nell’arte. Nella musica, con la sua capacità di unire in qualche modo diversi mondi, soprattutto ci aspettavamo un anno scoppiettante pieno di artisti, se non originali, almeno controversi, che fanno parlare di sé. Invece no: la controversia dura il tempo di uno sbadiglio e poi si torna alla pantofolaia normalità. Ma una band forse è riuscita nel miracolo di mescolare le carte e di far discutere a distanza di tempo: stiamo parlando degli Autechre, che guarda caso, hanno appena fatto uscire il loro nuovo lavoro, l’enigmatico Sign, in un 2020 che non poteva appunto finire senza che loro ne lasciassero uno, di segno.
La band è senza dubbio quella che più di tutti nel campo della musica elettronica è riuscita a incasinare la mente di critica e pubblico come di fronte a un rebus: ci sono discussioni, topic, forum sull’opera di questo duo il quale per far parlare di sé non usa avanzate tecniche di marketing, ma semplicemente fa uscire il disco e sparisce dalle scene. Non imitano la tecnica della teoria dell’invisibilità di residentsiana memoria (quella sì fin troppo studiata a livello commerciale): semplicemente se ne fottono con un candore estremo. E questo fa impazzire un po’ tutti, primo perché in un’era come questa in cui cani e porci si fanno autopromozione sfacciata è difficile capacitarsi di un tale comportamento; secondo perché, anche se non disdegnano di rispondere ai loro fan e fare interviste, molti sono convinti che non la raccontino giusta. Se poi contiamo che a volte queste interviste gli ascoltatori manco le leggono, circolano delle leggende che li circondano abbastanza assurde, ad esempio sui “fantascientifici” strumenti usati (la storia dell’utilizzo di AI autogenerative per i dischi è fasulla, eppure…).
Conseguenza di questo fottersene è che Autechre oramai è… boh, una cosa epica, una roba tipo Omero, un totem: in questi ultimi anni hanno raccolto il frutto delle loro passate fatiche, quando la critica cercava di inquadrarli in un’etichetta, ma l’IDM andava loro stretta e così tutta l’elettronica che circolava intorno. Adesso finalmente è esploso – e in un certo senso oramai già storicizzato – il genere HD, e quell’alternanza tra melodie e suoni astratti ad alta definizione rivela una pesante e chiarissima influenza autechriana tanto che ora questi ultimi sono in sostanza visti come gli inventori della tendenza. E quindi uno direbbe: vabbe’ a questo punto saranno compresi… beh, no. Sul nuovo album Sign la critica e il pubblico si sono divisi, come se Rob e Sean portassero inevitabilmente la gente a spaccare il capello in quattro. C’è chi ne loda la vena romantica, chi rimane deluso affibiando loro l’epiteto ingeneroso di svolta commerciale, altri invece sono entusiasti di questa nuova prova per il suo rinnovato astrattismo in equilibrio con la composizione musicale vera e propria, sul filo del pop.
Non ce ne stupiamo, perché non è la prima volta che si rimane spiazzati di fronte a un loro disco. E allora, invece di farvi la recensione di Sign, vi presentiamo cinque loro dischi (sorvolando per questioni di sintesi sui pur fondamentali e notevoli EP che tempestano la loro carriera) che hanno fatto discutere. Ovviamente dal punto di vista della critica: confusa dall’”imprevedibilità”, dall’“inafferrabilità” del duo. Alla faccia di chi dice che la musica è universale a capirsi.
“Confield” (2001)

Con questo disco gli Autechre vengono direttamente da LP5 che, oltre ad essere uno dei miei dischi della vita, è considerato quello che porta finalmente il duo lontano dalle sabbie ambient delle prime prove verso territori inesplorati. Insomma, la cosa diventa più astratta, i suoni si trasformano piano piano in veri e propri idiomi di un linguaggio cibernetico, le melodie sono frantumate in una sorta di gioco di prestigio “vedo non vedo”. Se però LP5 aveva un certo equilibrio tra “il prima e quello che sarà”, lasciando appunto gli ascoltatori appesi alla curiosità di sapere come va a finire, ecco: va a finire con Confield, che spinge sull’acceleratore dell’“incomprensibile”, dello “spezzato”, dell’“arrotolato”, tirando fuori delle emozioni al silicio prima inedite che ovviamente saranno interpretate da molti come fredde, robotiche, algide, ecc. Ma di freddo Confield ha davvero poco, semmai è un corpo che cerca calore, che sia di ferro o di carne.
La critica reagirà col disco in maniera controversa: Pitchfork ne loda la materia sonora che provoca delle reazioni inedite nell’ascolto e invita a farsi trascinare prendendosi il tempo necessario, mentre All Music e altri del settore lo vedono come un disco rispettabile, ma non godibile (il che sembra un paradosso, no?). La cosa meravigliosa è invece la recensione del Washington Post che senza mezzi termini descrive il disco come un CD che salta eternamente, regalando al duo una delle recensioni negative più buffe della loro carriera. All’epoca in effetti ascoltare Confield era, per gli iniziati, una vera rivelazione: qualcosa dopo il quale nulla sarebbe stato lo stesso, una spallata sonora rispetto alla roba del periodo storico in cui usciva, ma parallelo ad altre esperienze e realtà che prenderanno più avanti il posto nel gotha dell’elettronica (ad esempio la roba della Mego). Col tempo infatti è diventato un classico del gruppo e anche i più scettici dovettero rivalutarlo ammettendo di non averci capito un cazzo.
“Untilted” (2005)
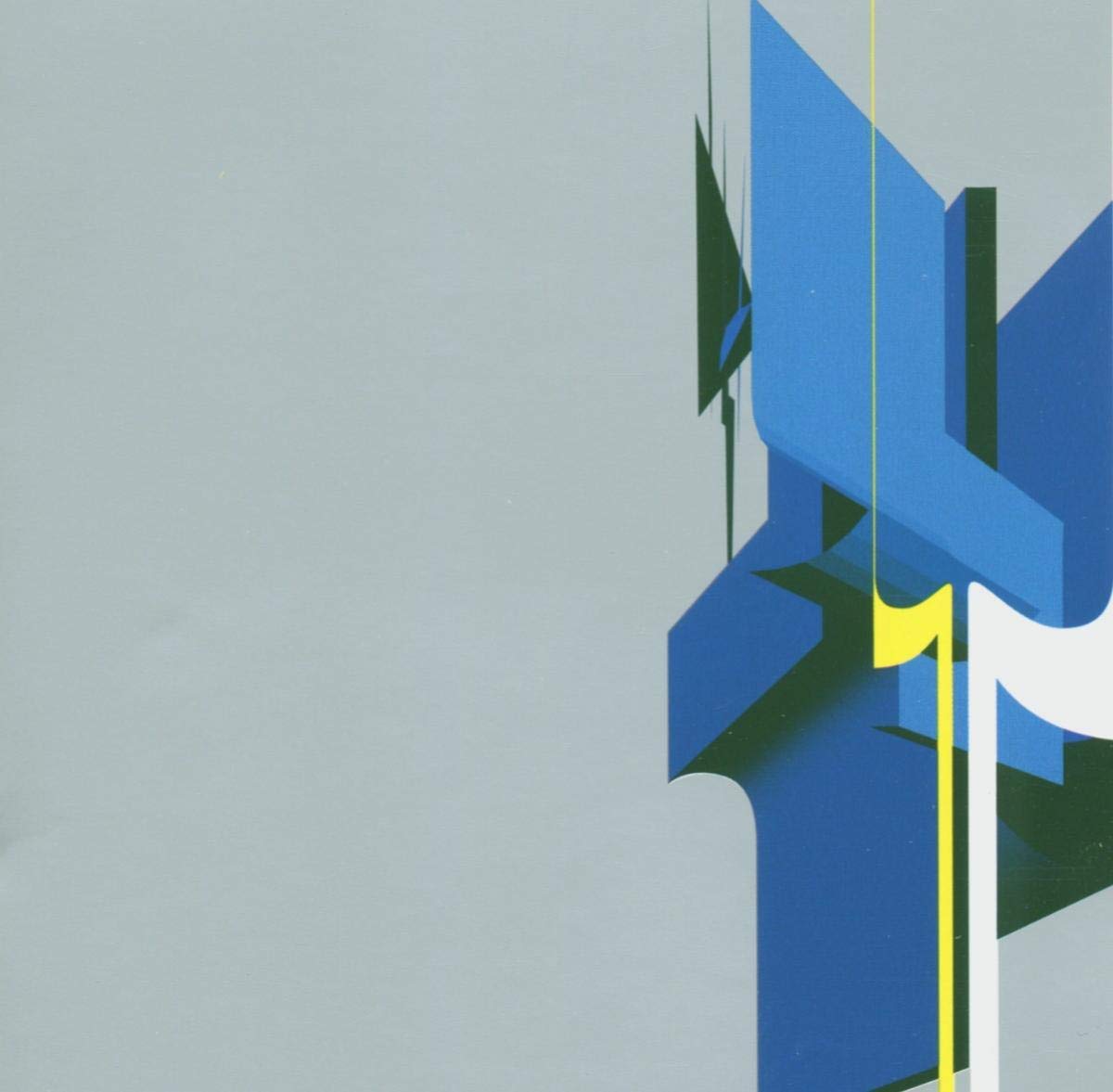
Disco che annovero tra i miei preferiti di sempre del loro catalogo, se non IL preferito: e il motivo mi è oscuro, devo essere onesto. Forse perché in Untilted si predilige la percussione, le sberle elettroniche in faccia, il ritmo spigoloso, la frenesia automatica, è una vampata di adrenalina in bocca. La melodia non è certo sparita, ma serpeggia tra le maglie di grossi magli robotico-idraulici, è come una specie di animismo moderno in musica: basta ascoltare Fermium per capire che qualcosa di misterioso si cela dentro questo disco, come se cercasse di smontare il computer che controlla il mondo per vedere com’è fatto dentro.
Ovviamente questo sforzo non fu compreso appieno dalla critica: l’Independent lo stroncò come un mero insieme di “click and bleeps” senza un minimo di struttura comunicativa, altri come Sputnik Music ne lodano il fatto di essere oltremodo incompromissorio e la particolarità che si possa ascoltare come si studia un fenomeno spaziale sconosciuto. Altri ancora rimangono neutri, affascinati dal progetto, ma incapaci di inquadrarlo dal punto di vista del giudizio. Nessuno però che lo descriva come un’esperienza godibile, piacevole, in poche parole emozionante. E invece forse è uno di quei dischi in cui i nostri prendono i loro nervi e te li mettono addosso: impossibile uscirne indifferenti se veramente si entra nei suoi solchi. È una specie di ribollire di lava metallica in un vulcano artificiale, pronto a esplodere da un momento all’altro. Per dirla tutta è l’altro lato della medaglia di Oversteps: dove lì ci sarà melodia, armonia e quindi un ritorno agli Autechre “ben temperati” che decidono di emozionare anche l’uomo medio, qui c’è l’opposto per ottenere un’emozione uguale e contraria a qualsiasi tipologia di ascoltatore.
“Quaristice” (2008)

Prima di arrivare all’acclamato e succitato Oversteps del 2010, subito accettato da critica e pubblico per la sua forma musicale più “canonica” e trampolino di lancio per imitatori scrausi come Oneohtrix Point Never, disco in qualche modo concepito per essere un classico e quindi – forse – più artificiale degli altri nella sua composizione, vi è l’ennesimo album semibistrattato, in altre parole Quaristice. Un disco che si dipana in ben 20 brani, in 77 minuti pieni, mescolando alcune jam quasi tutte di pochi minuti, come fosse una specie di raccolta di miniature elettroniche.
Stavolta alcuni critici riconoscono il ritorno ad un modus operandi più ascoltabile, e questo è vero nonostante inquietanti suite con voci artificiali, sbarattolate tirate oltremisura e scarnificazioni acid. Altri invece continuano – come l’Independent – a dire che il duo cerca in tutti i modi una struttura alternativa a quella conosciuta nella musica dance senza trovarla mai. Altri (come Pitchfork) continuano a parlarne bene sottolineando però che il divertimento passa in secondo piano, come se per forza dovesse essere un ascolto “serioso” o “difficile”: quindi tutto sommato ne parlano male. Quaristice nella discografia del gruppo rappresenta invece uno dei passi più caldi e umani del duo, essendo nato proprio da jam session quasi ispirate all’improvvisazione jazz: ma d’altronde anche il Miles Davis elettrico dei ’70 da molti critici è visto come freddo, asettico, incomunicabile: non sarà che siano codesti criticoni ad avere le orecchie foderate di prosciutto?
“Exai” (2013)
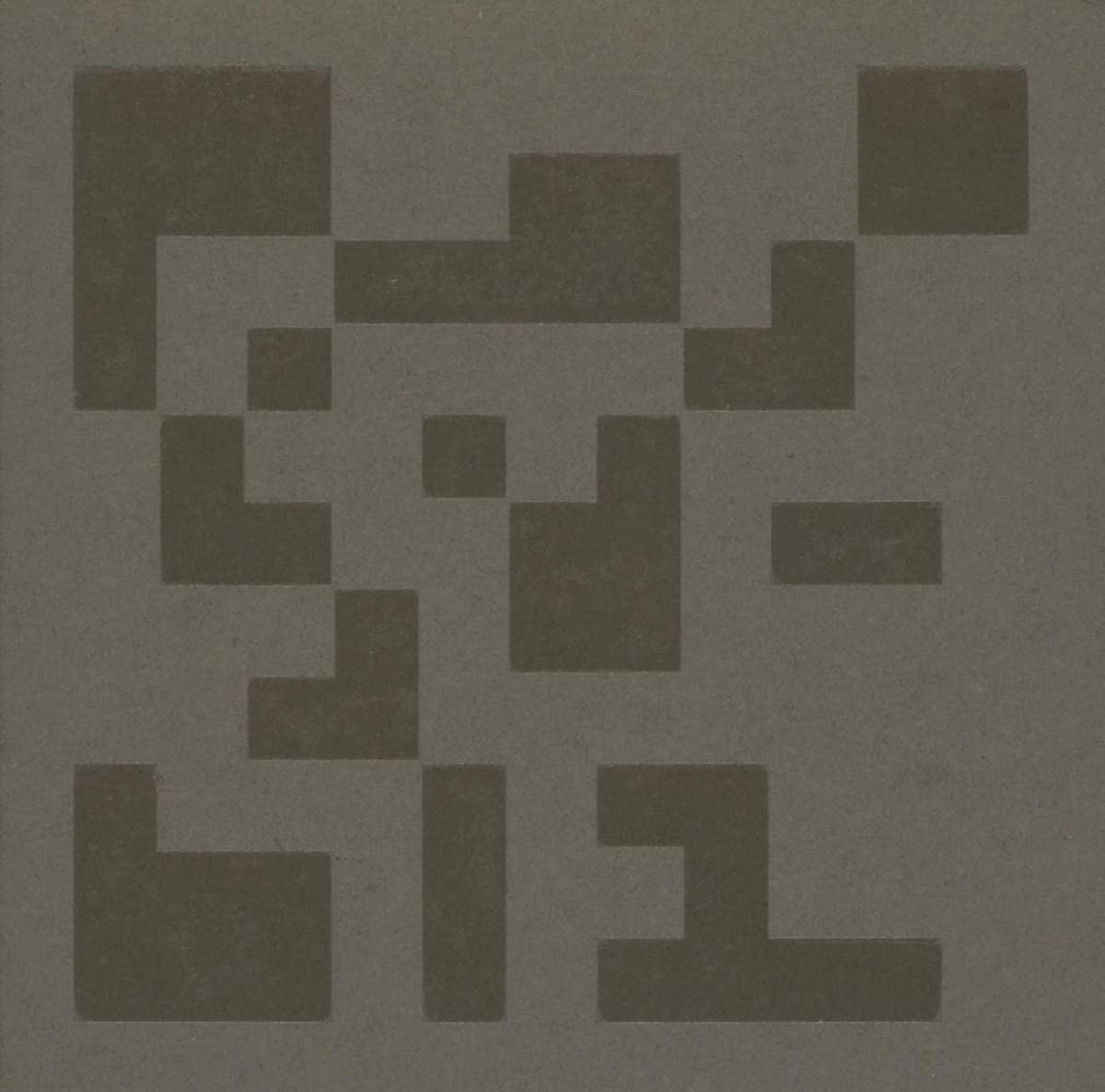
Quando Exai venne alla luce, non potevo credere alle mie orecchie e il disco subito si piazzò nella mia top di sempre dei dischi del duo. Una sorta di colonna sonora della conquista di altri pianeti, non saprei come altro definirlo seppur ci abbia provato (chiaramente fallendo) recensendolo appena uscito. La scelta di raccogliere brani dalla durata allucinante (quindi l’opposto di quanto sperimentato in Quaristice) che diciamo possiamo misurare nella media di 8 minuti l’uno per un totale di megalitici 129 minuti di musica fece storcere il naso a molti critici vedendola come un’operazione pigra e paracula, asserendo che i brani avrebbero avuto bisogno di un editing che li snellisse. Figurarsi quando, più tardi, sono usciti AE_LIVE, elseq 1-5 e le NTS Session, delle raccolte/pachiderma dalle durate folli: a quel punto era chiaro che i nostri sfidavano il difetto d’attenzione contemporaneo per portare l’ascolto in zona più dinamica. Un po’ come fosse musica classica anche se nella realtà a loro non interessa dimostrare alcunché, quanto suonare e registrare. Exai ha rotto il tabù della musica di lunga durata in un’epoca in cui è tutto velocissimo, rallentando i giri come un astronave che per arrivare al pianeta di destinazione necessita di anni luce di viaggio.
“Sign” (2020)

Eh sì, alla fine ho barato: il quinto album che prendiamo in considerazione è proprio il nuovo Sign. Perché? Perché appunto alla sua uscita ha visto gli ascoltatori dividersi. Un disco senza dubbio più accessibile dei precedenti, come se i due volessero prendersi una pausa dalle loro elucubrazioni, dilatarsi armonicamente, diventare più intimisti in un periodo complicato come quello che stiamo vivendo. Paddoni che sembrano droni che sovrastano un pianeta Terra desertificato, ma finalmente felice, come se l’assenza dell’uomo oramai estinto fosse la chiave per ricominciare: i momenti migliori del disco sono questi, compatti e marmorei, quasi estratti da un film di Carpenter, in cui è evidente che non serve oramai tutta questa tecnologia quanto un nuovo minimalismo in musica per recuperare la propria in/umanità. In si00 addirittura si riaffacciano quasi dei pascoli di pecore e capre mutanti con annessi campanellini, in una visione campestre da dopobomba. E poi ovviamente la tradizione dei ritmi incastrati, delle batterie elettroniche che sembrano autogenerarsi, così come una strizzatina d’occhio ai loro “pupilli HD”, riprendendosi la scena da capiscuola utilizzando le stesse armi della “concorrenza” (in alcuni casi sembra che vogliano addirittura sfidare i vari Arca & co. nel loro campo, ovviamente facendo molto meglio).
Questo loro indugiare sul sistema temperato ha riaperto l’annoso dilemma: gli Autechre ci sono o ci fanno? Sono davvero sperimentatori, fanno ricerca o semplicemente “raffazzonano” i loro brani spacciandoli per arte “incomprensibile”? Sono dei geni oppure degli impostori che vendono fumo per arrosto continuando ad attraversare campi battuti e ribattuti nella musica imbellettandoli solo di rumorini e scappellotti elettronici che distraggono dalla sostanza, utilizzando per esempio il programma Max/MSP al 9% delle possibilità perché in fondo “nun so boni a usallo”? Ecco, per quanto ci riguarda tutto può essere e nulla può, ma gli Autechre sono come la nostra squadra del cuore: non si discute, si ama. Non ce ne vogliano quindi i critici puntigliosi, i puristi della musica sperimentale e i sapientoni da discussione Facebook: noi questo Sign lo abbiamo colto e ce lo teniamo così com’è. Perché è forse l’unico segno tangibile di liberazione da questa balorda era musicale.











