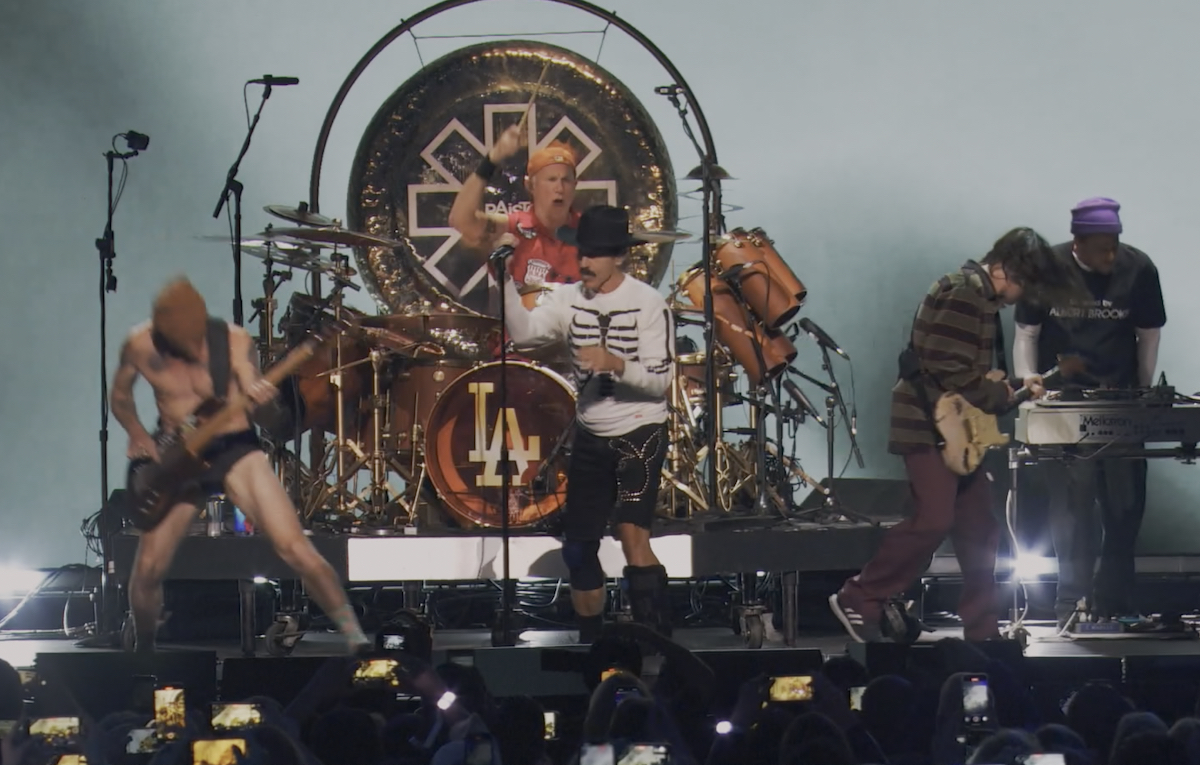Bologna, Milano e Mestre, in tre serate brumose di metà dicembre, sono tre luoghi e momenti ineccepibili per il manifestarsi di una strana, rassegnata eppure indomita cospirazione proveniente dalla Germania. Come se una lontana reminiscenza di anni plumbei vissuti dalle tre città ma per lo più dimenticati fosse un ingrediente essenziale per queste piccolissime adunate segrete, nel nome di Faust.
C’è però una premessa doverosa da fare, e non necessariamente a detrimento dell’evento cui abbiamo assistito, insieme a una cerchia ridotta (ma inaspettatamente transgenerazionale) di iniziati. Ed è che la formazione di cui stiamo per parlare si può definire “Faust” nella misura in cui un quintetto di musicisti radunato da Nick Mason si potrebbe definire “Pink Floyd”. E se qualcuno volesse individuare nei concerti di questa formazione una componente nostalgica, questa sicuramente non è contenuta in ciò che ha ascoltato il pubblico: non è stato proposto alcun brano appartenente alla storia del gruppo.
Del resto il 75enne Werner “Zappi” Diermeier, batterista e uomo di fatica del comitato faustiano originario, è oggi attorniato da musicisti che non sono stati realmente parte del collettivo di Wümme, Sassonia. Con lui ci sono Ilpo Väisänen (ex Pan Sonic) che manipola qualcosa di molto elettronico come del resto la compassata Elke Drapatz, vicina all’immobilità di Robert Fripp (ma in piedi), l’avanguardista di lungo corso Uwe Bastiansen con tastiere e chitarra elettrica, e il bassista Dirk Dresselhaus alias Schneider TM. Gli ultimi tre sono anche coinvolti nell’album Blickwinkel, uscito due mesi fa, delle cui tracce vengono sostanzialmente proposte delle versioni rielaborate, rimescolate ed espanse. Molto espanse. In più direzioni.
Nel corso della serata intermedia, quella di Milano, sono stati eseguiti cinque lunghi brani. Molto lunghi, almeno 10 minuti. Impossibile chiamarli canzoni, perché non è previsto che qualcuno canti. È una prima differenza cruciale rispetto ai Faust originari, nei quali c’erano le anime istrioniche e situazioniste di Jean-Hervé Peron e Joachim Irmler che contribuivano con le parti vocali e le ambizioni poetiche a quello che più che un gruppo era un’entità dedita ad attività anarco-insurrezionali sperimentali quanto volete, ma più assimilabile ai Soft Machine o ai Gong che non ai Kraftwerk o ai Tangerine Dream. Poi, certo, la xenofoba critica inglese ci ha insegnato a fare della nazionalità un ghignoso cliché artistico-gastronomico. Parlando della Perfida Albione, è sintomatico che un paio di anni prima dei Sex Pistols, i Faust avessero solleticato le velleità radical-chic della Virgin di Richard Branson, che li mise sotto contratto rendendo popolare nel Regno Unito un gruppo in realtà più interessato a confondere le masse che non a eccitarle. Ma ben presto, come tante avventure politiche e artistiche che negli anni ’70 si collocavano ai limiti del ragionevole, furono i Faust a implodere. I componenti hanno finito per mettere in piedi diversi gruppuscoli, singole cellule dormienti che non sono più in grado di operare nessuna sovversione.
E così, eccoci oggi a Zappi Diermeier, irriducibile sopravvissuto di quel gruppuscolo di sovversivi. È un po’ – se ci permettete di continuare con la metafora insurrezionale – una specie di Toni Negri, più imponente fisicamente ma decisamente meno interessato ad apparire (…provateci, a cercare materiale su di lui in rete), che continua a inseguire insieme ai suoi nuovi complici una sua alternativa alla musica stravincente di questo secolo. Lo fa con una performance di improvvisazione elettronica e industrial, che non fa perno sulla batteria elettronica, oh no: bensì su tamburi e piatti che picchia vigorosamente ma senza cedimenti, da vecchia, imponente e sudata Mensch-Maschine testardamente determinata a combattere l’algoritmo col suo personale ritmo. Col basso di Dresselhaus, crea groove martellanti e non di rado irresistibili, su cui gli altri tre rumoristi partono per orbite alienate nelle quali affiora di tutto, da Stockhausen ai Grateful Dead, dai Tangerine Dream ai Van Der Graaf Generator. E già che li abbiamo evocati, forse pure i Pink Floyd, quelli appena prima della gita a Pompei, beninteso.
Il pubblico pare affascinato (perlomeno quello della performance milanese) e applaude convinto. La sensazione è che in un’epoca in cui, dal pop al rock ai criminalini vezzosi della trap, ogni concerto è un omaggio adorante alla macchina dello show-business, questo tipo di riunioni carbonare e dissonanti portino una testimonianza di un percorso che nessuno potrebbe più prendere. E qui potrebbe iniziare il dibattito (… ma potete andarvene ora, prima che sia troppo tardi). Partendo da una domanda.
Ovvero: appurato che questa musica, il modo in cui suona e il modo in cui viene suonata, si contrappone con una certa evidenza (anche un po’ piccata) ai linguaggi musicali dominanti ma anche alla maggior parte di quelli che dovrebbero essere “alternativi”, ci si potrebbe domandare: questa musica è “contemporanea”, oppure non lo è più? L’età e il percorso di chi la propone (il più giovane è il 54enne Dresselhaus) la condanna a revival, come gli 883 o i CCCP ma per un’élite sparpagliatissima? La musica è realmente nostra contemporanea solo se contiene autotune o una Roland 808? Eppure quanto è risuonato nella piccola sala di quartiere (un’area di Milano nota come Quarto Cagnino, non precisamente Brera) per uno degli appuntamenti della rassegna Sempre più vicini suonava vivo e significativo e terribilmente somigliante al mondo là fuori. Certo, magari sono impressioni di dicembre: può darsi persino che se Zappi dovesse tornare qui a luglio, gli chiederemmo un minimo di reggaeton (“E dai che lo ballate anche voi, in vacanza sul Lago di Garda”).
Sono interrogativi un po’ oziosi, di quelli che sorgono quando si esce da una mostra, poniamo, al MAXXI di Roma. O all’Hangar Bicocca di Milano, al Mart di Rovereto. E forse questo pubblico è in fondo lo stesso, una minoranza “arty” che non si riconosce nei contenuti “alternativi” costruiti con rigore e accuratezza scientifica per le nicchie. Ma una volta ribadito che valeva certamente la pena di assistere al concerto (cosa che – malgrado la narrazione convinta istigata dal florido comparto musicale – non succede spesso, anzi) la natura rettile del critico impone di chiudere almeno con una piccola considerazione semi-negativa. Che pertiene all’impossibilità di catturare tutto questo in una registrazione e segnatamente, in un album, per quanto Blickwinkel abbia momenti forti e momenti significativi. Ha una sua validità, ma non si avvicina a quel livello di raffigurazione sonora della realtà, e non genera quel tipo di partecipazione emotiva. Resta comunque un disco su cui potete contare per organizzare la vostra lotta armata durante Sanremo.