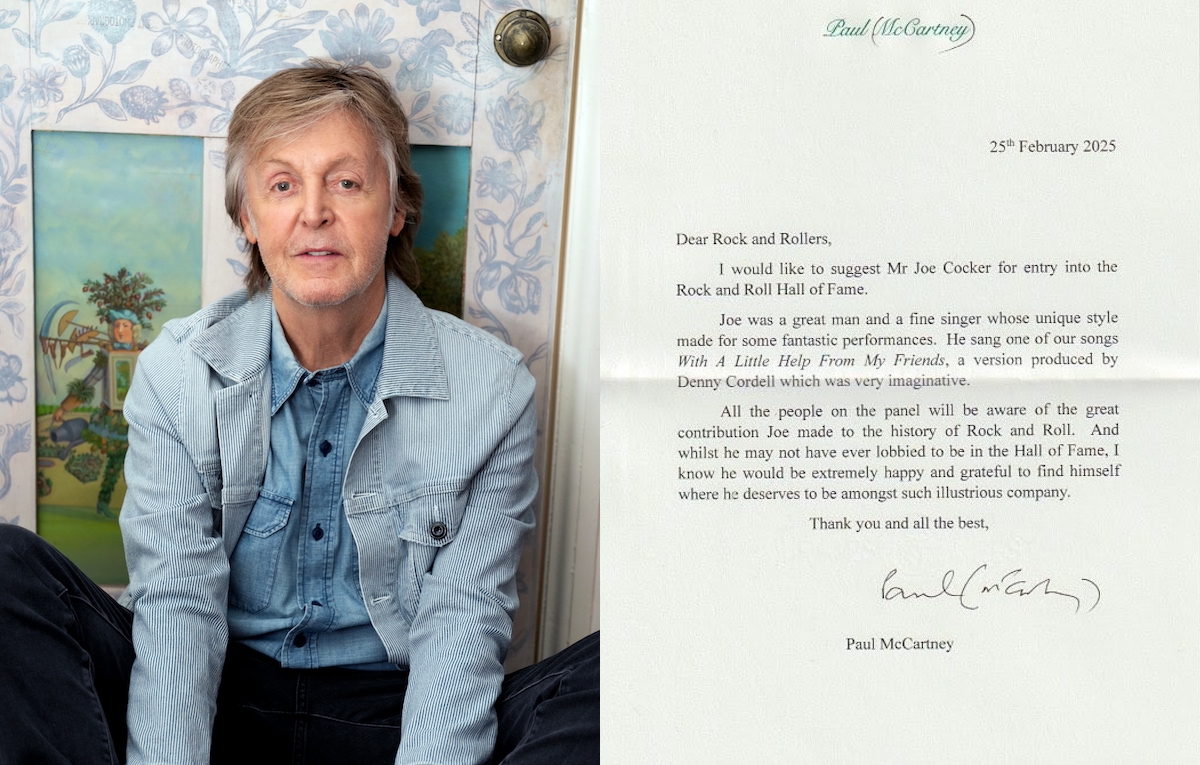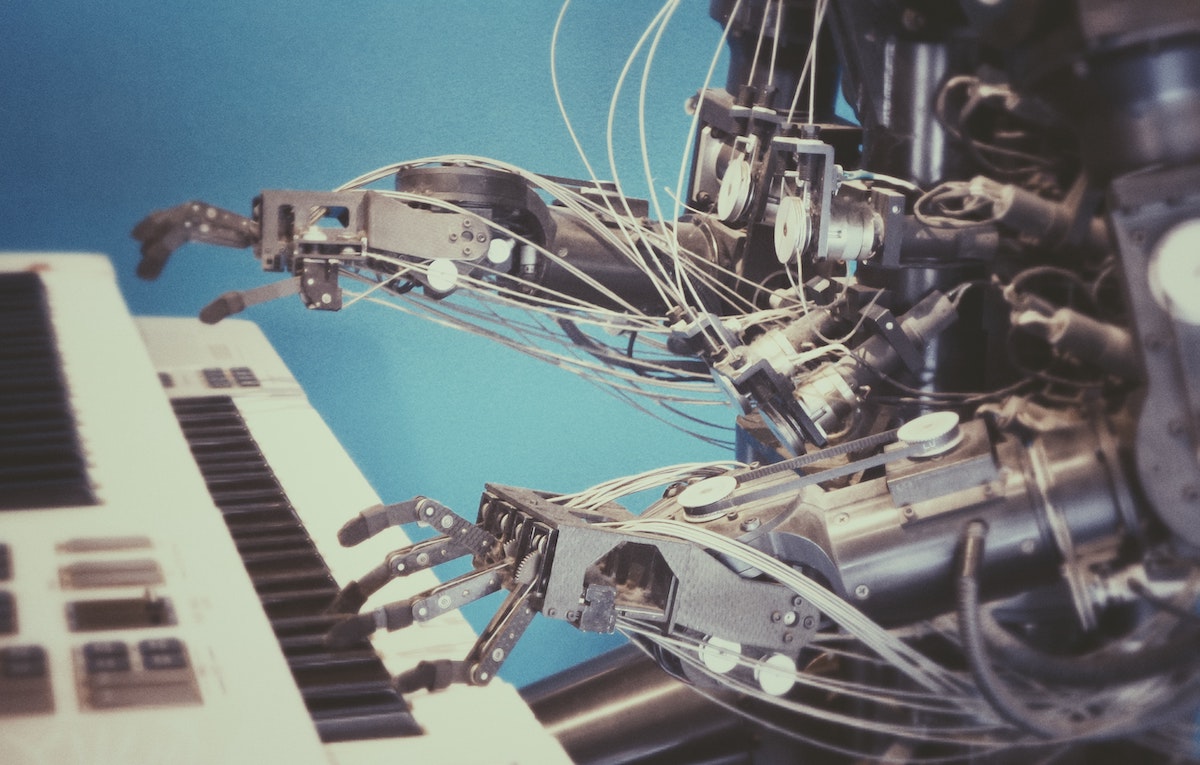Ogni tot anni Paul McCartney va in psicoterapia, parole sue. Durante la sua vita l’ha fatto per diverse ragioni: la morte di Linda, il divorzio dalla seconda moglie Heather Mills, periodi particolarmente difficili dalla natura più varia, ma mai per tutto quello che riguarda la sua storia artistica, mai direttamente con l’intento di affrontare i traumi – che pure ci sono stati – legati alla relazione dei Beatles con il mondo, alla beatlemania e, più in generale, ai rapporti irrisolti con le sue musiche del passato.
Per i suoi 70 anni, incredulo di aver raggiunto il traguardo, proprio sulle pagine di Rolling Stone, in una lunga e bellissima intervista rilasciata a Brian Hiatt, McCartney si disse, infatti, pacificato e speranzoso all’idea di raggiungere gli 80 nonché sempre più interessato ad approfondire lo studio della chitarra nel lasso di tempo che lo avrebbe separato dal traguardo. Detto, fatto. Il suo ultimo album McCartney III, uscito in piena pandemia nel dicembre 2020, è in effetti figlio non solo del lungo lockdown trascorso nella sua fattoria con figlia e nipoti suonando la chitarra, ma dell’ennesimo capitolo dell’ultima fase artistica di un Paul mosso in primis dal desiderio di giocare, di divertirsi e insieme mettersi a provare non tanto qualcosa di nuovo ma qualcosa di antico in modo nuovo.
Tutto questo ci porta a formulare una piccola teoria autoevidente: il ragazzo venticinquenne che nel 1967 vagheggiava pieno di domande e dubbi i suoi 64 anni, superata quella soglia, ci trasferisce una piccola sicurezza, quella di essere diventato un uomo, almeno all’apparenza, pacificato del tutto con quel ragazzo, più che mai desideroso di divertirsi, di cogliere in ogni forma le fortune che la vita gli ha offerto e che si è certamente guadagnato, facendo solo ciò che desidera, divertendosi, muovendosi in libertà in ogni territorio capace di farlo sentire a casa. Se trovare un metro per operare valutazioni e considerazioni sull’ultima tranche della carriera del più grande autore di canzoni pop vivente (l’altro è Brian Wilson, certo, ma la quantità sta dalla parte di Macca) risulta come minimo difficile e, come massimo, tracotante, è invece necessario sottolineare in che campo si sia mosso, in quello cioè, appunto, della più assoluta libertà. Esempio di una forma di privilegiata e ispirata resistenza al tempo, quello che esprime oggi Macca è un modo sano e felicemente egoista di non smettere, continuare a incidere dischi su dischi, fare tour con le date ravvicinate per gestire al meglio la custiodia di una figlia che è stata minorenne fino all’altroieri, rendendosi in grado di rispondere alle domande sul suo battere o meno in ritirata con un semplice: se mi piace e mi diverto, perché mai dovrei?
Già, in effetti, perché? In fondo chi di noi, che ci sentiamo fortunati anche solo per il fatto di essere vivi nel lasso spaziotemporale del cosmo in cui è vivo anche lui, vorrebbe vivere in un mondo in cui non nascono nuove melodie firmate da Paul McCartney? Fosse anche uno solo il brano di un suo nuovo disco da portare nella nostra vita a pieno cuore, perché rinunciarci? Dal canto suo McCartney non è un musicista né un compositore, né un autore, è un paradigma, è l’alfa e l’omega della faccenda, ed è un uomo – lo avete visto tutti Get Back – felicemente ossessionato dal mestiere che lo ha occupato per tutta la vita al punto da non riuscire a immaginare neppure l’alternativa della vacanza.
Qualcuno potrebbe obiettare che in fondo, quel che McCartney doveva dire l’ha detto già da tempo, con i Beatles, con dischi come Ram o Band on the Run, con canzoni che sono manifesti come Silly Love Songs, ma il paradigma, lo sappiamo, è il modello, il grado zero della coniugazione, l’imprescindibile. La sensazione, attraversando e riattraversando con movimenti differenti la carriera di Macca è che da un certo punto in poi, un momento difficile da datare ma che forse possiamo reperire molto indietro, già negli anni ’80, non sia stato più così importante il risultato ma il continuo ripetersi del modello senza che mai, nei risultati, si ripetesse davvero la sostanza. Ciò che ancora cerchiamo e chiediamo al più grande autore di canzoni pop vivente non è tanto che scriva altri capolavori in grado di entrare negli annali della canzone internazionale, ma che tenga in vita e alta la possibilità che nel mondo possano esistere ancora grandi canzoni, le sue, con quel marchio della fabbrica umana che solo possiede chi ha un talento tanto smisurato.
La verità è che in questo senso Paul McCartney è perfettamente allineato col suo pubblico, che include, all’incirca, tutto il globo: tanto connesso a sé stesso e tanto consapevole di aver fatto di tutto e di aver dunque anche sbagliato, Macca è tanto pacificato con sé stesso da perdonarsi e andare oltre con una considerazione di sé che prevede il piacere, il gusto, la bellezza ma non la perfezione. In occasione dell’uscita di Press to Play (1986) confessò di essere assolutamente capace di rendersi conto di aver pubblicato anche pezzi non conclusi, a volte eccessivamente soft, altre proprio schifosi, di aver fatto uscire, dalla fine dei Beatles in poi, anche cose trascurabili ma aggiunse che tuttavia, poi, «talvolta arriva una bella cosa e questo fa sì che valga ancora la pena».
La carriera di McCartney, dall’omonimo postbeatlesiano del 1970 fino al 2020 incluso, include, è innegabile, una vastità impressionante di tentazioni a cui s’è deciso di cedere, desideri musicali segreti realizzati, divertissement dall’esito trascurabile che trovano spazio nelle tracklist finali degli album e piccole e meno piccole idee geniali lasciate a dormire nelle versioni deluxe per i fan, e ancora dischi talmente zeppi di cose e cosine che sembrano demo da cameretta da farti pensare all’incapacità di rinunciare, di negarsi qualcosa. Ecco qui, allora, il punto, a volte muovendosi nella creazione di album memorabili come Chaos and Creation in the Backyard (2003) e del suo naturale seguito Memory Almost Full (2007) che hanno partecipato alla rifondazione del suo mito per le generazioni più giovani, a volte perduto nei viaggi esotici dell’Egypt Station, intento a raccontarci di un party a casa di Frank Sinatra o del ritorno in Brasile, altre ancora riconnettendosi alle sue radici rock’n’roll dei 50s (Run Devil Run, 1999), quello che vediamo chiaro è il desiderio, tanto semplice quanto celeste e lontano dalle storie delle nostre vite di ogni giorno, di non negarsi nulla, potendolo naturalmente fare: andare avanti a lavorare perché sì, in modo impressionante, sconvolgente anche per frequenza e intensità, «talvolta arriva una bella cosa e ne vale ancora la pena».