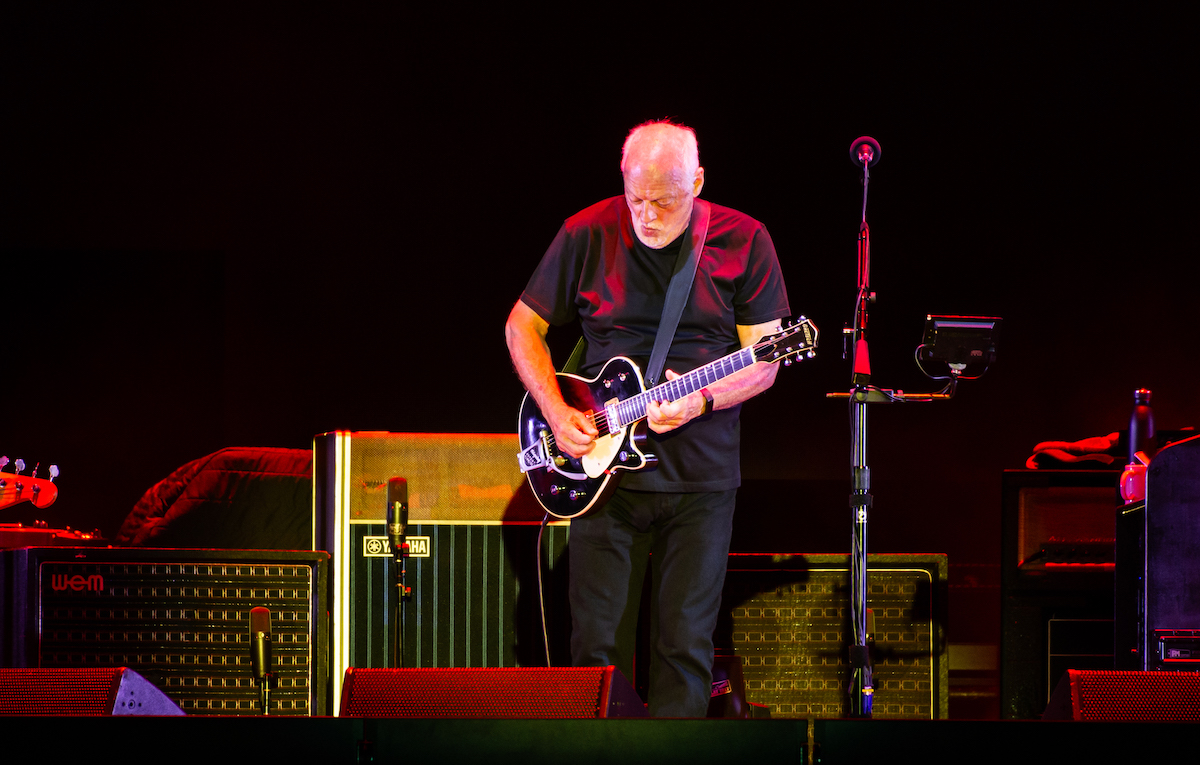Una sera, agli inizi del 1967, i quattro membri originari dei Floyd – Roger Waters, bassista, Richard Wright, organista, Nick Mason, batte- rista, e Syd Barrett, cantante e chitarrista – erano pigiati in un’auto mentre rientravano a Londra da un concerto fuori città e stavano discutendo del loro futuro. In quel momento erano il gruppo più discusso d’Inghilterra: pionieri psichedelici che mescolavano evasioni strumentali con i testi contorti e lisergici di Barrett. Mancavano poche settimane alla firma del contratto con la EMI – che li avrebbe resi compagni di etichetta dei Beatles – e alla registrazione del loro primo album, The Piper at the Gates of Dawn. «Era una di quelle conversazioni tra ragazzi, piene di testosterone, tipo: “Allora che si fa?”», ricorda Andrew King, uno dei manager del gruppo, che in quel momento era al volante. «Poi qualcuno ha buttato lì una battuta cinica, del tipo: “Fanculo l’arte, sono i soldi che contano”. E all’improvviso Barrett – profondi occhi scuri e vaporosi capelli mossi – dal sedile posteriore ha commentato con voce lieve: “Non dovresti dire così. Ho studiato arte per sette anni. È importante. È solo l’arte che conta”».
I Floyd avrebbero tenuto fede a quel credo. L’ambizione narrativa e le rivoluzionarie sonorità di The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here e The Wall sono scaturite dalla devozione di Barrett all’arte nel rock. Ma in quei dischi Barrett non c’era. Nell’estate del 1967, meno di sei mesi dopo quella conversazione in auto, aveva ormai intrapreso una lunga e vorticosa discesa nella follia, alimentata da un abuso di LSD. Agli inizi del 1968 fu abbandonato dal gruppo e venne sostituito dall’ex compagno di scuola David Gilmour. Barrett ha realizzato due struggenti album solisti nel 1970, The Madcap Laughs e Barrett – entrambi portati a termine sotto la paziente guida di Gilmour – poi si è ritirato nella casa di famiglia a Cambridge e vi è rimasto – salvo qualche bizzarra incursione a Londra negli anni ’70 – fino al 7 luglio 2006, quando è morto per le complicazioni del diabete. Aveva 60 anni e la famiglia non ha mai rivelato i dettagli delle cause mediche o psicologiche della sua malattia.
«Syd è stato il faro illuminante dei nostri esordi e il suo lascito continua a ispirarci», hanno dichiarato Gilmour, Wright e Mason nel loro elogio funebre. In un altro comunicato, Waters ha affermato: «Syd era un ragazzo adorabile e un talento unico. Lascia un corpus di opere molto toccante e molto profondo, che splenderà in eterno». «La cosa straordinaria dei brani di Syd», mi disse Waters nel 1987, «era che, in quella stravaganza e in quella folle giustappo- sizione di idee e parole, c’era una poderosa carica di umanità. Erano canzoni umane all’ennesima potenza. Ed è quello a cui ho sempre aspirato anch’io. In questo senso, avverto un forte legame con lui». Il destino di Barrett ha continuato ad aleggiare sui successi dei Floyd, in particolare sulle creazioni di Waters che indagano le crisi emotive e la psicosi della rockstar in Dark Side e The Wall. E l’epica elegia di Shine On You Crazy Diamond in Wish You Were Here era una dichiarazione di nostalgia per Barrett. “Hai consumato il tuo benvenuto con precisione casuale / hai cavalcato la brezza d’acciaio / Avanti, mente delirante, profeta veggente; avanti pittore, pifferaio, prigioniero, splendi!”.

PinK Floyd. Da sinistra: Roger Waters, Syd Barrett, Nick Mason, Rick Wright. Foto di Andrew Whittuck/Redferns
Dopo l’inizio delle ostilità tra i Pink Floyd a metà degli anni ’80, Gilmour e Waters sono rimasti uniti per la devozione a Barrett. Ogni sera, durante il tour Radio K.A.O.S. del 1987, Waters mostrava un video promozionale del 1967 registrato per il singolo d’esordio dei Floyd, Arnold Layne, e poi diceva alla folla di spettatori: «Il grande Syd Barrett; per non dimenticare». A New York, nel suo recente tour da solista, Gilmour ha eseguito Dominoes di Barrett, un’agrodolce invocazione di pace e comunanza: “È un’idea, un giorno o l’altro / Nelle mie lacrime, nei miei sogni… Io e te e le tessere del domino…”. Anche nei lunghi anni di isolamento, Barrett è stato un’icona per un’intera generazione di artisti; i R.E.M., gli Smashing Pumpkins, i Cure e Robyn Hitchcock sono tra i molti discepoli che hanno fatto cover delle sue canzoni, lo hanno citato come fonte d’ispirazione e hanno continuato a sperare, come rivela Hitchcock, «che verso la fine della sua vita sarebbe uscito dalla nebbia e avrebbe espresso qualche commento, avrebbe descritto la nebbia». Invece Barrett se n’è andato senza dire una parola. La sua ultima intervista, rilasciata all’amico fotografo Mick Rock per Rolling Stone, risale al 1971. «Sto scomparendo, evito quasi tutto», disse, «procedo a ritroso». Aveva 25 anni.
«La cosa aveva radici profonde», mi spiegò Gilmour nel 1982, quando gli chiesi del tracollo di Barrett. «L’esperienza psichedelica può aver agito da catalizzatore. Ma credo che non riuscisse a gestire l’idea del successo e tutte le cose che comportava». Gilmour ravvisava un aspetto sgradevole nell’idolatria di cui era oggetto il genio tormentato del suo amico. La vita di Barrett, disse Gilmour, «è una storia triste, che viene romanzata da persone che non ne sanno nulla. L’hanno resa affascinante, ma non è affatto così». Nel giugno 1975, i Pink Floyd erano in studio per il missaggio di Shine On You Crazy Diamond, quando un uomo grassoccio e trasandato, con la testa e le sopracciglia rasate, entrò e si accomodò come fosse a casa sua. Sulle prime nessuno lo riconobbe. Alla fine Gilmour capì che aveva di fronte il soggetto della canzone in persona: Syd Barrett. «Se questa storia me la raccontasse qualcun altro», dichiarò Gilmour nel 1982, «stenterei a credere che si possa stare seduti in una stanza minusco- la per ore con un caro amico a cui si è stati legati per anni, senza riconoscerlo».
In seguito Waters confessò di essere scoppiato «in fottute lacrime» vedendo Barrett che, non ancora 30enne, dimostrava il doppio dei suoi anni. Quel giorno, l’unico contributo musicale di Barrett arrivò dopo che i Floyd avevano ascoltato infinite volte Shine On You Crazy Diamond. Quando qualcuno chiese all’ingegnere del suono di ripeterla, Barrett disse: «Perché? L’avete già ascoltata una volta». Non era certo il Syd Barrett che dal 1965 a metà 1967 era stato l’anima e la stella indiscussa dei Pink Floyd. «La gente non si rende conto di quanto fosse bravo, di quanto avesse voglia di lavorare», disse King, che diventò il manager della band insieme a Peter Jenner verso fine 1966. «Syd mi ha riferito che ci ha messo un mese per scrivere il testo di Arnold Layne» – un racconto vivido, evocato da versi concisi, della storia di un uomo imprigionato per aver rubato biancheria femminile stesa ad asciugare. King ricorda anche una sessione di missaggio di Piper agli studi di Abbey Road, con Barrett alla console che muoveva gli attenuatori con le mani: «Era come guardare un pittore; la grazia naturale del movimento delle sue mani».

I Pink Floyd nel novembre 1967. Da sinistrat: Roger Waters, Richard Wright, Nick Mason, Syd Barrett. Foto di Baron Wolman/Iconic Images/Getty Images
Syd, all’anagrafe Roger Keith Barrett, era nato a Cambridge il 6 gennaio 1946, quarto di cinque fratelli e figlio di uno stimato patologo che morì quando lui aveva 14 anni. Barrett mostrò un precoce talento di pittore e pianista, ma presto preferì suonare la chitarra con Gilmour e Waters, suoi compagni al liceo di Cambridge. Scriveva anche canzoni: Effervescing Elephant e Bike risalgono all’adolescenza e a quegli anni risale anche il soprannome Syd. La futura moglie di King, Wendy, conosceva Barrett fin dai tempi di Cambridge. «Per lei», dice King, «Syd era la vita e l’anima di ogni festa, ed era una calamita per le donne». Nel 1964 Barrett portò il suo entusiasmo e il suo magnetismo alla scuola d’arte di Londra, dove cominciò a suonare con Waters, Wright e Mason. Nell’autunno 1966, i Pink Floyd –battezzati così da Barrett, che unì i nomi di due bluesmen americani, Pink Anderson e Floyd Council – si erano ormai po- sizionati ai margini del pop britannico, «improvvisando su un accordo con quelle macchine per l’eco. Barrett faceva scorrere un accendino Zippo sul collo della chitarra, creando un effetto metallico simile al verso di un uccello». Allo stesso tempo, Barrett scriveva brani densi e compatti con progressioni armoni- che e melodie brillanti, traendo ispirazione per i testi da libri di scienza (Astronomy Domine), da I Ching (Chapter 24) e dalla sua infanzia (Matilda Mother). «Non era un grande chitarrista», spiega Jenner, «ma aveva una fervida immaginazione; e aveva la capacità di distillarla».
Nel giugno 1967, Barrett diventò ufficialmente una pop star con il secondo singolo dei Pink Floyd, See Emily Play. Il brano, entrato nella Top Ten britannica, coglieva l’ottimismo e il technicolor che caratterizzavano la stagione più vivace della controcultura inglese. Ma Barrett, che aveva iniziato a prendere acidi a 19 anni, stava abusando delle droghe in modo sconsiderato (mentre gli altri Floyd preferivano l’alcol) e si comportava in modo imprevedibile. Spariva per giorni e passava interi concerti in stato catatonico. Nonostante i segnali d’allarme, quell’estate i Floyd cercarono di promuovere l’uscita di Piper con un tour disastroso negli Usa, che dovettero interrompere quando Barrett diventò ingestibile. A Los Angeles, quando dovevano suonare al Cheetah, i Floyd furono aiutati dal futuro Alice Cooper e dal suo gruppo, che allora si chiamava Nazz. «I Floyd erano rimasti senza soldi», dichiara Cooper, «così sono restati con noi, nella nostra casa di Venice. Ricordo che un mattino sono entrato per fare colazione e al tavolo c’era Syd. Aveva dei pantaloni viola, e stava fissando la scatola di cereali, nel modo in cui di solito si guarda la tv. Stava guardando qualcosa che noi non potevamo vedere». Ma nei pochi concerti grandiosi di quella settimana, i Pink Floyd erano «assolutamente il miglior gruppo psichedelico di tutti i tempi. Usciva roba fantastica da quegli amplificatori, e dietro quei suoni avevano un’organizzazione impeccabile. E Syd aveva un fascino unico: era il ragazzo che nessuno poteva raggiungere».
«Tutti volevamo che tornasse», dice Jenner. Lui e King, senza successo, consultarono degli specialisti per Barrett, e arrivarono persino a contattare il celebre psicoanalista R.D. Laing. La diagnosi più precisa la diede lo stesso Barrett nell’ultimo disco registrato ufficialmente con i Pink Floyd, Jugband Blues, che si apre letteralmente con l’atto dell’addio: “È estremamente cortese da parte vostra pensarmi qui. / E vi sono molto obbligato per aver chiarito / che non sono qui”. «Quand’ero bambino, negli anni ’50», spiega Jenner, «in Inghilterra c’erano dei nebbioni pazzeschi. E ricordo il carrello che portavo a scuola, ricordo che usciva silenzioso dalla nebbia poi svaniva di nuovo nella nebbia». Barrett alla fine è diventato come quel carrello, ammette tristemente Jenner. «È entrato nella nebbia. Ogni tanto spuntava fuori. Poi, non ne è uscito mai più».

Nick Mason, Roger Waters, Syd Barrett e Rick Wright dei Pink Floyd durante un concerto a Londra il 16 dicembre 1966. Foto di Adam Ritchie/Redferns
Gilmour raccontò nel 1982 quant’era stato difficile lavorare con Barrett ai suoi due album solisti: «Bisognava preregistrare ogni traccia senza di lui, basandosi su una versione del brano che aveva già preparato, poi bisognava farlo sedere e indurlo a suonare e cantare insieme alla registrazione, intervenendo in continuazione. Oppure fare il contrario. L’idea che lui suonasse con un altro gruppo di musicisti era chiaramente impraticabile, perché cambiava la canzone ogni volta». The Madcap Laughs e Barrett sono documenti tormentati e splendidi della disgregazione mentale di Barrett, che passa dal capriccio infantile alla chiarezza di una confessione sincera. «Non so quanto fosse capace di introspezione», dice Hitchcock. «Quello che lasciava intravedere nella sua musica era il modo in cui lui vedeva il mondo. E anche se rifiutava di condividere le emozioni degli adulti, quei dischi sono pieni di emozioni».
Mick Rock, che aveva scattato le foto di Barrett per entrambi gli LP, ricorda un Barrett diverso nei primi anni dopo l’uscita dal gruppo, «che si vestiva ancora alla moda, che non aveva ancora rinunciato a tutto». Intorno al volgere degli anni ’70, Barrett e Rock vivevano nello stesso palazzo. «Quando passavo del tempo con lui era sempre per fumare uno spinello, ascoltare musica, ridere, sfogliare fumetti». Ma ripensando all’intervista del 1971, Rock dice: «Mi ricorda quella canzone degli U2, Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of. Si era inceppato. Ed era successo molto in fretta». Barrett tenne i suoi ultimi concerti nel 1972 a Cambridge, come frontman di un trio chiamato Stars, con il bassista Jack Monck e il batterista John “Twink” Alder, ex membro dei Pretty Things. «Era una specie di terapia», spiega Monck, che conobbe Syd tramite Jenny Spires, ex compagna di scuola di Syd con la quale lui aveva una relazione. «Volevamo aiutarlo, tirarlo fuori». Poi un promoter fissò una serata per gli Stars con gli MC5, che ottenne una brutta recensione su Melody Maker. Gli Stars si sciolsero e Monck dice che da allora ha visto e parlato con Barrett un’unica volta: un anno dopo, davanti a dei negozi di strumenti musicali a Londra. «Era ancora più smarrito. Ma sapeva che era stato una star e che tutto gli era scivolato via. A tratti quel passato tornava a galla. “È qui che dovrei stare. Ho diritto di stare qui, i negozi di musica o gli studi di registrazione. È questo il mio mondo”».
Dai tardi anni ’70 in poi, Barrett ha vissuto appartato a Cambridge, invisibile al resto del mondo. Ma era un recluso non privo di mezzi, grazie ai diritti d’autore e alle vendite dei Floyd. Ma la crudele ironia è che è morto due volte: la prima nel fiore della giovinezza, quando il suo spirito creativo e la sua volizione lo hanno abbandonato; poi quando lo ha abbandonato il corpo. «Forse è stato il più furbo di tutti», dice Jenner in tono affettuoso. «Quando mi sento triste per Syd, penso sempre che forse sta ridendo di noi».