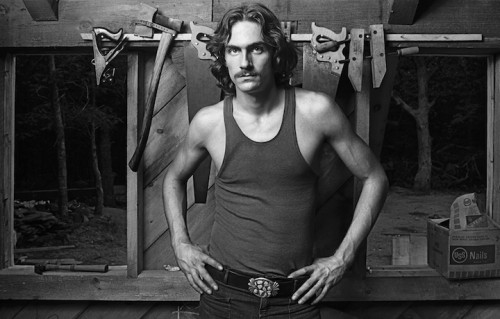L’ultimo album di James Taylor, Before This World, è la sua prima raccolta di canzoni originali da 13 anni a questa parte. Non che si sia rilassato troppo, durante questo tempo: è andato regolarmente in tour, ha registrato dischi live e cover, e ha cresciuto due gemelli che oggi hanno 14 anni. Ma a un certo punto ha capito che doveva rendere la scrittura un aspetto prioritario della sua vita: quindi ha preso in prestito l’appartamento di un amico e si è chiuso lì a scrivere quello che è diventato un disco dolce e riflessivo, che richiama le atmosfere dei suoi album anni ’70. «Non sono il tipo di musicista che si reinventa di continuo», dice. «Quello che mi interessa è diventare sempre più bravo». A 67 anni, James è in grado di giudicare la sua vita e la sua carriera con onestà, compresi i momenti bui – la dipendenza dall’eroina, le difficoltà come genitore (prima dei gemelli ha avuto due figli, Sally di 41 e Ben di 38 anni, dall’ex moglie Carly Simon). «Sally e Ben sono venuti su alla grande», dice. «Ma non per merito mio. Sono stato un padre difettoso. Le dipendenze sono una forma di ritardo dello sviluppo, e credo di essere diventato adulto molto tardi». Oggi James ci accompagna lungo 50 anni di canzoni.
“Rainy Day Man”(1967)
Nel 1966, a 18 anni, vivevo all’Albert Hotel di New York insieme al mio migliore amico, Zach Wiesner, che scrisse questo pezzo con me. Stavamo nell’unica altra stanza dell’hotel che era scampata a un incendio. Il titolo ha a che fare con la droga. Joel “Bishop” O’Brien, il batterista dei Flying Machine, era tossicodipendente. Passavo un sacco di tempo a casa sua, quindi era inevitabile che prima o poi provassi anch’io l’eroina. È come se fossi nato per farmi, era la chiave che apriva ogni porta. Per i successivi vent’anni non sono più tornato.
“Something in the Way She Moves”(1968)
Avevo convinto i miei genitori a comprarmi un biglietto per Londra, dove un amico pote- va ospitarmi per qualche settimana. Speravo di riuscire a cantare nei club o in strada, e invece finii per conoscere Peter Asher, che lavorava per Apple Records. Mi fece ottenere un’audizione con Paul McCartney e George Harrison, e suonai questa canzone davanti a loro. Quando sentii che George aveva usato il titolo come strofa di Something non mi sembrò di essere stato derubato. E comunque la mia canzone a sua volta cita I Feel Fine dei Beatles.
“Carolina in my Mind”(1968)
Stavo lavorando al mio primo disco, ai Trident Studios di Londra, proprio mentre i Beatles registravano il White Album lì accanto. Mi rendevo conto della fortuna di poter ascoltare le loro incisioni e osservare il loro processo creativo, ma sentivo ugualmente la mancanza della mia casa in North Carolina. Questa canzone cattura la sensazione di sentirsi richiamati verso un altro luogo.
“Sweet Baby James”(1970)
Allen Klein divenne capo di Apple Records nel 1969. Per contratto avevamo la possibilità di controllare i dati delle vendite, ma lui non era d’accordo e ci lasciò andare. Così tornai negli Stati Uniti e scoprii che mio fratello Alex era diventato papà. Decisi di scrivere una canzone per suo figlio, che era stato chiamato come me. Una piccola canzone da cowboy. Inizia come una ninna nanna, poi dalla seconda metà parla di ciò che la musica significa per me. Penso che sia la mia canzone migliore.
“Steamroller”(1970)
Tornai da Londra dipendente dall’eroina, ed entrai in rehab. In realtà era una struttura psichiatrica. Ero già stato in un posto del genere quando avevo 17 anni. Lì dentro scrissi un bel po’ di canzoni che entrarono in Sweet Baby James. Steamroller però risaliva ai tempi dei Flying Machine, ed era nata come scherzo. C’era un sacco di gente bianca che suonava il blues, universitari che cantavano come Howlin’ Wolf e Muddy Waters, e la cosa mi sembrava comica.
“You’ve Got a Friend”(1971)
Carole King e io suonavamo insieme al Troubadour di Los Angeles. Lei aveva appena scritto You’ve Got a Friend, che era una risposta alla mia Fire and Rain. Non appena la ascoltai, decisi che volevo suonarla. Poco tempo dopo mi trovavo in studio a registrare Mud Slide Slim and the Blue Horizon. Peter [Asher] disse: “Perché non provi a fare You’ve Got a Friend?”. C’era solo un problema: dovevo chiedere il permesso a Carole. La chiamai, un po’ timoroso, e lei rispose: “Va bene, te la regalo”, e da parte sua fu molto generoso.
“Walking Man”(1974)
Ho scritto un sacco di canzoni su mio papà; ho la sensazione che emotivamente fosse bloccato. Questa canzone nasce dal mio desiderio di averlo accanto. Quando ero piccolo sparì per qualche anno, fu arruolato in Marina e in seguito partì volontario per il Polo Sud. Ci mancava un sacco. Mia madre ha avuto cinque figli nella campagna del Nord Carolina, dove aspettava che mio padre tornasse a casa. Questa cosa in qualche modo è sempre rimasta con me.
“A Junkie’s Lament”(1976)
Ho un sacco di pezzi che parlano di guarigione. Questo è un monito a non considerare un drogato come un essere umano del tutto funzionante. Le persone prendono droghe per avere controllo: vogliono bypassare tutti i rischi che possono correre nelle loro vite, ogni incertezza e ansietà. Vogliono premere un bottone e ottenere il risultato finale. Non c’è dubbio che, in questo modo, ogni loro relazione personale ne soffrirà.
“Secret o’Life”(1977)
L’ho scritta in un angolo di luce sulla scala di una casa che stavo costruendo, a Martha’s Vineyard. Ci ho messo circa 10 minuti, come se la canzone fosse già dentro la chitarra. Una strofa dice: “The secret of life is enjoying the passage of time”. È una cosa assurda da scrivere, e il titolo doveva richiamare i gusti delle caramelle Life Savers, come Pep-O-Mint o But-O-Rum. È una frecciata all’arroganza di scrivere una canzone intitolata The Secret of Life.
“Only a Dream in Rio”(1985)
Ero entrato un’altra volta in rehab dopo un paio di brutti episodi in cui avevo umiliato me stesso e le persone che amo mandando tutto a puttane. Ma fu solo quando Michael Brecker [il sassofonista] mi coinvolse nel programma dei Dodici Passi che feci sul serio. Una volta disintossicato, però, non ero sicuro che ci fosse vita per me, oltre la droga. Poi andai a suonare al festival Rock in Rio. Salii sul palco, e 30mila persone conoscevano le mie canzoni. Quello è stato il momento della svolta.
“Never Die Young”(1988)
Questa canzone è scritta dal punto di vista di qualcuno che si è arreso, e guarda le vite di due giovani che non sono bloccati nel pantano della vita: “Let other hearts be broken / Let other dreams run dry / Let our golden ones sail on to another land beneath another sky”. È una canzone triste, ma anche piena di speranza.
“Copperline”(1991)
Un’altra canzone che parla di casa, di mio padre, di un’infanzia che è stata molto tranquilla, cosa rara oggi. In quei giorni mi sentivo parte del paesaggio – gli alberi, i fiumi, gli animali. [Mia moglie] Kim e io stiamo crescendo i nostri ragazzi in campagna, ma non è la stessa cosa. La loro vita è costantemente connessa. Penso che tutta l’informazione che riceviamo ci stia preparando ad avere un’unica mente comune, come fossimo in un alveare.
“Enough to Be on Your Way”(1997)
Anche mio fratello Alex era tossicodipendente, e nel 1993 è morto. Quando è successo ho sentito un senso di sollievo, sia per lui che per la sua famiglia. Un anno dopo sono riuscito a rimettermi in contatto con la sua vita – non soltanto il casino della sua fine, tutto quel dolore. A quel punto ho scritto questa canzone.
“Mean Old Man”(2002)
È una canzone sofisticata e al tempo stesso un ritorno al passato. Paul Mc- Cartney mi ha confessato che quando l’ha sentita credeva si trattasse di Frank Loesser o Cole Porter. A un certo punto Bob Dylan mi disse che aveva ascoltato Frozen Man [altra canzone di Taylor, nda], e la riteneva una grande canzone. Questo per me basta. I critici possono massacrarmi, ma finché qualcuno come Paul o Bob mi dirà: «Continua così, ragazzo», io sono contento.
“Angels of Fenway”(2015)
L’ho terminata nel maggio 2014, ma avevo già pronta la musica da sette anni. Sapevo di voler scrivere qualcosa sulla miracolosa stagione 2004 contro gli Yankees. Per i fan dei Red Sox, e per gli appassionati di baseball in generale, è stato un evento fantastico. L’ho immaginata come la storia di un’anziana signora, che nasce nell’anno in cui i Red Sox hanno vinto il campionato l’ultima volta, e muore il giorno in cui finalmente riescono a tornare al successo, 86 anni dopo.
Potete leggere l’edizione digitale della rivista,
basta cliccare sulle icone che trovi qui sotto.