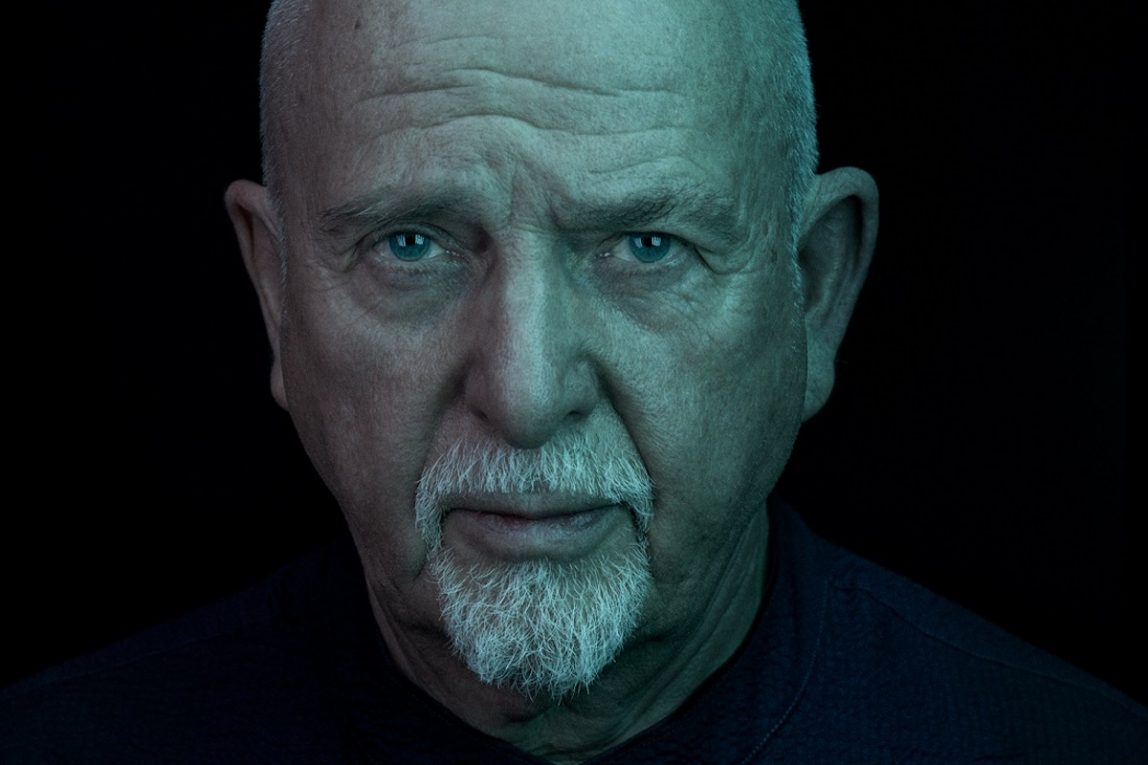È un urlo rabbioso che sovrasta la danza macabra del contrabbasso: «Ride bene chi ride ultimo e riderò io quando ti vedrò BRUCIARE!». Potrebbe essere la voce dell’insegnante sadico di The Wall o del soldato di Amused to Death a cui il rinculo del mitragliatore ricorda un amplesso. E invece a parlare è il Diavolo in persona. Di demoni Roger Waters ne ha cantati parecchi, con e senza Pink Floyd, gli mancava quello vero. Lo affronta in un disco che esce per Sony Classical dove prende il teatro da camera dell’Histoire du soldat di Igor Stravinsky, riscrive il testo originale, affida le esecuzioni agli strumentisti del Bridgehampton Chamber Music Festival e si cala nel ruolo del narratore. Nell’interpretazione colorita e verbosa di Waters, The Soldier’s Tale è una favola morale sulla guerra e l’avidità, solo che per una volta non ci sono riff di chitarra elettrica e parti roboanti di batteria, ma saliscendi repentini di tromba e bicordi staccati di violino.
Secondo l’arbitro supremo dell’avanguardia postbellica Pierre Boulez, l’Histoire du Soldat era «teatro della povertà». Intendeva dire che era stato prodotto con pochi mezzi. Quando lo compose nel 1917, durante la Prima guerra mondiale, Igor Stravinsky non era più il giovane selvaggio che solo quattro anni prima aveva messo sottosopra il mondo della musica con La sagra della primavera. Viveva in Svizzera esiliato dalla rivoluzione comunista, era al verde e depresso per la morte del fratello sul fronte romeno. Cercò una via d’uscita ideando con l’amico scrittore Charles-Ferdinand Ramuz un piccolo teatro musicale ambulante. Basò il soggetto sulle fiabe russe raccolte dal folclorista Aleksandr Afanas’ev e nate in reazione al reclutamento obbligatorio imposto da Nicola I. Un soldato in licenza dà al Diavolo il suo violino – l’anima, cioè – in cambio di un libro in grado di prevedere le fluttuazioni del mercato e farlo diventare ricco. L’avidità e l’incapacità di riconoscere la felicità impediranno all’eroe di liberarsi dal Diavolo, fino al tragico finale. Glenn Gould, che non aveva una gran opinione dell’opera, la descrisse come il «Dottor Faust dell’età del jazz».
Date le ristrettezze economiche, Stravinsky musicò il suo teatrino con coppie di strumenti appartenenti a tre diverse famiglie, uno per il registro acuto e uno per quello grave, tutti facilmente trasportabili da una località all’altra: violino e contrabbasso, clarinetto e fagotto, cornetta (spesso sostituita da una tromba) e trombone, più un set di percussioni. L’orchestrina era collocata su una piattaforma su un lato del palco. Sull’altro lato sedeva il narratore, la cui voce a volte si sovrapponeva e a volte si alternava alla musica. In scena, attori e ballerini mimavano l’azione. Un ritmo militaresco apre e attraversa l’opera, fino a essere inglobato nella marcia trionfale del diavolo che la chiude. Gli arrangiamenti sono meccanismi solo apparentemente semplici. Ci sono tempi mutevoli, incastri ritmici ingegnosi, echi di tradizioni popolari e persino del jazz che il compositore non aveva mai ascoltato e che aveva letto sugli spartiti importati dall’America. Non esiste un centro stilistico e la musica oscilla paurosamente fra vignette popolaresche e dissonanze diaboliche. Il progetto di portare questo teatro da camera in giro per la Svizzera fallì dopo una sola rappresentazione a causa della diffusione dell’influenza spagnola. La sua musica, però, ha attraversato un secolo.
Cent’anni dopo la prima dell’Histoire a Losanna (29 settembre 1918) e la firma dell’armistizio di Compiègne tra Francia e Germania che di fatto mise fine alla guerra (11 novembre 1918), Roger Waters ha rimesso mano al Dottor Faust dell’età del jazz, accodandosi alla lunga lista di personalità che l’hanno interpretato: Jeremy Irons, Christopher Lee, Gerard Depardieu, Max Von Sydow, Sting, Jean Cocteau, Peter Ustinov, Frank Zappa, John Cage, in Italia Paolo Poli, Giancarlo Giannini, Peppe Servillo e quest’anno Stefano Panzeri, voce narrante della versione in lingua italiana degli Esecutori di Metallo su Carta di Enrico Gabrielli e Sebastiano De Gennaro. Ora, abbinare Roger Waters a Stravinsky sembra un’idea bizzarra, ma il bassista ha flirtato a lungo con la musica colta, vedi l’opera Ça ira, e l’Histoire contiene due temi a lui cari: la guerra e la disciplina militare – com’è noto, il padre di Waters è morto durante il secondo conflitto mondiale, il nonno paterno durante il primo – e le insidie del materialismo. Pochi lo ricordano, ma il musicista aveva affrontato The Soldier’s Tale in una rappresentazione dal vivo già dieci anni fa. Nel dicembre 2014 si è chiuso per due giorni con sette musicisti nella chiesa presbiteriana di Bridgehampton, nello Stato di New York, uscendone con le registrazioni che vengono pubblicate oggi.
Waters non si limita a interpretare il libretto di Ramuz nella traduzione in lingua inglese di Michael Flanders e Kitty Black. Lo espande, aggiunge dialoghi e frammenti di narrazione, spiega e rende esplicito ogni passaggio. Fa l’istrione, interpreta la parte del soldato con un marcato accento inglese e quella del Diavolo con un’inflessione tedesca. Aggiunge brevi recitati per il re e la principessa. Non si cura dello spartito, che lascia sì libertà d’intonazione, ma in alcuni passaggi prescrive una precisa scansione ritmica dei fonemi. Sopprime la frase-chiave «Una felicità è tutta la felicità, due è come se non esistesse» e amplia la magnifica fanfara del Grande corale alterando però il fragile equilibrio fra parti narrate e suonate. I cinquanta minuti di durata di The Soldier’s Tale diventano quasi ottanta e l’opera da camera rischia di trasformarsi in un audiolibro.

Foto di Sean Evans
Negli ultimi cent’anni l’Histoire si è prestata a innumerevoli letture. Per restare in Italia, nel 1979 Dario Fo la mise in scena su incarico della Scala (dove però non fu rappresentata) con una trentina di attori-mimi. La intese come un’opera da piazza, allegoria del soldato che, schiacciato dalla guerra e dai meccanismi del potere, smarrisce la propria identità. Immaginò che l’opera s’adattasse anche alla perdita d’identità di contadini ed emigranti. Prima della morte, Pier Paolo Pasolini progettava di farne un film con Ninetto Davoli, protagonista traviato dal potere corruttore della tv (il progetto è stato portato a teatro a metà anni ’90). Lo scrittore americano Kurt Vonnegut trovava ridicolo che un soldato potesse andarsene in giro con un violino nel bel mezzo al massacro della Prima guerra mondiale. «Perché allora non la scrivi tu una storia migliore?», gli chiese il giornalista George Plimpton. Vonnegut lo fece, consegnando nel 1993 al New York Philomusica Chamber Ensemble un nuovo libretto. dell’Histoire, trasformata nella storia di Eddie Slovik, l’unico disertore americano fucilato durante la Seconda guerra mondiale.
Nelle Cronache della mia vita, Stravinsky scrisse d’essere stato sedotto soprattutto dal lato umano della tragedia del soldato. Il suo invito a non cercare nell’opera significati nascosti è rimasto inascoltato. The Soldier’s Tale viene spesso letta in chiave pacifista e così viene presentata la versione di Roger Waters. Lo scenario in cui si muovono i personaggi, però, non è bellico. L’Histoire è piuttosto una favola sul libero arbitrio, sui rapporti di potere, sull’avidità. Sulla necessità di marciare, proprio come il soldato, senza deviare dalla strada della rettitudine. Con un po’ di fantasia, può essere lettera come allegoria dei pericoli in cui incorre l’artista messo di fronte alle lusinghe del denaro – Waters direbbe: quando entra nella Macchina – e fatalmente smarrisce il suo talento. La marcia finale suona come un funerale grottesco alla volontà del soldato. Stravinsky e Ramuz ci dicono che non siamo padroni del nostro destino, che siamo destinati a essere continuamente beffati da esso. Il suo pessimismo riecheggia nella concezione di Waters delle relazioni sociali ed economiche.
C’è dell’altro. Forse oggi, in un periodo in cui artisti e musicisti hanno a propria disposizione una sovrabbondanza di mezzi, questo «teatro della povertà» è il simbolo potente di quel che accade quando la creatività è sottoposta a vincoli. Lo diceva anche Stravinsky, nelle lezioni ad Harvard sulla poetica della musica, che più l’arte è vagliata e limitata, più essa è libera. E che, parafrasando Leonardo da Vinci, la forza di un’opera nasce nella costrizione e muore nella libertà.