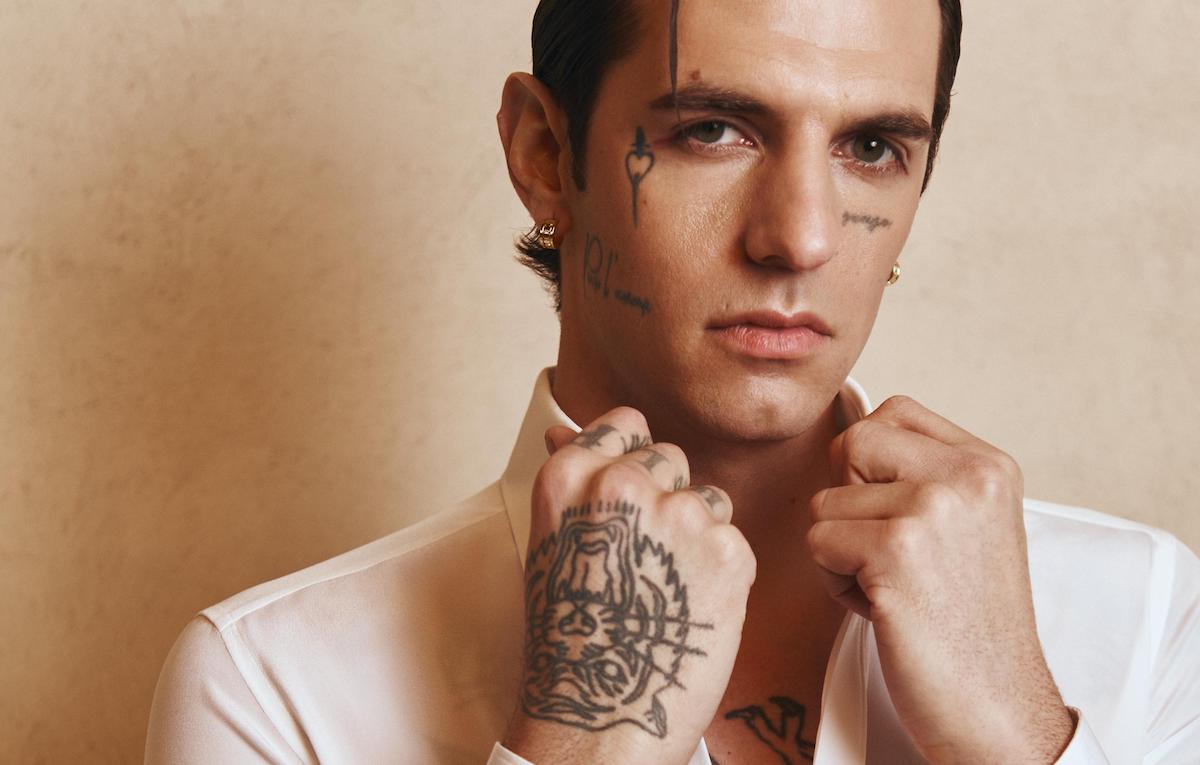C’è una cosa che dicono i Pet Shop Boys e temo sia in parte vera. E cioè che nel tempo non restano i disconi che consideriamo importanti, quelli coi messaggi ponderosi, le grandi opere celebrate dalla critica e dagli ascoltatori illuminati che guardano dall’alto verso il basso chi ha gusti musicali massificati. Alcuni restano, è evidente, ma rimangono soprattutto le canzoni pop. Quelle sì che entrano nelle vite delle persone e dicono chi siamo come collettività. Secondo questo ragionamento, Lives Outgrown di Beth Gibbons è un discone di quelli che non restano. Ed è magnifico.
Ecco un’altra cosa poco canzonettara e per niente pop: Lives Outgrown è un disco sulla mezza età, e quindi sul corpo che s’indebolisce, sulla menopausa (davvero), sulla prospettiva della morte che a 59 anni si fa un po’ più concreta, sull’effetto che fa assistere alla scomparsa di amici e famigliari. Nei testi c’è la certezza d’essere tutti quanti, lei e noi, diretti verso il nulla, troppo terrorizzati per sentirci liberi, stupidi che capiscono all’ultimo momento che dovevano vivere di più e meglio. Sembra roba pensata apposta per tenere alla larga il pubblico.
Siccome Gibbons è una tipa piuttosto riservata (per chi non la conosce: trattasi di eufemismo), non ha detto granché di queste canzoni prodotte con James Ford, uno degli architetti della lounge spaziale degli Arctic Monkeys e di mille altri dischi, tra cui l’ultimo dei Pet Shop Boys (ma tu pensa) e Memento Mori dei Depeche Mode (pure Lives Outgrown in fondo è un po’ un memento mori). Una cosa però Gibbons la dice in un comunicato stampa e cioè che «mi sono resa conto di com’è la vita senza la speranza. È una tristezza che mai avevo provato. Prima avevo la possibilità di cambiare il futuro, ma quando ti scontri col tuo corpo non puoi costringerlo a fare qualcosa che non vuol fare».
In un mondo di suoni preconfezionati, Lives Outgrown ha una “voce” unica, un suono folk non replicabile fatto di strumenti a corda che ti pare quasi di toccare, cori che sembrano provenire dall’altro mondo, un pianoforte che Ford suona con un cucchiaio e poi tupperware, cassetti di legno, lattine, una padella per paella e altre cose percosse da Lee Harris dei Talk Talk. Banditi i beat. Anche i timbri acustici ed elettrici sono spesso elaborati e un po’ camuffati in modo artigianale, non usando plug-in. È folk a un passo dall’esoterico, con mediorientalismi che aggiungono mistero al mistero e passaggi sonori cinematografici come nella seconda metà di Beyond the Sun.
Beth Gibbons è uno degli ultimi misteri del pop. È lontana dai filoni vincenti della musica odierna, comunica poco, pubblica raramente dischi. Lives Outgrown può essere considerato il suo primo vero album solista. Arriva 22 anni dopo Out of Season fatto in coppia con Rustin Man, pseudonimo di Paul Webb dei Talk Talk, e a cinque anni dalla rilettura della terza sinfonia di Górecki, un po’ giusta (la conduzione del grande compositore Krzysztof Penderecki) e un po’ strana (lei contralto in una parte da soprano). Dati i temi, Lives Outgrown è il suo lavoro più personale, nonché quello a cui ha lavorato più a lungo, dieci anni. Se nella Symphony of Sorrowful Songs la cantante si calava tra le altre cose nei panni di una madre che piange il figlio morto in guerra, qui è la donna di mezza età che vede le opzioni assottigliarsi ed è costretta ad accettare che non andrà tutto bene. A volte l’album sembra la colonna sonora potente di una scena ambientata su un letto di morte, a volte un poema campagnolo sul disfacimento fisico, a volte una raccolta di litanie esistenziali. In ogni caso, è roba che non sentite altrove.
Qualcuno dirà che è un album noioso, ma è una stupidaggine. L’unica musica noiosa è quella poco interessante e questa invece ha un fascino suo dato dall’intreccio fra il canto espressivo e il timbro volutamente fragile di Gibbons e il suono materico degli strumenti. Si può cantare del fatto che si sfiorisce, si soffre, si muore e lo si può fare con grazia e mistero. Uno degli album dell’anno. Se hanno ragione i Pet Shop Boys, un discone che non resterà.