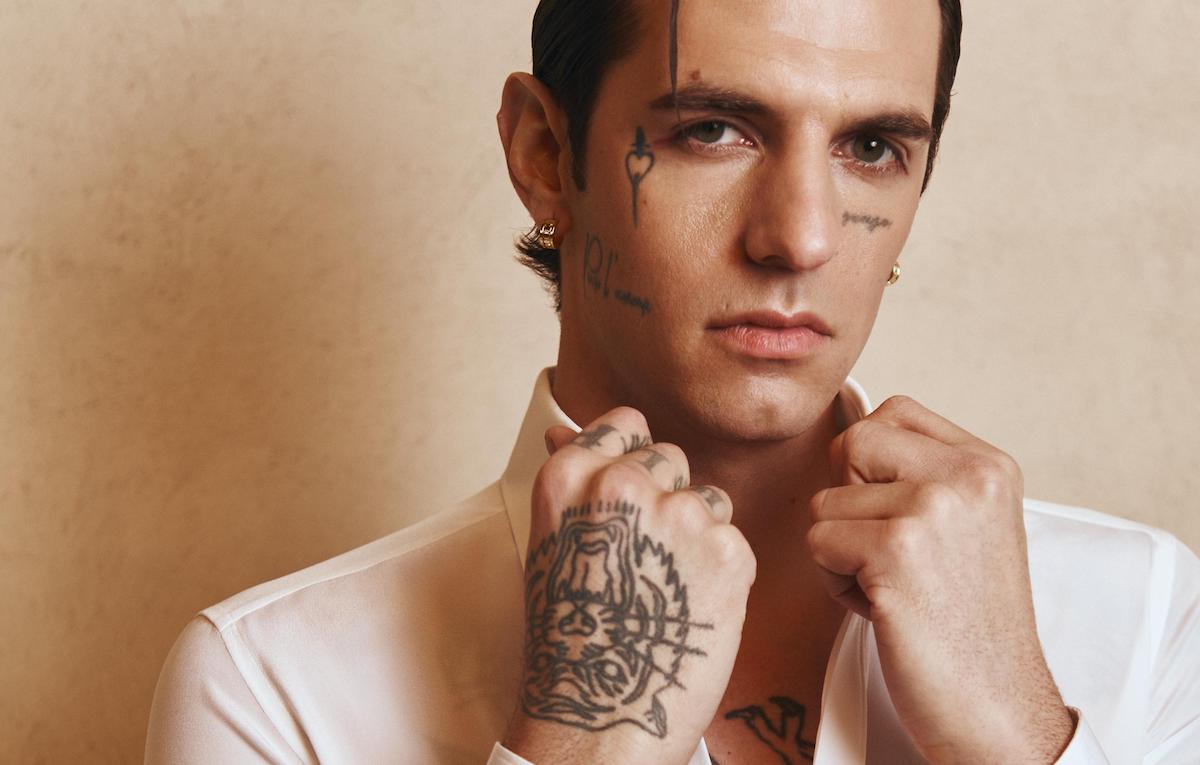Al 47esimo pezzo sui 50 dell’antologia che ripercorre la storia dei Rush arriva una specie di Easter egg. All’inizio di Headlong Flight del 2012 Alex Lifeson suona un assolo di chitarra a cui Geddy Lee e Neil Peart rispondono con rapidi colpi di basso e batteria all’unisono. È una replica voluta e pressoché identica di un passaggio di Bastille Day del 1975, a sua volta inclusa nella raccolta. È un modo per strizzare l’occhio al passato divertendosi e la dimostrazione del fatto che Rush 50 racconta la storia della band come se fosse una saga epica.
La struttura narrativa è il punto di forza di Rush 50. Che non è un greatest hits come Chronicles del 1990, anche se contiene molte delle canzoni più note della band. E non è nemmeno una raccolta di rarità, sebbene contenga una manciata di inediti. È invece un memoir musicale che pesca in ordine cronologico da tutti gli album in studio del trio con l’aggiunta di una buona dose di pezzi dal vivo, compreso l’ultimo medley eseguito durante il concerto di addio del 2015. Disponibile in varie versioni, tra cui una su 4 CD e una contenente 7 LP, è la prima antologia dei Rush a uscire dopo la fine della band e la morte di Peart avvenuta nel 2020. Curata, assemblata e confezionata con cura, è il giusto coronamento della carriera, ma funziona altrettanto bene come introduzione per non iniziati o come chicca per superfan.
Per chi fa parte di quest’ultima categoria, una delle attrattive principali di Rush 50 è il singolo di debutto uscito nel 1973 per l’etichetta della band, la Moon Records. Il 45 giri conteneva una cover di Not Fade Away di Buddy Holly e You Can’t Fight It, scritta a quattro mani da Lee e dal primo batterista John Rutsey. Non sono di per sé niente di speciale, specie se si pensa che in quello stesso anno sono usciti disconi di band che hanno indicato la via ai Rush come Houses of the Holy dei Led Zeppelin o Selling England by the Pound dei Genesis. Pure loro sembrano essere dello stesso avviso. «Mio Dio, lo odiavamo», dice Lifeson a David Fricke in uno dei due saggi contenuti in un volume cartonato in formato coffee table di oltre 100 pagine incluso nel box, insieme a un sacco di foto, con la grafica di Hugh Syme, autore storico delle copertine dei Rush. Lo odiavano, ma serve per cogliere l’evoluzione straordinaria avvenuta negli anni successivi.
Rush 50 rende giustizia a Rutsey, soprattutto con Need Some Love e Before and After, coppia di brani registrati durante un concerto del 1974 in una scuola superiore dell’Ontario (inclusi nel documentario del 2010 Beyond the Lighted Stage) che risultano molto più incisivi rispetto alle versioni in studio del debutto omonimo. Ma la parte iniziale del disco è solo un preludio al più importante cambio di batteristi avvenuto nella storia del rock: l’arrivo di Neil Peart nell’agosto del 1974.
È interessante confrontare un paio di inediti presi da un concerto tenuto a Cleveland meno di due settimane dopo il debutto di Peart (la cover di Bad Boy e la prima versione di Garden Road) con la versione live in studio di Anthem, il pezzo che apre Fly by Night, registrata solo quattro mesi dopo. Nei primi due Peart dà la propria interpretazione dei Rush 1.0, nell’altro si sente già il suo marchio di fabbrica, una miscela di potenza e precisione sbalorditive. È la fotografia del momento in cui il batterista getta le basi del sound maturo della band.
Rush 50 documenta magnificamente la grande stagione creativa compresa tra metà e la fine degli anni ’70 attraverso i capisaldi registrati studio (le sezioni iniziali di 2112 e Closer to the Heart) e una selezione di pezzi dal vivo potentissimi. In Something for Nothing, registrata alla Massey Hall di Toronto nel giugno 1976, sono evidenti tutti gli elementi che hanno reso il gruppo il power trio per eccellenza dell’epoca: il canto penetrante di Lee, i riff di Lifeson, l’aggressività di Peart. Una versione tirata allo spasimo della suite strumentale La Villa Strangiato al festival olandese Pinkpop nel 1979 spiega più di tante parole la crescita dell’abilità compositiva di pari passo con le doti tecniche. L’accoglienza del pubblico fa capire che i Rush sono riusciti a mettersi sempre alla prova continuando comunque a entusiasmare i fan (tra gli elementi di interesse ci sono anche cosiddetta Vault Edition di The Trees, fino a ora mai pubblicata fuori dal videogioco Rock Band, con un assolo di chitarra alternativo di Lifeson, e la versione di Working Man uscita in precedenza solo come singolo digitale).
La prima parte di Rush 50 contiene la maggior parte delle canzoni più note della band e una generosa rassegna del periodo successivo al boom commerciale di Moving Pictures del 1981. Per i puristi, ai tempi dei pezzi coi synth di metà degli anni ’80 i Rush si erano persi. E invece all’interno della storia narrata da Rush 50 suonano benissimo. In The Big Money del 1985, per dire, ci sono alcuni dei passaggi di chitarra più inventivi di Lifeson (e un assolo geniale) e in Time Stand Still del 1987 Peart adatta brillantemente la sua tecnica sovrumana a un contesto pop-rock contemporaneo.
Le sezioni dedicate agli anni ’90 e 2000 valorizzano album bistrattati come Counterparts del 1993 (vedi l’aggressività di Stick It Out tipica dell’era grunge) e Snakes & Arrows del 2007 (rappresentato dallo strumentale dinamico ed esotico The Main Monkey Business e da una versione live della struggente Workin’ Them Angels). È bello sentire i Rush portare sul palco con entusiasmo pezzi del loro catalogo più datato, come il tuffo breve e infuocato nello strumentale prog Cygnus X-1 del 1977, a Rio nel 2002, e l’interpretazione del 2004 di Between the Wheels, un brano poco noto di Grace Under Pressure del 1984 (è peraltro una delle tante canzoni di Rush 50 con un testo, scritto da Peart, terribilmente attuale, vedi anche Witch Hunt che evoca ineluttabilmente la xenofobia dell’era Trump: “Dicono che ci sono degli stranieri che ci minacciano / I nostri immigrati e infedeli”).
Oltre al singolo in apertura Not Fade Away, il brano più rilevante dal punto di vista storico è quello che chiude Rush 50, il documento inedito degli ultimi 10 minuti circa trascorsi sul palco davanti a un pubblico da Lee, Lifeson e Peart. A conclusione del tour R40, che prevedeva una scaletta di pezzi in ordine cronologico a ritroso, hanno fatto un salto indietro fino agli esordi suonando un medley di What You’re Doing e Working Man, dal debutto, con un frammento di Garden Road nel finale. Al di là della musica, colpisce quel che accade dopo. Mentre ringrazia pubblico e crew, Lee dice: «Wow, che sorpresa». Come i fan sanno, si stupiva dal fatto che Peart fosse venuto al suo fianco. In passato il batterista aveva sempre rispettato quello che lui chiamava il meridiano della backline e non aveva mai raggiunto i compagni di band sul fronte del palco, alla fine dello show. È un piccolo momento emozionante che commemora il legame fraterno tra i musicisti e chiude degnamente il viaggio di Rush 50 attraverso una delle storie più belle che il rock ci abbia regalato.