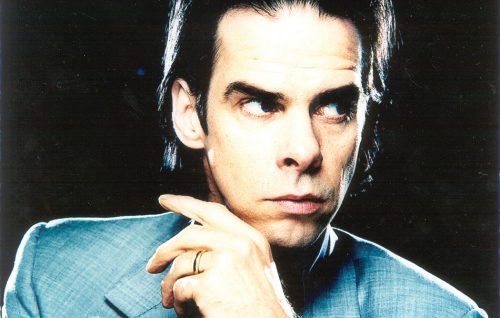È un dio selvaggio che attraversa le canzoni e viaggia senza requie inseguendo un miraggio. È un uomo straziato dai dubbi e dal dolore. È un mezzo mistico rapito da una visione di bellezza assieme carnale e spirituale. È un ex amante che s’abbandona ai ricordi. È un santo peccatore. Ci sono dieci versioni di Nick Cave nel suo nuovo album coi Bad Seeds, una per ogni canzone di Wild God. E tutti, o quasi, anelano a uno stesso glorioso finale. Ascoltando il disco, impari a volerlo anche tu. E arriva ogni volta, spesso sotto forma d’un coro femminile prodigioso e ultraterreno che intona parole di gioia e d’amore assoluto.
Wild God è la versione di Nick Cave d’una messa di Harlem, un’esperienza liminale tra sonno e coscienza, mito e realtà. È uno di quei dischi che dicono cose semplici e lo fanno in modo poetico, di quelli che solo grandissimi come lui o un tempo Cohen possono permettersi di fare. È una cerimonia pop in cui ogni pezzo racconta un’esperienza trasformativa, è una parabola sull’amore ambientata in un mondo che è questo, ma è anche un altro. Come attratto da una forza misteriosa, questo carico di musica e parole, di suoni ed emozioni parte da una qualche miseria, a volte di nuovo la morte di un figlio, e tende inesorabilmente verso una forma di realizzazione estatica o se preferite di pura e semplice ed elementare felicità. È un hallelujah alla vita com’è, nel bene e nel male. È un disco che grida gioia, gioia, gioia.
Erano cinque anni che Nick Cave non faceva un album coi Bad Seeds. Nel frattempo, ha reso ancora più solido il legame di collaborazione con Warren Ellis, col quale ha scritto e prodotto non solo il disco di canzoni Carnage al quale è legato il film This Much I Know to Be True, ma anche varie colonne sonore, da La panthère des neiges a Blonde fino alla recente Amy. Non significa che Wild God sia un album come quelli vecchi dei Bad Seeds. Non lo è, non potrebbe esserlo, non ci sono performance cariche di quell’assurda intensità che lambiva la violenza. E però, ben più di Ghosteen del 2019, è il disco di un collettivo (che comprende non solo i Bad Seeds ma anche le coriste del Double R Collective, Colin Greenwood dei Radiohead al basso, Luis Almau alle chitarre acustiche) che circonda e direi abbraccia il cantante che sta al centro della scena e racconta le sue parabole con voce ferma e vivida, quasi da evangelista. Ed è una voce credibile, in tutti sensi anche se queste canzoni sembrano a volte favole e a volte passaggi della Bibbia. E forse è questo di cui oggi abbiamo disperatamente bisogno, di voci credibili.
Uscire dal dialogo a due con Ellis, che comunque qui è co-autore di tutte le musiche, ha fatto bene a Cave. Come i precedenti, Wild God è un disco a cui si deve un po’ di devozione affinché lo si possa apprezzare, ma è decisamente più vivace e carico di positività di Ghosteen, il che lo rende più facile da sentire nonostante sia lontano dai canoni della musica odierna. Ma oramai Nick Cave fa storia a sé, è lontano dalla nostra modesta contemporaneità. La caratura è quella delle opere migliori del Cave maturo. Se altri suoi dischi potevano sembrare a tratti troppo verbosi, troppo personali, troppo introversi per colpire, questo è fatto per farti muovere e commuovere. Lo spirito è quello dei concerti coi Bad Seeds che ha portato in giro di recente, facendone uno epico all’Arena di Verona.
C’è un forte richiamo ad essere presente alla propria esistenza, ora, adesso. Il pensiero del futuro non c’è, il passato va messo alle spalle, l’imperativo è accettare e abbracciare la vita. A credere negli altri per tornare a credere in sé stessi. Lo si sente ad esempio nella title track, racconto fiabesco nel cui protagonista è facile vedere Cave, uno spirito che entra ed esce dal passato, dalle sue stesse canzoni, dai luoghi del mondo in cerca di qualcosa che scopriremo essere una forma di trascendenza collettiva ed euforica, con l’immagine dell’uomo dai lunghi capelli che attraversa questa e altre canzoni ispirata ai versi di S. Giovanni della Croce: “La brezza d’alte cime, allor che i suoi capelli discioglievo, con la sua mano leggera il collo mio feriva e tutti i sensi miei in estasi rapiva”.
Prima di Wild God c’è un’altra canzone favolosa chiamata Song of the Lake, altra scena fiabesca su un uomo testimone della bellezza di una donna che è assieme immensa e dolorosa, che è dolorosa poiché immensa. È gioia fin dal titolo Joy, che ha un testo che si rifà al canone blues ed è un miscuglio di immagini fenomenali, dolore, lutto, sogno, con un coro che è una stretta confortante, a noi e al cantante, e l’immagine di un fantasma con un paio di enormi scarpe sportive ai piedi (il figlio?) che gli dice che “abbiamo avuto troppi dispiaceri, è il momento della gioia”. Il massimo è essere Frogs, rane che sguazzano felici in uno stagno e saltano in alto. Forse anche loro mirano senza saperlo alla trascendenza o all’infinito e poco importa se ogni volta ricadono in basso, nel fango.
Wild God è anche un disco di donne che cercano di salvare uomini (Final Rescue Attempt, forse per la moglie Susie Beck), di incontri mistici (Conversion, con un altro coro prodigioso e un titolo che fa capire che tutte queste canzoni in fondo raccontano conversioni di qualche tipo), di sogni che si mangiano la realtà (Long Dark Night). È musicato con un mix tra il suono caldo dei Bad Seeds maturi, occasionali interventi orchestrali che somigliano a una tempesta benevola, cori e voci che svolazzano attorno a quella del protagonista. Spesso, più che canzoni costruite in modo tradizionale sono racconti in musica, ma a differenza di molti altri recenti album di Cave Wild God è volutamente accessibile, carico di un’emotività diretta, semplice, umanissima, pop.
I giorni selvaggi e nichilisti dei Bad Seeds sono andati, passati, alle spalle. Da ombre del male Cave li ha riconvertiti in apostoli del bene. Wild God è il punto d’arrivo magari solo temporaneo del percorso di evoluzione del personaggio e di esplorazione del dolore iniziato con la morte del figlio Arthur. Qui ogni cosa è illuminata. È la vita che s’afferma dopo la morte. “Get ready for love”, cantava Cave vent’anni fa, ma neanche quella canzone esplosiva poteva prepararci a queste “trionfanti metafore d’amore”, a questo teatro di sentimenti positivi che solo un pazzo potrebbe considerare buonista, a questo suono che è rock ma anche soul e gospel e sembra un’onda a cui è difficile se non inutile resistere.
E che finale. Prima O Wow O Wow (How Wonderful She Is), dedica ad Anita Lane, ritratto dolce e campagnolo che ha qualcosa di fiabesco (di nuovo), una trappola ben architettata da Cave e dai suoi per farti innamorare di lei e poi farti commuovere quando parte un messaggio lasciato nel 2019 nella segreteria telefonica del cantante. E infine As the Waters Cover the Sea, un’immagine presa dal Libro di Isaia (“perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare”), altra metafora di rinascita, due minuti conclusivi semplici e pazzeschi, dallo spirito quasi natalizio.
È la chiusura perfetta di un album dove s’attraversano le dimensioni del sogno, del divino, del fiabesco con una compostezza invidiabile e un talento del mescolare musiche e parole che ha pochi uguali oggi. È un gran disco, ma immagino che questo lo si sia capito.