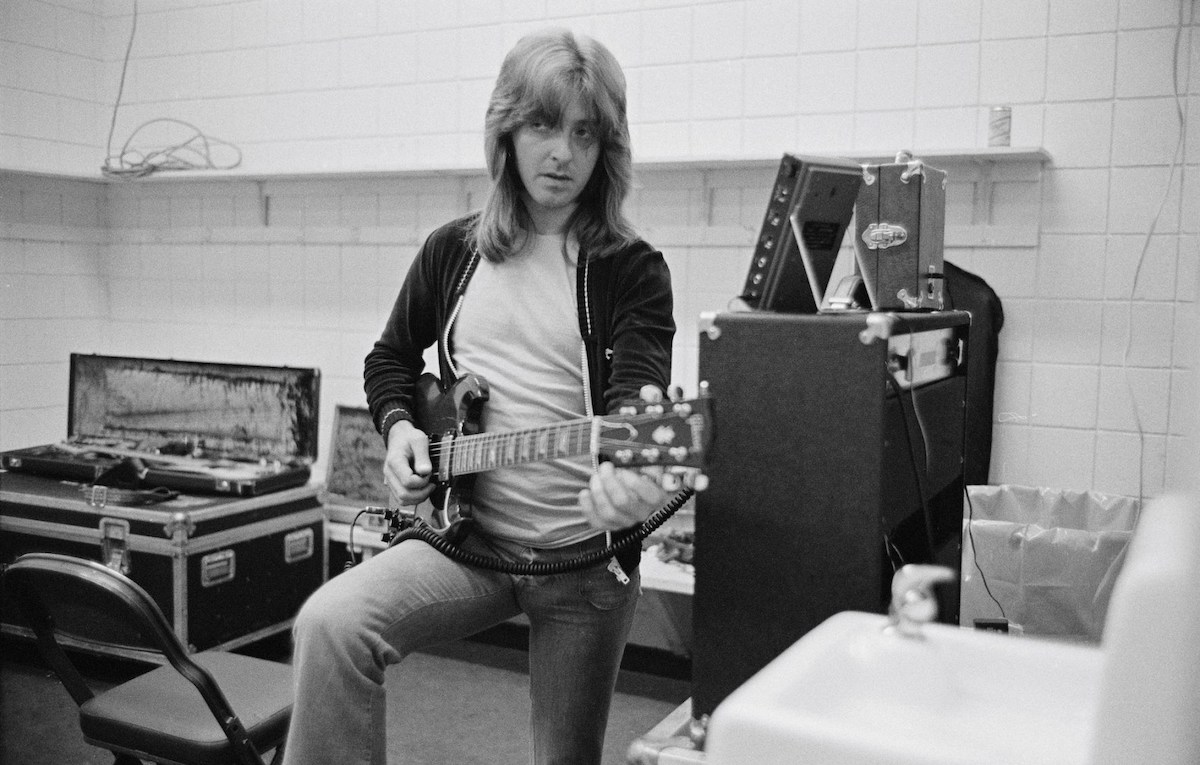Nel 1973 George Harrison era per tutti il Beatle che stava uscendo meglio dalla fine della band. Era diventato una superstar anche come solista grazie al triplo All Things Must Pass e al Concerto per il Bangladesh di cui s’era fatto promotore. Liberatosi dai Fab Four, aveva ottenuto tutto ciò che da sempre desiderava? Non esattamente. E difatti ha cambiato tutto col capolavoro dimenticato Living in the Material World, pubblicato 50 anni fa, alla fine di maggio del 1973, scegliendo un approccio più minimale e firmando l’opera più profondamente strana della sua carriera.
Living in the Material World è considerato un brutto pasticciaccio pieno di predicozzi. Un po’ come Ram di Paul McCartney, disprezzato da tutti per decenni, è stato messo da parte fino a quando gli hipster dell’indie non l’hanno riscoperto e hanno capito che c’era del genio. Evidentemente i tempi erano maturi.
Non è uno di quei dischi che ti tirano su il morale come All Things ed è proprio questo il punto. All Things è la grande dichiarazione spirituale di un ex Beatle, Material World è l’opera di un uomo confuso e amareggiato nonostante la giovane età. Sta per compiere 30 anni e, dopo avere assaporato il successo, si chiede perché la sua vita non sia più divertente. Attorno a sé vede solo tradimenti e paranoia. Non c’è da stupirsi che suoni attuale nel 2023.
Harrison trasforma la sua crisi spirituale in canzoni candide, conflittuali, contraddittorie. Mette in fila nel disco momenti pessimi, ma anche meravigliosi. Non era mai stato così spudorato: si mette a nudo come mai prima, né dopo. Avrà pure subìto un duro colpo, ma guardiamo il lato positivo: almeno ha vicini sua moglie Pattie Boyd e il suo migliore amico Eric Clapton. Cosa potrebbe mai andare storto?
George fa un passo indietro rispetto alla dimensione epica di All Things Must Pass e tira fuori l’album di una band, inciso col secondo miglior gruppo che abbia mai avuto, un manipolo di compagni fidati: Klaus Voorman al basso, Jim Keltner alla batteria, Nicky Hopkins al pianoforte, Gary Wright all’organo. Il sound è intimo, a misura d’uomo, con la semplicità meravigliosa di Be Here Now, Don’t Let Me Wait Too Long e la hit Give Me Love (Give Me Peace On Earth).
Per la prima volta George si cala anche nei panni del produttore, suona la slide e torna persino a mettere le mani sul sitar, lo strumento che l’aveva portato a iniziare il suo percorso spirituale, ma che non toccava da anni. È il suo album di cantautorato proto-indie. Non a caso, la cover più nota l’ha fatta Elliott Smith con Give Me Love, cogliendone lo spirito malinconico. E The Day The World Gets ‘Round ha un’atmosfera che rimanda ai futuri Pavement di Wowee Zowee o Brighten the Corners.
Give Me Love (Give Me Peace On Earth) è il pezzo centrale del disco, una delle canzoni più belle mai scritte dai quattro Beatles, prima e dopo lo scioglimento. Sono pochi minuti brillantissimi di genio, c’è tutto il tormento di Harrison, tutto il suo struggimento, il suo disincanto, la sua speranza. E li esprime finendo per elevare i musicisti che lo accompagnano. Klaus Voorman ha mai suonato il basso con questo trasporto? Nicky Hopkins ha mai suonato in modo così estatico? Una chitarra è mai parsa così felice di essere nelle mani di qualcuno? Harrison aveva un legame speciale con Give Me Love. Scrive nella sua autobiografia I Me Mine: «È una preghiera e una confessione intima che condivido col Signore e con chiunque voglia ascoltarla».
È facile capire perché Material World ha una brutta nomea: George proprio non ce la fa a mettere da parte le sue stronzate cosmiche. Il disco è pieno di roba pomposa da predicatori e di momenti di ipocrisia indotti dalla cocaina abbinati a momenti di autentico calore umano. Harrison esorta i fan a essere più rispettosi dei sentimenti del Signore, ma tratteggia una sua versione di Dio che è ben misera, degna di una casalinga di Real Housewives a corto di pillole (“Il Signore ama chi ama il Signore”: mio Dio, cosa sei, un dodicenne?).
Harrison non se la passava granché bene. Predicozzi moralistico-religiosi a parte, la sua vita era un gran casino di sesso e droga. Si sentiva tradito dopo il lavoro fatto per il Bangladesh. I fondi erano stati sottratti da consulenti di cui si era fidato che l’avevano lasciato con un milione di sterline di tasse da pagare. E c’erano pure le grane legali infinite dei Beatles, che hanno ispirato Sue Me, Sue You Blues.
E poi c’era la vita privata. L’amata mamma Louise si era ammalata di cancro nello periodo in cui i Beatles si stavano sgretolando ed era morta nel luglio 1970. Non fa mai il suo nome nel disco, ma il dolore per la perdita emerge dalla musica, soprattutto in Be Here Now, il pezzo di un figlio che, devastato dal dolore, piange intonando il mantra “non è più come prima”. Proprio come John in Julia o Paul in Let It Be, anche lui ha tratto ispirazione per alcune delle sue canzoni più emozionanti dallo sconforto per la perdita della madre.
Nota bene: nel 1970, l’anno della morte della madre di Harrison, sono usciti Let It Be dei Beatles, la canzone Mother di Lennon e Sentimental Journey di Ringo Starr, un album di vecchie canzoni che piacevano tanto a Elsie Starkey, ancora viva e in ottima salute. «L’ho fatto per mia mamma», diceva il batterista. Anche quando si stavano separando, i quattro sono rimasti in qualche modo fratelli.
Don’t Let Me Wait Too Long è una gemma. Anche se George aveva chiuso con Phil Spector, è la cosa più spectoriana che abbia mai fatto, un pezzo pop da girl group anni ’60 all’altezza delle Crystals o delle Ronettes. Ogni dettaglio è curato con amore: la batteria potente nel ritornello, il clavicembalo, le nacchere alla Be My Baby. George è sempre stato un fan devoto dei gruppi femminili. Quello che a tutti è sfuggito, a proposito di My Sweet Lord, è che il contenzioso legale per la somiglianza con He’s So Fine delle Chiffons non è dovuto al caso: la fede di Harrison nelle Chiffons non era meno forte delle sue altre convinzioni spirituali, e difatti quella è la canzone d’amore più sincera dell’album.
Lo spirito di Ronnie Spector è presente anche in Try Some Buy Some, un valzer meravigliosamente bizzarro che George aveva scritto per il singolo del ritorno di Ronnie, nel 1971. Come ha raccontato la cantante nell’autobiografia Be My Baby, gli ha detto: «Non capisco una parola». E lui: «Non fa niente, neanch’io». David Bowie era un grande fan del pezzo, che ha cantato in Realit, interpretandolo come un’allegoria della dipendenza e della disintossicazione.
Leggendo il titolo Be Here Now uno si aspetta il peggio, ma il brano, un’elegia per Louise Harrison, arriva dritto al cuore con un testo ridotto ai minimi termini. Il sitar di George aggiunge un effetto bordone inquietante, ma è anche una canzone nel tipico stile della California meridionale, con quell’atmosfera folk-rock alla Blue Jay Way o Long, Long, Long. L’ha scritta sulle Hollywood Hills e nel lavoro della chitarra si sente un che di Neil Young.
Fa sorridere il fatto che Be Here Now sia diventato il titolo di uno dei dischi rock più drogati mai pubblicati, l’album gli Oasis del 1997 che sta alla cocaina come quello di Harrison sta a Krishna. Ancora più divertente è il fatto che Noel Gallagher ha avuto la faccia tosta di attribuire l’ispirazione per il titolo a Lennon (George l’aveva preso dal libro di Baba Ram Dass), un’affermazione che ha spinto George a tenersi ben lontano ogni qual volta Paul si è fatto fotografare con Noel. In ogni caso, Noel ha anche intitolato una grande hit degli Oasis ispirandosi alla colonna sonora di George del 1968 Wonderwall Music.
Un altro aneddoto pop: George deve aver apprezzato il fatto che la title track Living in the Material World ha ispirato una delle hit più fondamentali di Madonna degli anni ’80, appena prima che lui producesse il suo film Shanghai Surprise del 1985. In fondo, Material Girl aveva un animo e un umorismo sfacciato molto alla Beatles e la protagonista poteva essere benissimo la ragazza di Drive My Car. Madonna ha poi intrapreso un viaggio spirituale simile a quello di George, passando da Material Girl a Ray of Light nell’arco di 13 anni, lo stesso lasso di tempo che per George è trascorso fra Amburgo e Material World. Tutte le cose devono passare, in effetti.
In Material World Harrison confessa di sentirsi prigioniero della propria vita. “Non so cosa ci faccio qui / Ma spero di vederci molto più chiaro”. Non c’è un filo di speranza nella voce, non prova nemmeno a fingere. Giura che sta “cercando di far passare un messaggio”, anche se il suo unico messaggio è che ne sta cercando disperatamente uno. E il suo unico legame umano è costituito – sorpresa! – dai suoi vecchi amici Beatles. “Li ho incontrati tutti qui nel mondo materiale / John e Paul qui nel mondo materiale / Anche se abbiamo iniziato da poveri / Abbiamo portato Richie in tour”. C’è qualcosa di tenero nel modo in cui parla di Ringo usando il nome d’infanzia Richie, anche perché alla batteria c’è proprio lui.
Il delizioso lato B Miss O’Dell avrebbe dovuto essere inserito nell’album. George spettegola sul conto della sua vecchia amica e impiegata della Apple Chris O’Dell, ma poi gli scappa troppo da ridere per riuscire a cantare la seconda strofa. In una take, dice “Garston 6922”, che era il vecchio numero di telefono di Paul a Liverpool: ricordava il puro divertimento rock’n’roll di Apple Scruffs o Wah Way, ma era una canzone troppo leggera per la missione che Harrison si era dato.
Un anno dopo, Dark Horse segna la fine della mistica di George. Potremmo considerarlo il peggior album solista di un Beatle fino a quel momento: almeno il Wedding Album di John & Yoko può fare da sottofondo mentre si lavano i piatti, mentre Dark Horse è solo una sarabanda alcolica di autocommiserazione, per di più registrata quando aveva una brutta laringite. Da quando Pattie l’aveva lasciato per Clapton aveva anche contratto la Layla-ite. In pubblico, George si è comportato in modo civile, dichiarando che «preferisco che lei stia con lui piuttosto che con un idiota». Peccato che non fosse in grado di creare musica in quel momento, come purtroppo ha dimostrato nell’attesissimo tour solista del 1974, che ha spazzato via tutta la stima conquistata in precedenza. Risultato: Material World è diventato marginale.
È stato messo in ombra da All Things e persino i fan più accaniti dei Beatles hanno preso le distanze dal disco. Robert Christgau ha riassunto le critiche con la sua tipica arguzia: «Harrison canta come se stesse facendo l’imitazione di un sitar e quattro persone diverse, tra cui un omino nella mia testa che non avevo mai notato prima, mi hanno ringraziato quando ho spento quel dannato affare su Be Here Now».
Nella musica di George sono tornate luce e vita dopo avere conosciuto la moglie Olivia Arias. Negli anni ’70 ha scritto alcuni dei suoi brani migliori: Oooh Baby (You Know That I Love You) su Extra Texture, Blow Away e Here Comes the Moon su George Harrison e soprattutto Pure Smokey su Thirty Three & 1/3. Quando la sua carriera ha nuovamente decollato, alla fine degli anni ’80, la gente era talmente contenta di averlo ritrovato da perdonargli e dimenticare la maggior parte della produzione dei ’70 successiva a All Things Must Pass, compresa purtroppo tanta grande musica. Come Living in the Material World, che è pieno di grandi momenti. Vale la pena riscoprirlo.
Da Rolling Stone US.