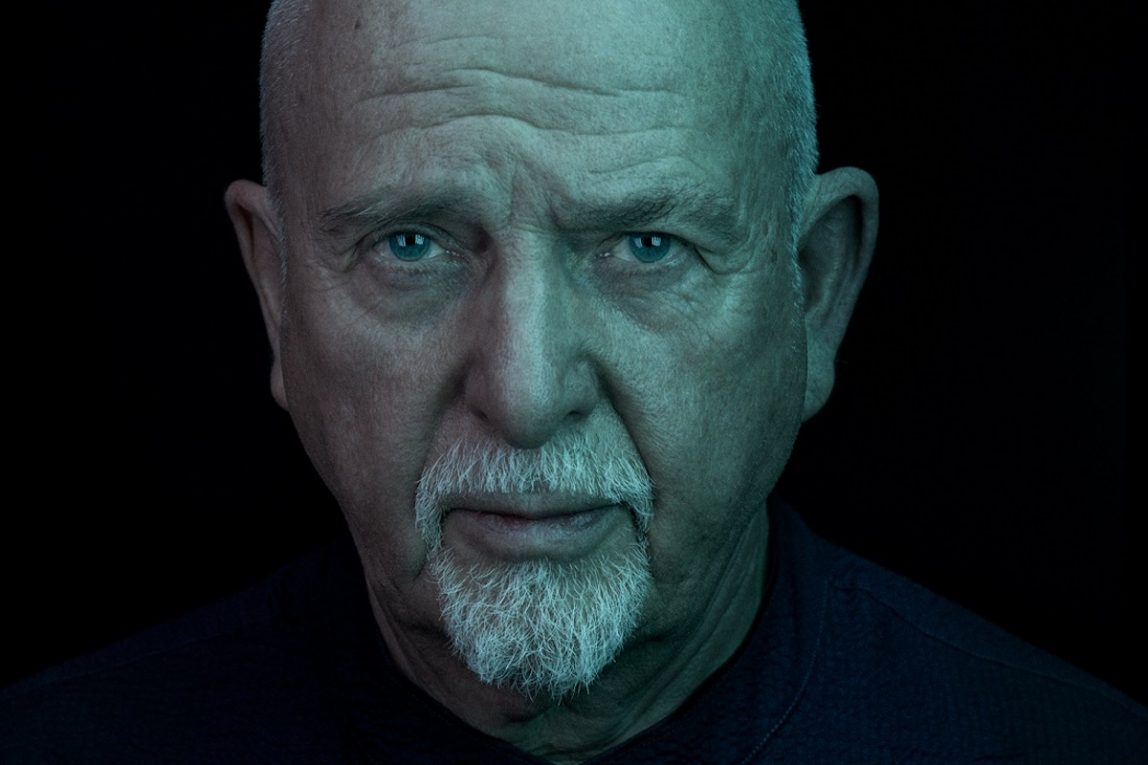Quando il dolore è arrivato, David Bowie stava cantando una canzone intitolata Reality. Era una sera del giugno 2004 durante una data di un lungo tour che lo aveva portato nel caldo soffocante di un palazzetto di Praga. Reality, la title-track dell’album uscito un anno prima, parla di affrontare la mortalità e mettere da parte le illusioni. A 57 anni, Bowie lo stava facendo da tempo. Era sobrio e aveva finalmente smesso di fumare. Stava prendendo dei farmaci per abbassare il colesterolo e si allenava con un personal trainer. Quella sera, come sempre, sembrava un extraterrestre senza età: magro, con i lunghi capelli biondi sulla fronte senza rughe e una sciarpa fluorescente intorno al collo. Però, quella notte, mentre era al centro del palco e stava cantando “Ora la mia morte non è più solo una canzone triste” (un riferimento alla sua interpretazione di My Death di Jacques Brel che risaliva al periodo apocalittico di Ziggy), all’improvviso è rimasto senza fiato. Ha portato una mano al petto e ha smesso di cantare, lasciando il pezzo incompiuto. «Ha girato la testa e mi ha guardato», ricorda la bassista Gail Ann Dorsey, «era pallido, quasi trasparente. La camicia era zuppa di sudore. Stava lì in piedi, immobile. Ho visto le facce degli spettatori in prima fila cambiare espressione, dalla gioia alla preoccupazione». Un bodyguard si è precipitato sul palco e lo ha portato via.
In qualche modo Bowie è riuscito a portare a termine il concerto prima di incontrare un medico che gli ha diagnosticato la compressione di un nervo nella spalla e gli ha prescritto dei rilassanti muscolari. Due giorni dopo Bowie ha fatto un altro concerto in Germania, nel quale ha cantato per l’ultima volta Ziggy Stardust. Non ha perso una nota, poi è sceso dal palco ed è collassato. Poco dopo è stato operato d’urgenza per un’arteria coronarica ostruita.
Quella notte ha segnato la fine di David Bowie come personaggio pubblico. Non ha mai più fatto tour né rilasciato interviste. È diventato talmente riservato da rimproverare il suo collaboratore più stretto, Tony Visconti, per aver rivelato che durante le pause in studio guardavano insieme i programmi comici inglesi in televisione.
Quando è tornato nel 2013 a sorpresa con il primo album dopo 10 anni, The Next Day, ha compiuto un’opera che nessun’altra rockstar è mai riuscita a portare a termine, quella di recuperare in un colpo solo tutto il mistero dei suoi anni migliori, se non di più. È diventato una leggenda, un fantasma vivente, nascosto dietro abiti comuni, mentre accompagna sua figlia a scuola, prende un taxi, fa esercizio insieme ai comuni esseri umani in una palestra di Manhattan. Quando sta in famiglia, dice, è solo David Jones, la persona che era prima di diventare David Bowie. Alla fine è caduto veramente sulla Terra e quello che ha visto gli è piaciuto. I suoi ultimi tre anni sono stati un periodo di straordinaria creatività. Nel 2014 ha cominciato a lavorare a un nuovo album, Blackstar e nello stesso tempo ha collaborato a un ambizioso musical off-Broadway, Lazarus, basato sulle sue vecchie canzoni. La sua morte il 10 gennaio 2016, due giorni dopo l’uscita di Blackstar, e un mese dopo il debutto di Lazarus, ha generato un’ondata di dolore in tutto il mondo che non si vedeva dai tempi di Michael Jackson o Elvis Presley. Visconti, che sapeva della malattia, aveva notato da subito il tono di alcuni testi di Blackstar. «Che fottuto bastardo», gli ha detto un giorno, «stai scrivendo il tuo album di addio». Bowie ha risposto con una risata.
«Il modo in cui ha vissuto il suo ultimo anno è una incredibile fonte di ispirazione», dice Visconti, facendo notare che, nonostante la malattia, ha scritto alcune delle sue strofe più divertenti (“Mi ha preso a pugni peggio di un uomo”, “Dove sono finiti i lunedì?”): «Non ha perso il senso dell’umorismo». Nei momenti peggiori Visconti cercava di rassicurarlo: «Mi chiamava subito dopo aver finito le cure e non riusciva neanche a parlare. “Non ti preoccupare, ce la farai”, gli dicevo. E lui: “Non ci sperare troppo”».
Le ultime settimane del tour di Reality sono state piuttosto tristi. Due mesi prima del suo attacco di cuore, uno dei tecnici è morto cadendo dal palco. Qualche settimana dopo dal pubblico qualcuno ha lanciato un lecca lecca che lo ha colpito nell’occhio sinistro già danneggiato. Un episodio che lo ha turbato molto. Da tempo Bowie aveva confessato al suo tastierista Mike Garson (l’uomo dietro al folle assolo di piano di Aladdin Sane) la sua intenzione di passare più tempo con la famiglia: la moglie Iman e la figlia Alexandria nata nel 2000. Bowie ha cresciuto il suo primo figlio Duncan Jones, nato nel 1971 e oggi un affermato regista, portandoselo dietro in mezzo ai tour, alla dissolutezza e ai cambi di personalità degli anni ’70. Bowie adorava Iman. Durante un tour in Giappone con i Tin Machine nel 1992, racconta Tony Sales, suo compagno nella band, si era fatto tatuare sul polpaccio un ritratto di Iman a cavallo di un delfino, con la preghiera della serenità scritta sotto, un’immagine che aveva disegnato lui stesso. «Più o meno a tre quarti del tour di Reality», ricorda Garson, «mi ha detto: “Mike, dopo questo tour ho intenzione di vivere una vita normale e fare il padre di famiglia. Voglio vedere crescere Lexi e starle accanto. È una cosa che mi è mancata la prima volta».
Aveva anche altri progetti ambiziosi: «Volevamo fare altri tre album», dice Visconti: «Un disco di elettronica, per esempio. Aveva anche in mente un nome per un nuovo gruppo. Voleva divertirsi e lavorare senza troppa pressione». I due hanno affittato uno studio nello spazio di Philip Glass a New York. Visconti lo gestisce per due anni dopo l’attacco di cuore di Bowie, ma alla fine lui gli dice: «Vendo le quote, non credo che userò quello studio. Voglio prendermi una pausa». Diceva sul serio: non ha cominciato a lavorare a The Next Day fino al 2010.
Nel 2005 ricompare brevemente per due brevi concerti con la sua band preferita del momento, gli Arcade Fire. «Sto molto bene», dichiara a un reporter durante le prove. Sale sul palco altre due volte: nel maggio 2006 a Londra per rendere omaggio a una delle sue fonti di ispirazione, Syd Barrett, e per cantare insieme a David Gilmour Arnold Layne (e tanto per non farsi mancare nulla, anche Comfortably Numb). Sei mesi dopo canta tre pezzi a un evento di gala accompagnato da Mike Garson e duetta con Alicia Keys sulle note di Changes. È l’ultima canzone che esegue dal vivo.
Che fottuto bastardo. Stai scrivendo il tuo album di addio
Sempre nel 2006 raggiunge in studio un’altra band che ammira, i TV on the Radio, per cantare in un loro pezzo, Province. Il suo consiglio alla band, secondo quanto ha raccontato Dave Sitek, è: «Non piegate la testa. Rimanete strani». In quel periodo dice anche a un giornalista di essere «stufo» dell’industria discografica. «Faccio passeggiate e guardo tonnellate di film. Una volta ho visto tre film di Woody Allen di seguito. Mi piace andare al cinema Angelika a Downtown, se il film non è un granché, mi infilo nelle altre sale, una dopo l’altra. È facile». In un’altra intervista dice: «Mi piace vedere nuove band, nuovi teatri, mostre, tutto. Vado ovunque, senza farmi notare e mai oltre la 14esima». Ha ideato un trucco per diventare invisibile a Manhattan: porta sempre con sé un giornale in lingua greca, in modo da convincere i curiosi di essere un signore greco che assomiglia a David Bowie. Quando non si dedica di nascosto alla cultura, dipinge e fa schizzi con il carboncino. Insieme a Lexi e Iman si divide tra Manhattan e Woodstock. Si è innamorato della «spiritualità» delle Catskill Mountains mentre registrava un album nello studio di Tony Visconti e ha comprato un terreno di 64 acri con l’idea di costruire una casa. D’estate affitta una stanza in un bed & breakfast e ha anche comprato una seconda casa in cui ha costruito una grande biblioteca. «La montagna mi piace», ha detto nel 2003, «sono un Capricorno, sono nato per andarmene in giro sui monti. Non sono mai stato uno da Woodstock, un hippy o cose del genere, ma quel posto mi ha conquistato subito per la sua bellezza».
Nel 2007 collabora con il New York Highline Festival e annuncia di voler fare un «grande concerto all’aperto». Quando smentisce, le voci sulle sue condizioni di salute ricominciano a girare. «L’ho visto nel 2008 e nel 2009», dice Tony Visconti, «e aveva preso peso. Era robusto, in forma. Il viso era roseo, prendeva medicine per il cuore, ma stava bene. Era come tante persone di 50 o 60 anni che prendono medicine per il cuore e vivono a lungo». Non fa neanche vita da recluso. Accompagna Iman agli eventi, diventando una presenza fissa sui red carpet, allegro e vestito in modo impeccabile, ma sempre silenzioso. Partecipa anche alla prima del film di fantascienza Moon di suo figlio Duncan Jones e posa orgoglioso con lui per i i fotografi. Le sue scelte fuori dall’ambito musicale sono stravaganti: nel 2006 compare in una puntata della serie Extras di Ricky Gervais, doppia il cartone animato preferito di Lexi, SpongeBob SquarePants e recita in The Prestige di Christopher Nolan, nel ruolo dell’inventore Nikola Tesla, e nel film indipendente August, nel ruolo di un temibile dirigente d’azienda. Nolan deve implorarlo per farlo partecipare al suo film, per l’altro invece si candida Bowie stesso. Le condizioni che pone però sono imprescindibili: «Si presentava sul set con le battute preparate e recitava la sua parte», ricorda il regista Austin Chick, «ma per nessuna ragione al mondo mi era permesso di dirigerlo».
Nel gennaio del 2013 Bowie ha convinto il mondo di essersi ritirato definitivamente dalla musica, quindi quando all’improvviso annuncia l’uscita del suo primo album in 10 anni, The Next Day, la risposta è entusiasta. «Erano tutti felicissimi», ha detto Bono degli U2, «anche lui era contento di suscitare ancora tanto interesse». Scherzando, Bowie dice a Bono che per una volta il suo compleanno non verrà oscurato da quello di Elvis, nato anche lui l’8 gennaio.
Ha composto 30 canzoni e le ha registrate ai Magic Shop Studios, dietro l’angolo del palazzo in cui abita a Soho. Insieme a Visconti registra dal vivo le basi strumentali e suona alcune parti di chitarra. È l’inizio della sua ultima ondata di creatività: «Non riesco a fermarmi», scrive in una mail a Floria Sigismondi, regista dei video di The Next Day, «sono nel pieno dell’ispirazione e continuo a creare». Nel marzo del 2013 porta Lexi e Iman a visitare la mostra David Bowie Is al Victoria and Albert Museum. «Credo che vedere la sua vita rappresentata in questa mostra sia stata un’esperienza inusuale per lui», dice la curatrice Victoria Broackes, «persino travolgente, in un certo senso». Durante il soggiorno a Londra dice anche al produttore teatrale Robert Fox di avere in mente un musical basato sul libro del 1963 L’uomo che cadde sulla Terra, che ha già portato al cinema nel 1976. Da allora è ossessionato dal personaggio, l’alieno Thomas Newton, e si identifica molto con lui. Le angosciose parti strumentali dell’album Low del 1977 erano un tentativo di rappresentare la mente di Newton. Fox lo mette in contatto con la drammaturga Enda Walsh, insieme stendono la prima bozza di sceneggiatura e nell’aprile del 2014 contattano il regista Ivo van Hove. È un grande fan di Bowie, ma ha già altri impegni: «Ho avvertito la sua fretta fin dal primo giorno», dice, «io volevo posticiparlo e lui mi diceva: “No, no, no, dobbiamo farlo adesso”». Nasce così Lazarus, la storia di Newton da vecchio, chiuso nel suo appartamento a tracannare gin, con il cuore spezzato e la convinzione di essere “un uomo alla fine della vita che non può morire”. La sua salvezza è l’apparizione di una ragazzina di 13 anni che riesce a fargli credere di poter tornare a casa e, come Gesù con Lazzaro, lo riporta in vita. «Ovviamente non è una coincidenza il fatto che la ragazzina avesse la stessa età della figlia di Bowie quando l’ha scritto», dice van Hove. Per Bowie sentir cantare le sue canzoni è un’esperienza nuova. Quando vede la cantante Cristin Milioti fare una versione dark e angosciata di Changes, non può fare a meno di sorridere: «Sono molto felice di averla scritta». Fin da ragazzo sognava di scrivere un musical: «Aveva la stessa espressione di un bambino stupito e al massimo della felicità», racconta James Nicola, direttore artistico del New York Theater Workshop, che ha prodotto lo spettacolo.
Bowie sta anche scrivendo nuove canzoni. Nell’estate del 2014 registra con Visconti un singolo intitolato Sue (Or in Season of Crime) con la Maria Schneider Orchestra, che viene pubblicato nella compilation Nothing Has Changed. È un pezzo con influenze jazz, epico e orchestrale in cui tra gli altri suona il sassofonista Donny McCaslin, che insieme alla sua band sarà il centro musicale dell’ultimo album di Bowie. Quando arriva in studio a New York per registrare Blackstar, Bowie non ha più sopracciglia né capelli. Ha già svelato ad alcuni amici e collaboratori di avere il cancro. «È arrivato direttamente da una seduta di chemioterapia, non era possibile nascondere la cosa alla band», dice Visconti, «quando me l’ha detto di persona mi è mancato il fiato». Bowie chiede di non dire niente a nessuno. L’argomento non viene più tirato fuori.
Era ottimista, perché aveva visto che stava funzionando. Poi a un tratto, a metà dell’anno scorso hanno detto che stava guarendo
«È stato molto coraggioso e aveva un’energia incredibile per essere un malato di cancro», dice Visconti: «Non ha mai mostrato paura. Era concentrato sull’album».
Blackstar è un disco libero e sperimentale ispirato a Black Messiah di D’Angelo e To Pimp a Butterfly di Kendrick Lamar. Bowie pranza in studio con la band ogni giorno, ordinando da un locale vicino, chiamato Olive’s. «Si è creata una situazione molto intima», dice il tastierista Jason Lindner, che con i suoi suoni vintage ha contribuito a dare forma all’ambiente sonoro di Blackstar. Il giorno del suo 68esimo compleanno Iman passa a trovarlo in studio portando del sushi di Nobu e la band gli fa una sorpresa registrando una versione di Happy Birthday. In studio c’è anche Muffin, il cane del suo assistente, che «lo faceva sempre sorridere», dice Lindner. Oltre alle sette canzoni di Blackstar e alle tre usate in Lazarus, dice Visconti, ci sono altri cinque brani inediti, tra cui uno in stile Hunky Dory intitolato When Things Go Bad.
Bowie continua a fare chemioterapia, con effetti apparentemente positivi: «Era ottimista, perché aveva visto che stava funzionando. Poi a un tratto, a metà dell’anno scorso hanno detto che stava guarendo. Io ero emozionato, lui mi ha detto: “Non festeggiamo troppo presto. Vediamo come va”. Ha continuato con la chemio, e io pensavo che ce l’avrebbe fatta».
Nei testi di Blackstar però Bowie continua a inserire riferimenti alla mortalità, così come infonde maestosità alla musica, e quindi l’album prende sempre più la forma di un addio. «Credo abbia pensato che se doveva morire questo sarebbe stato un ottimo modo per farlo», dice Visconti, «una grande ultima dichiarazione».
Bowie si rende conto che anche Lazarus ha la stessa funzione, con i suoi temi esistenziali e i riferimenti a tutti i suoi dischi del passato.
Eppure, proprio mentre sta progettando due addii paralleli del “personaggio David Bowie”, sta facendo il possibile per rimanere David Jones. «Non voleva morire», dice van Hove, «non era una lotta contro la morte, era un lotta per la vita. E la vita per lui era la famiglia, sua moglie e sua figlia». Bowie lavora anche a un altro progetto: due straordinari video diretti da Johan Renck. Quello di Blackstar, lungo 10 minuti, è ultraterreno, complesso e criptico, con riferimenti ad Aleister Crowley e all’iconografia di Bowie stesso, di cui il più palese è quello a un astronauta ormai morto da tempo che potrebbe essere Major Tom. Le diverse sezioni del video sono cantate da nuovi personaggi: l’inquietante Button Eyes (interpretato da Bowie stesso), un prete e il carismatico e sfacciato prestigiatore della strofa di mezzo. Tutti i personaggi sono nati da suoi disegni. L’idea di filmare il personaggio di Button Eyes sdraiato a letto è di Renck. Sembra un letto di morte. Un mese dopo aver girato quella scena, a novembre, il cancro si ripresenta. Questa volta i dottori dicono che è terminale. «Si era diffuso in tutto il corpo», dice Visconti, «era incurabile».
Bowie non è in grado di assistere alle prove di Lazarus, ma riesce a essere presente alla prima, sopportando la ressa dei fotografi per l’ultima volta. Gli resta un mese di vita, ma dice a van Hove di voler fare un altro album. «Pensava di avere ancora qualche mese, eravamo molto elettrizzati all’idea di registrare ancora», dice Visconti, «quindi credo che la fine sia arrivata più rapidamente del previsto. Non ho informazioni al riguardo. Deve essere peggiorato in fretta». La notizia della sua morte coglie di sorpresa anche i collaboratori più stretti che erano al corrente della malattia. Altri, come gli attori di Lazarus, non sapevano nemmeno che fosse malato. Nella prima rappresentazione dopo la sua morte, l’attore Michael C. Hall che interpreta Newton, non riesce quasi a cantare, consapevole del significato che quelle canzoni hanno assunto. Renck sapeva della malattia, ma non del peggioramento delle sue condizioni. Come molti altri, oggi rivede con altri occhi la scena finale del video di Lazarus in cui Bowie, indossando un vestito bianco con strisce diagonali simile ai costumi del periodo The Man Who Fell to Earth/ Station to Station, si chiude dentro un armadio di legno che ricorda una bara. Mentre gli ultimi accordi di chitarra vanno in dissolvenza, Bowie chiude la porta e svanisce nell’oscurità. Non era un’idea sua, ma gli è piaciuta e ha deciso di farlo. «Qualcuno sul set ha detto: “Dovresti finire il video sparendo dentro l’armadio”», racconta Renck, «l’ho visto pensarci per un secondo, poi ha fatto un grande sorriso e ha detto: “Sì, così rimarrà il dubbio a tutti, giusto?”».
Questo articolo è tratto da “David Bowie Forever”, il nuovo numero speciale di Rolling Stone dal 20 dicembre in edicola.