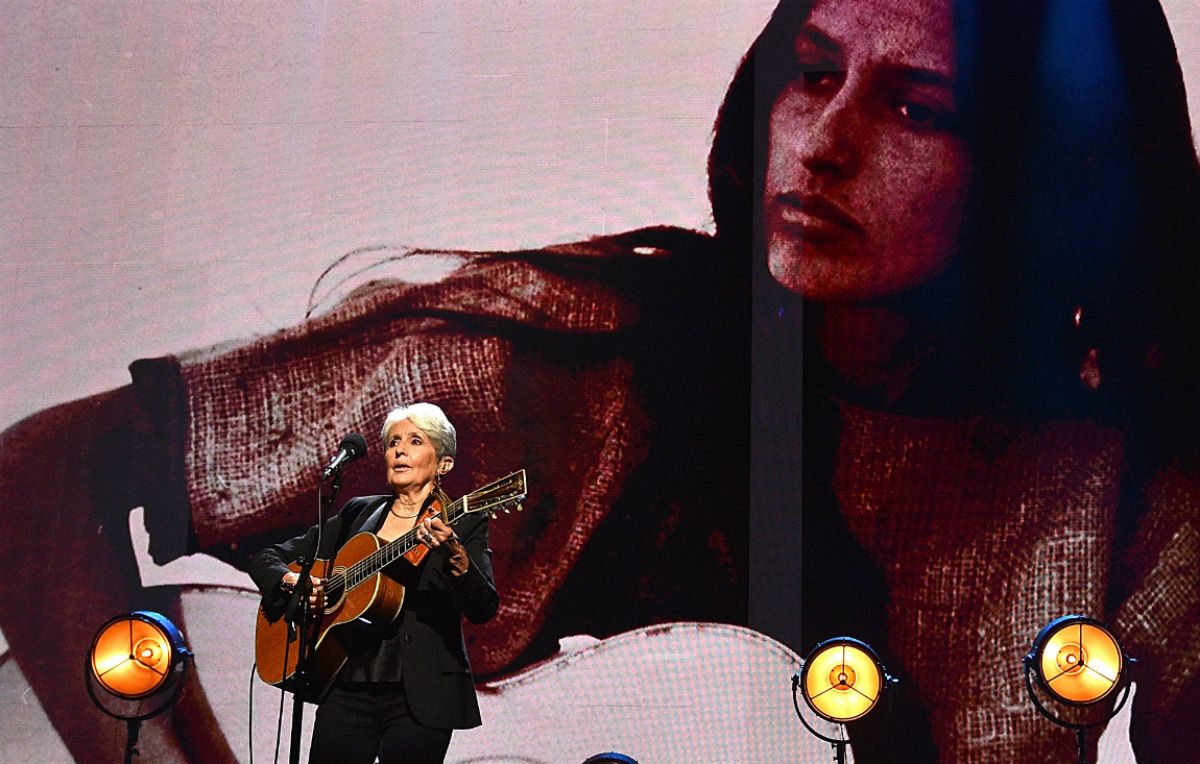Sarà capitato anche voi nei giorni scorsi di vedere una grafica di Pitchfork apparire nella timeline di Instagram. Sono screenshot di vecchie recensioni di dischi, da Born to Die di Lana Del Rey a Stories from the City, Stories from the Sea di PJ Harvey. Compaiono l’autore dell’album, il titolo, la copertina, il voto. Solo che il punteggio inserito nel pallino improvvisamente cambia. E così, lo 0 dato nel 2003 a Liz Phair diventa un 6. Il senno di poi ci rende tutti più saggi.
Diciannove fra le tante recensioni in cui i critici di Pitchfork hanno toppato (o forse no, anche il senno di poi è fallibile) sono state raggruppate in un articolo, questo, in cui si rivalutano alcuni dischi accolti in modo troppo severo, da Musicology di Prince a Vroom Vroom di Charli XCX. E, al contrario, s’abbassano i voti a lavori ora considerati sopravvalutati come Turn On the Bright Lights degli Interpol, uscito in pieno entusiasmo per il revival del post punk, o Miss Anthropocene di Grimes, pubblicato l’anno scorso e già svalutato da 8,2 a 6,9 su 10. Altri voti vengono rettificati, ma non in modo radicale. Così l’8 attributo diciotto anni fa a Room On Fire degli Strokes diventa un 9,2.
Nell’introduzione si spiega che le opinioni cambiano in relazione «al contesto, alla cultura, a chi siamo e a chi eravamo». Molto saggio. Non è un modo di riscrivere la storia, assicura Pitchfork, e difatti i voti d’epoca restano tali nella sezione delle reviews, ma il tentativo di aprire una conversazione sul tema che ha preso il via dalle lamentele di chi fa parte dello staff del sito e ha sempre pensato, chessò, che il 6,4 dato a Discovery dei Daft Punk sia un crimine punibile col carcere duro.
Pitchfork ha ragione e ha torto. Ha ragione perché questa piccola operazione sdrammatizza la pratica di attribuire i voti a un disco, riportandola nella sua giusta dimensione. Un voto e in generale un’opinione espressa su un album non sono giudizi universali, sono la reazione qui e ora di un singolo individuo a quel che ascolta in determinate circostanze. Anche il critico più severo coi propri gusti personali non può che ammettere la precarietà di almeno una parte dei suoi giudizi. A volte lo sono anche dopo sei mesi di ascolti ripetuti, figuriamoci dopo aver sentito un disco tre volte.
Qualunque critico o giornalista musicale ha almeno uno scheletro nell’armadio, vale anche per quelli che sono troppo presuntuosi per ammetterlo. Avere l’armadio pieno di scheletri significa che hai lavorato tanto. Se hai la casa invasa dagli scheletri significa che forse quello non era il tuo lavoro.
«Non si danno i voti alle opere d’arte» dice sdegnato anche l’ultimo cantantello che è appena uscito da Amici e già si considera all’altezza di Bob Dylan. Però i voti possono servire, a patto di non prenderli troppo sul serio. E qui sta il torto di Pitchfork che continua a esprimerli nella rubrica delle recensioni in numeri da 0 a 10 con tanto di cifra decimale, come se davvero si potesse attribuire una misura precisa a un’opera dell’ingegno. La critica non è una scienza esatta e nemmeno tifo da stadio. A meno che non le si dica con un po’ d’ironia, frasi come «eh no, questo non è un disco da 7,4, ma da 7,1» sono da tso. È la sindrome da Alta fedeltà, l’idea che il pop possa essere sistematizzato in classifiche stilate con intransigenza militaresca. La buona notizia è che questa mentalità non fa più danni: la recensione, intesa come giudizio su un album e non come lettura dello stesso, non è granché in salute.
Il processo di riattribuzione dei voti da parte di Pitchfork non sarà elegante, giacché si tratta di una revisione fatta non dagli autori delle recensioni originali, ma è utile. Mi ha fatto venire in mente un’altra operazione compiuta di recente nel campo del giornalismo musicale americano. Quest’ultima non ha a che fare coi voti, ma col giudizio storico su un disco e su come esso cambia al mutare del clima culturale. Mi riferisco a Rolling Stone US che un anno fa ha chiamato a raccolta oltre 300 giornalisti, musicisti anche di primaria importanza, produttori e addetti ai lavori al fine di aggiornare la celebre lista dei 500 album migliori della storia. Un mese fa ha fatto lo stesso con le canzoni.
L’elenco originale dei 500 Greatest Albums of All Time era stato stilato nel 2003 e poi aggiornato nel 2012. È il contenuto più consultato di Rolling Stone negli Stati Uniti. «Nessuna lista è definitiva», scrivono i colleghi americani, «i gusti cambiano, nuovi generi emergono, la storia della musica è soggetta a un processo di riscrittura. Così abbiamo deciso di rifare la lista da capo».
Il cambiamento è radicale: su 500 album, ben 154 non erano presenti nel 2003 e 86 sono usciti negli anni 2000. È un grande sforzo collettivo per aggiornare il canone della musica pop che ha portato a una rivalutazione massiccia di dischi (e canzoni, si veda la lista del mese scorso) di area black. Il simbolo di questo mutamento è l’avvicendamento al numero uno degli album fra Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (2003) e What’s Going On di Marvin Gaye (2020). In quanto alle canzoni, al primo posto ora c’è Respect di Aretha Franklin, al secondo Fight the Power dei Public Enemy, al terzo A Change Is Gonna Come di Sam Cooke, roba da infarto per chi è cresciuto con l’incrollabile certezza che meglio di Dylan e dei Beatles non vi sia nulla al mondo.
Rolling Stone US non ha cambiato voti alle recensioni, e anzi le recensioni sbagliate di questa e di altre testate sono parte integrante della storia della musica rock, si veda ad esempio lo sprezzo con cui furono accolti i Led Zeppelin alla fine degli anni ’60. L’operazione di Rolling somiglia a quella di Pitchfork nella misura in cui invita a considerare le conversazioni sulla musica all’interno dei contesti storici e culturali in cui avvengono.
Non tutti sono d’accordo e dopo la pubblicazione si sono lette sui media italiani frasi come «Rolling Stone choc» o lamentele su come nel nome del politicamente corretto si sta riscrivendo tutto, persino la storia delle canzonette. E però dopo Black Lives Matter e soprattutto dopo la presa di coscienza dell’importanza di chi orienta la conversazione sui consumi culturali, un cambiamento era naturale. Sta avvenendo dentro la musica classica, in cui qualcuno sta mettendo in discussione l’eurocentrismo. Può avvenire anche nel pop.
Il tempo ci dirà se il cambiamento proposto dalla giuria radunata da Rolling Stone è eccessivo e se alla fine ci sono più ragioni nel 6,8 che Pitchfork attribuisce oggi a Random Access Memories dei Daft Punk o nell’8,8 che gli dava otto anni fa. Una cosa è certa: eravamo influenzati da fattori personali e dal clima culturale allora e lo siamo anche oggi. Ci sta: riconoscere che la musica che amiamo è nel bene e nel male un riflesso del mondo in cui viviamo ci rende ascoltatori più consapevoli e adulti.