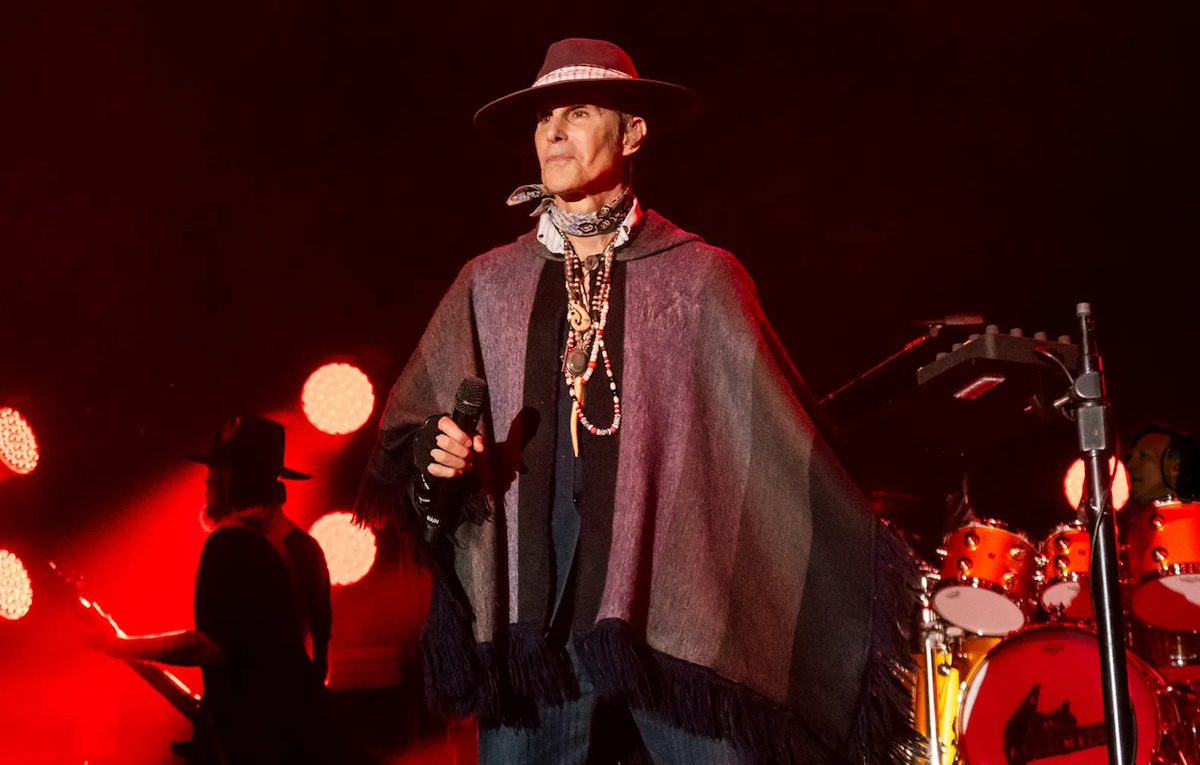«Portami alla luce» ha chiesto alla sua anima gemella. Il portico della casa a East Hampton era già inondato dalle prime luci del mattino. La coppia di artisti più cool di New York l’aveva comprata nel 2009, poco dopo un matrimonio flash in Colorado. All’alba di domenica, accudito da Laurie Anderson, se ne andava a 71 anni Lewis Allan Reed, in arte Lou Reed. Era il 27 ottobre del 2013, dieci anni fa.
Il mondo del rock alternativo si scoprì orfano del suo guru che un tempo ormai lontano, oltre a deliziare i fan con testi scabrosi che solo lui sapeva trasformare in celestiali e suonare in modo inequivocabile la sua 1964 Gretsch Country Gentleman, era un compiaciuto esteta dell’autodistruzione tra abissi di anfetamina, alcol ed eroina. Negli ultimi trent’anni, grazie ai Narcotici e Alcolisti Anonimi, all’incontro con l’ex moglie Sylvia Morales, poi all’unione con la performer di Chicago e ai rigidi insegnamenti del Tai Chi, Lou Reed aveva abbandonato quasi ogni residuo di maledettismo e si era addolcito con i suoi pari grado, pur conservando una facciata bisbetica che di filosofia orientale aveva poco o nulla (sembra che i camerieri di New York che l’hanno servito nel corso degli anni conservino decine di aneddoti poco edificanti).
Dieci anni dopo la sua scomparsa per diverse e annose patologie a carico del fegato, trapiantato senza successo alcuni mesi prima del decesso, il culto loureediano si è istituzionalizzato, soprattutto grazie agli sforzi di Laurie Anderson che ha ereditato – senza alcuna precisa istruzione dal marito – la gigantesca responsabilità di gestire la sua legacy artistica. Prima con vari tributi musicali (Some Kinda Love: Performing the Music of the Velvet Underground dei velevetiani Feelies è l’ultimo in ordine di tempo), mostre ed esibizioni un po’ sparse per il globo, poi con l’Archivio Lou Reed presso la New York Public Library e, l’anno scorso, con il primo volume delle sue bootleg series, intitolato Words & Music, May 1965. In questo mese di ottobre è stata pubblicata anche Lou Reed – Il re di New York di Will Hermes, la prima biografia che ha attinto notizie dall’Archivio del musicista americano.
Il leader indiscusso dei Velvet Underground, poeta studente di Delmore Schwartz e apprendista di Andy Warhol («perché Lou non mi parla più?» è il succo delle domande che negli anni Warhol poneva ai suoi interlocutori dopo l’insolente cacciata dai Velvet), blastatore di giornalisti musicali («Riuscite a immaginare di lavorare per un fottuto anno e ricevere una B+ da uno stronzetto del Village Voice?» inciso su Live: Take No Prisoners), cantore ante litteram della nazione queer, sopravvissuto all’eroina e all’elettroshock, rilevatore borghese di cazzate borghesi, fu “incoronato” re di New York da David Bowie una notte del 1997 al Madison Square Garden mentre il molto più celebre adepto di Reed e dei Velvet festeggiava i suoi 50 anni tra giovani allievi e il padrino di lungo corso.
Non è certo un caso che Hermes abbia intitolato con il nickname coniato da David Bowie la sua massiccia biografia (800 gloriose pagine nella versione italiana con un inserto fotografico che dà un volto anche ad alcune figure meno note ma importanti della timeline sentimentale di Reed) ricca di materiali inediti e di numerose testimonianze raccolte direttamente dall’autore nel corso di questi ultimi anni. Tradotto a quattro mani da Chiara Veltri e Paola De Angelis per Minimum Fax, Lou Reed – Il re di New York è un’indagine appassionata priva di fanatismo, accurata senza pedanteria, dettagliata senza pignoleria. La prosa dell’autore, dalla nascita di Reed al Beth-El Hospital di Brooklyn fino all’epilogo nella casa al mare, è coinvolgente, elettrizzante, a tratti commovente, a volte dolorosa.
Il tomo racconta del re, di tutti i suoi luoghi newyorkesi, da quelli più spartani degli esordi a quelli ultra-borghesi della consacrazione, del suo regno fra “pensiero ed espressione” e della pletora di personaggi che l’hanno sfiorato, amato, popolato o abbandonato, compresi i primi grandi amori Shelley Albin (che dovrebbe essere, seppur con i suoi occhi castani, la protagonista inaspettata di Pale Blue Eyes) e Bettye Kronstad. È un grande affresco collettivo a stelle e strisce dal forte spirito queer, una lunga e affascinante walk on the wild side.
L’investitura di David Bowie nei confronti di Lou Reed, oltre a suggellare un chiaro percorso di influenze artistiche, tracciava una riappacificazione pubblica fra i due dopo che il loro noto rapporto si era bruscamente interrotto quando il cantante inglese aveva preteso dal suo protégé un approccio più sobrio alla vita. Correva l’anno 1979. Reed aveva The Bells da promuovere, registrato con tecnologia binaurale, come il disco dal vivo dell’anno prima Live: Take No Prisoners. Il cantante di Long Island, accasato da pochissimo con la futura sposa Sylvia Morales dopo la relazione intensa ma dolente con la compianta transgender Rachel Humphreys (inghiottita dall’Aids a gennaio 1990, senza una lapide), era stanco delle sue maschere grottesche ma era molto lontano dalla libertà espressiva di chi è senza maschere o, quanto meno, le sa gestire.
Per sdebitarsi dei suoi influssi velvetiani, David Bowie gli aveva regalato il successo e una carriera discografica solista (che non era per nulla decollata con l’esordio) facendogli indossare quella del fantasma (vedi Transformer, 1972, da lui prodotto). Bowie, che di maschere se ne intendeva, e ne aveva anche compreso il potere distruttivo, si era ritrovato a Berlino, dando vita all’ennesimo successo di pubblico e critica ma soprattutto trascendendo la necessità tossica e tipicamente rock di incarnare un personaggio per fare musica.
Lou Reed stava decisamente peggio. Era diventato un fumetto stile Frankenstein sulla cover del primo numero della fanzine Punk. Rappresentava, al tempo stesso, sia Jim che Caroline, la coppia devastata di Berlin. Sulla copertina di un numero del gay magazine Mandate del 1977 il suo “lancio” era ancora “Lou Reed: il principe delle tenebre”. D’altronde aveva finto per diverso tempo di iniettarsi eroina sul palco a scopo “promozionale” con Lester Bangs a fare da Virgilio sulle pagine di Creem. Che cosa ci si poteva aspettare? La title track The Bells, una delle canzoni più lugubri e al tempo stesso magnifiche della storia del rock, era forse la perfetta soundtrack di questo pozzo senza fondo.
“Il tour promozionale europeo, che partì in primavera, fu una schifezza”, scrive Hermes. “In Germania, una donna salì sul palco e Reed, spaventato e apparentemente ubriaco, la trascinò giù per i capelli per poi venire arrestato nei tafferugli e passare il resto della notte in carcere. Una settimana dopo, suonò all’Hammersmith Odeon di Londra e Bowie andò a vederlo. Reed era felicissimo e lusingato. Dopo il concerto i due e il loro entourage andarono in un club, dove Reed si mise in adorazione del suo amico, soffocandolo di baci. Scorrevano fiumi di sakè e Dom Pérignon. A un certo punto Reed, ubriaco, propose a Bowie di produrre il suo album successivo”.
Era una doppia ammissione di fragilità: come uomo tossicodipendente e come artista col cappello in mano. Al Bottom Line, Reed aveva 400 spettatori mentre Bowie poteva contare su migliaia di fan che continuavano a seguirlo con dedizione, uscita dopo uscita. «Certo, posso prendere in considerazione l’idea di produrre il tuo prossimo album, ma dovresti darti una ripulita». Quando l’allievo umilia il maestro gli effetti possono essere devastanti.
“In un batter d’occhi, Reed allungò la mano superando Sylvia e diede un forte schiaffo in faccia a Bowie con il dorso della mano destra, poi lo schiaffeggiò di nuovo, stavolta con il palmo, lo afferrò per il collo e lo tirò dall’altro lato del tavolo”. Chuck Hammer che avrebbe poi suonato per i dischi di entrambi nel 1980, disse che le guardie del corpo di Bowie intervennero e fecero sgombrare la sala. «Ricordo che ci spinsero su per le scale per farci uscire dal ristorante». «Non permetterti più di dirmi una cosa del genere», proferì con un sibilo velenoso e ubriaco Reed. Poco dopo, portato via dal suo entourage, Reed collassò in albergo. Forse fu proprio quello il momento di svolta del romanzo loureediano.
Sylvia, divenuta nel 1980 la signora Reed, cominciò a mettere ordine in un’esistenza disordinata e pian piano aiutò e incoraggiò il marito a creare le basi per la vita adulta e a favorire un indotto commerciale che molto ebbe a che fare con gli introiti pubblicitari. C’è chi è convinto che Sylvia Reed gli salvò in pratica la vita.
In una delle sue ultima apparizioni pubbliche, nel giugno del 2013, al Festival internazionale della creatività di Cannes, Lou Reed disse profeticamente: «In un mondo di download, gli unici che pagano siete voi», rivolgendosi al mondo dell’advertising. In quei giorni autunnali del 2013 la residenza part-time di Anderson-Reed era meta di pellegrinaggio di pochi intimi che andavano a salutare l’amico e collega di lungo corso. Il fegato trapiantato nel giugno dello stesso anno in una clinica specializzata di Cleveland non si era dimostrato all’altezza (quell’organo era «tutt’altro che perfetto» riferì senza giri di parole il chirurgo prima dell’operazione). Reed si dilaniava perché temeva di essere “cancellato” dalla storia come se l’antisemitismo che aveva portato la sua famiglia a cambiare il cognome (Reed deriva da Rabinowitz) si fosse risvegliato per spedire la sua arte nell’oblio. Era un guerriero, ma si sentiva un eterno sconfitto.
Può sembrare paradossale per uno degli artisti più citati e influenti della sua generazione, ormai – dall’album New York (1989) in avanti – osannato da pubblico e critica come non gli era mai successo prima (l’enorme fortuna postuma dei Velvet Underground, band di nicchia quando era in vita, è sempre stato un boccone amaro da digerire per il suo creatore). Non gli sovveniva in quegli ultimi mesi di aver fondato il primo gruppo rock che metteva insieme un’avanguardia artistica, letteraria e sonora con feedback, ballate ipnotiche e bordoni. Di aver ideato e scritto concept album memorabili come Berlin del 1973, Songs for Drella con John Cale sulla figura del loro maestro Andy Warhol e, proprio parlando di fine vita, uno degli album più importanti sull’elaborazione del lutto e sulla morte (Magic and Loss, 1992). Di aver scritto canzoni come Sweet Jane, Satellite of Love, Perfect Day, Coney Island Baby, Street Hassle e All Tomorrow’s Parties. Di aver pubblicato Metal Machine Music, lo schiaffo più grande dato all’industria discografica. Ma soprattutto di aver trasfigurato in senso artistico l’esperienza della terapia elettroconvulsivante (TEC) – all’epoca un protocollo standard – che i medici gli somministrano nel 1960 per una diagnosi di schizofrenia con tendenze paranoiche. Per tutta la vita quella sarebbe stata la “cicatrice” sul campo di battaglia del guerriero Reed.
La teoria della madre frigorifero allora era in voga e secondo gli psichiatri era la ragione profonda dei comportamenti disfunzionali del giovane Lou. Per tutta la vita Reed difese la madre non attaccandola. Mentre fra il serio e il faceto, tipico del suo modo di essere, incolpò in più occasioni il padre di comportamenti violenti e omofobi nei suoi confronti, anche negli ultimi giorni di vita, come ha testimoniato l’amico Julian Schnabel. Sospetti, ricordi, allusioni. Sempre confutati dalla sorella Bunny, psicologa di professione e forse “colpevole”, dal suo punto di vista, di un complesso di Elettra in difesa del padre. Traumi familiari. Ci può essere nulla di così mostruosamente banale? Quali immaginari e quali reali? “Who am I?”, si chiedeva retoricamente in una bellissima canzone autobiografica contenuta in The Raven, dedicato a Edgar Allan Poe. Sigmund Freud in persona non avrebbe saputo rispondere. E forse, uno come Lou, che giocava molto con la sua inafferrabile identità, non gliel’avrebbe nemmeno chiesto.
«Ho passato del tempo con un sacco di artisti verso la fine della loro vita. Non ho mai conosciuto nessuno che fosse tanto infuriato perché stava per morire, che volesse vivere così tanto», ricordò Hal Willner, una delle figure più importanti della maturità artistica dell’ex Velvet, iniziata col capolavoro Ecstasy e conclusa con la controversa collaborazione tra Reed e i Metallica Lulu, di cui si salva Junior Dad – l’unico pezzo in carriera di una durata simile a quella del brano simbolo dell’estetica furente e minimalista dei Velvet: Sister Ray – per certi versi il testamento artistico del cantante.
Forse si sorprenderebbe di quanto non è stato affatto dimenticato. Tutto il contrario. E che il suo è stato il miglior vanishing act che un uomo che ha “camminato nel fuoco” potesse eseguire.