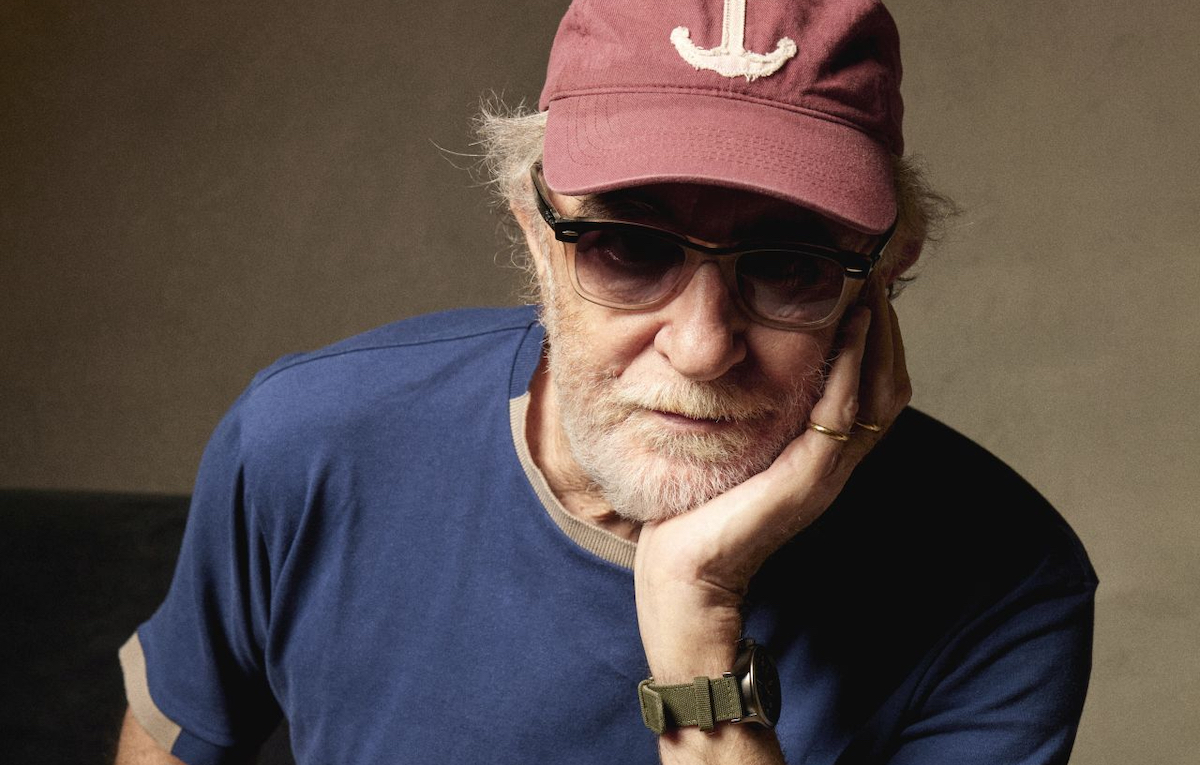Come ha dimostrato Francesco Guccini, l’eredità che lascia un artista radicato nella nostra cultura può essere di due tipi, una tecnica – relativa alla scrittura, alle canzoni in sé, alle sonorità – e una pertinente al mood, a ciò che ha rappresentato nella carriera, al modo in cui si è approcciato alla musica. Ecco: i 70 anni di Francesco De Gregori corrispondono, più o meno, a 50 passati fra dischi e concerti, ergo è chiaro come uno che ha cominciato ad avere i riflettori addosso così presto e che ha attraversato da protagonista la nostra musica sia stato capace di sopravvivere alla grande ai cambiamenti di opinione e costume. Per questo c’è chi può aver preso a modello i suoi pezzi e chi direttamente lui e la coerenza che ha messo in tutto ciò.
Inutile nascondersi: il primo aspetto è quello che dà più soddisfazioni, a oggi. Anche perché il bello di tracciare una mappa dei nomi che hanno ricavato lezioni ascoltando le sue canzoni, infatti, è spingersi fino a personaggi – almeno sulla carta – insospettabili. Com’è tipico dei padri della patria, di quelli che ritornano ovunque, anche dove non te l’aspetti. Per dire: il Vasco Rossi degli esordi, quello di fine anni ’70 col Fegato, fegato spappolato, prima di scoprire le chitarre elettriche era un cantautore come andava per la maggiore, e non ha mai nascosto di essersi ispirato proprio a De Gregori, allora superstar all’apice della fama. E se Asilo Republic del Blasco, dal suo battesimo “spericolato” Colpa d’Alfredo (1980), è un omaggio un po’ in sordina al tour di Banana Republic (1978) di uno dei suoi maestri e di Dalla, quando nel 1995 avrebbe fatto una cover iconica, quasi alt rock, di Generale sarebbe stato tutto più evidente.
Per il resto, sembriamo i soliti stronzi a dirlo, ma i lavori del cantautore romano che più hanno lasciato il segno sono i primi, usciti fra il 1974 al 1978. Dopo, ancora episodi scolpiti nell’identità condivisa, da Viva l’Italia a Titanic, La donna cannone e persino La leva calcistica della classe ’68; ma è stato come se la sua musica avesse perso la dirompenza, smettendo di figliare e diventando un po’ canone a sé, inseguendo Dylan e rendendosi al contempo meno attuale. Può averne raccolto l’eco il pop-rock generalista (Ligabue su tutti, ma anche la stessa Elisa), però è un lascito vago.
Al contrario, se torniamo a un disco come quello “della pecora” (Francesco De Gregori del 1974) ci troviamo le radici di gran parte dei cantautori indipendenti: fra arrangiamenti ruvidi e scarni, testi ermetici e a tratti incomprensibili e nichilismo, passano – ammettendolo sempre con orgoglio, loro – da Federico Fiumani a Vasco Brondi (di cui De Gregori è grande appassionato, se si esclude che lo definisce «rock estremo»). E parliamo, oltretutto, di un freak rispetto al resto del curriculum, di un qualcosa di volutamente ostico e complesso. Poco più in là, infatti, c’è già l’altro aspetto prezioso del periodo degli esordi, cioè la capacità di muoversi fra la canzone politica di stagione (Pablo, Le storie di ieri, la stessa Generale) e una narrazione intima più trasversale alle epoche (i vezzeggiativi di Buonanotte fiorellino).
E proprio Rimmel – la canzone prima ancora che il disco – in questo senso ha rappresentato una rivoluzione nella canzone d’amore, abbattendo la retorica delle grandi narrazioni e riducendole alle piccole cose, alle minuzie (il “collo di pelliccia”, le “labbra” per “un indirizzo nuovo”), puntini prevertiani da unire e tutt’altro che banali o retorici, poi sublimati con Atlantide (con quel “ditele che la perdono per averla tradita” che è un cortocircuito), poesiole intime e dagli occhi lucidi come Natale e Renoir e persino la preghiera di Santa Lucia. Su queste coordinate, la nostra musica è andata avanti trent’anni, prima addirittura di ricollegarsi in maniera del tutto esplicita alla radice col folk levigato dei vari Brunori Sas, Dente e dell’it-pop dei dettagli e dell’iper-malinconia di oggi. Anche se sarebbe riduttivo ascriverne l’influenza solo a quel contesto: ciò che rimane dei suoi testi sono l’attenzione per la parola, le metafore, i riferimenti storici e al tempo stesso la dimensione popolare, la capacità comunicativa. E quindi ecco spiegato Vasco Rossi, ma anche Caparezza che al live celebrativo dei quarant’anni di Rimmel tributa Bufalo Bill. Per non parlare, poi, dell’importanza di Banana Republic, simbolo della nascita del concerto da stadio moderno, a testimonianza di come De Gregori non sia stato solo un cantautore di platino ma una star che ha cambiato il pop italiano.
E però, in questo senso, è da sempre anche un simbolo di coerenza, che nel music business significa scelte impopolari, passare per ruvido e ostinato, mai accomodante neanche con la propria musica e comunque non “simpatico”. Non tanto per l’aver gestito in maniera naïf e antidivistica l’isteria degli esordi (erano comunque gli anni ’70), né per il non erigersi a santone, anzi concedendosi a davvero tanti duetti e collaborazioni indice di un atteggiamento tutt’altro che elitario. Semmai, il punto è che lui resta quello di un Bufalo Bill con gli arrangiamenti scarni per “autopunirsi” del successo commerciale di Rimmel; quello del ritiro dopo il “processo” al Palalido; quello delle incomprensioni coi colleghi, tra cui la famosa causa a Gianni Morandi; e quello che negli anni ’80, quando le mode cambiavano e gli amici disertavano come cantautori (Dalla, Venditti) ha rifiutato il compromesso, attraversando il deserto con dischi storti e démodé nell’essere politici – e fisiologicamente poco venduti – come Terra di nessuno. E dire che intorno a lui non c’erano scudi come il culto giovanilistico di Guccini o l’aura di santità di De André, ma solo concerti à la Neverending Tour e un pubblico vario, a riscoprire la natura operaia mai rinnegata del mestiere.
Tradotto: 70 anni così lasciano un’eredità di mood e di pensiero difficile da raccogliere per i colleghi, e che non a caso è rimasta solo sua. Più facile da imitare su un palco che sotto, quindi. Sicuramente meno rischioso. E allora auguri: deve essere bello avere figli sparsi per la musica italiana, se non sa altro per vederli crescere compiendo scelte di vita diverse dalla propria.