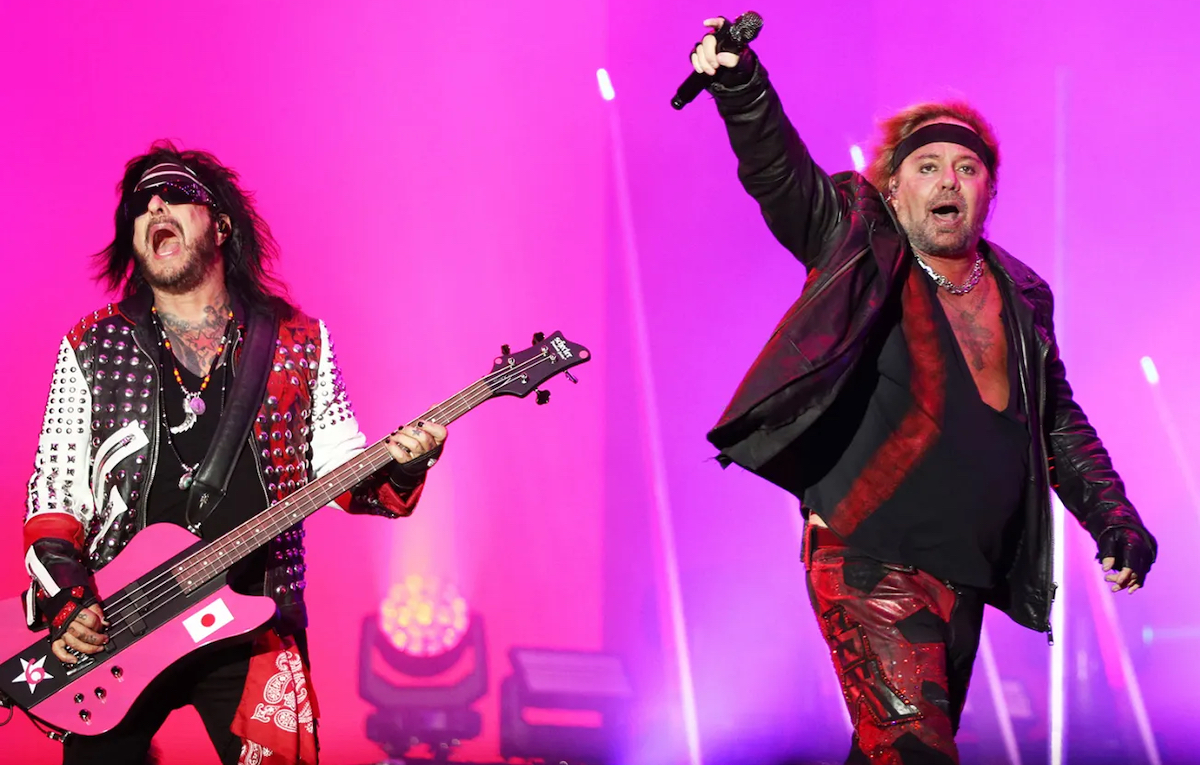L’8 marzo non si festeggia solo la Giornata internazionale della donna, ma anche una ricorrenza che è apparentemente agli antipodi. È l’anniversario di The Downward Spiral dei Nine Inch Nails. Uscito nel 1994, è la storia di un uomo che gradualmente si aliena dall’umanità fino ad autodistruggersi in una spirale di misantropia, arrivando al suicidio. Criticato all’epoca per il verso di Closer “I want to fuck you like an animal”, Trent Reznor non è mai stato assolutorio nei confronti del protagonista dell’album. Il disco è anzi uno spaccato di mascolinità tossica e racconta come la mania della dominazione non porti ad altro che nefandezze e morte.
The Downward Spiral non è solo questo, è un’opera più complessa, un disco epocale, rivoluzionario, il picco (Chris Vrenna a parte) del concetto di one man band e definitivo sdoganamento dell’industrial. Reznor fa tesoro della passione per la melodia data dai suoi trascorsi new romantic/synth pop con gli Exotic Birds (che aprivano i concerti di Culture Club ed Eurythmics) ibridandola con il noise, il metal, l’avanguardia sperimentale e per l’appunto l’industrial rock, con un occhio di riguardo alla trasversalità di Prince e dei Depeche Mode dei ’90 (non a caso Flood, corresponsabile del successo di Violator, è il co-produttore). The Downward Spiral è questo calderone di influenze, esce in un periodo di grande fermento musicale ed è un concept, e in questo Reznor torna indietro al periodo del progressive rock.
Sulla carta la storia non è nulla di nuovo, anzi, a pensarci viene da sbadigliare, associandola ai luoghi comuni del rock (i due dischi che ispirano il lavoro sono Low di Bowie e The Wall dei Pink Floyd, che in qualche modo avevano già detto tutto). Eppure, miracolosamente, The Downward Spiral riesce a toccare nuove corde, quelle sotto la facciata (come ben espresso dalla copertina di Russell Mills, una superficie delicata che nasconde ferite aperte simboleggiate dai materiali, ovvero sangue, insetti morti, garze chirurgiche), a creare un paesaggio sonoro inedito e a rendere credibili anche testi all’apparenza esageratamente iperrealisti. È come se, in uno slancio cyberpunk, Reznor si fosse fatto scrivere più che scrivere egli stesso, lasciando a una mano “medianica” la responsabilità di cucire l’album limitandosi ad essere una persona esterna che cerca di “controllarlo”.
Il discorso del controllo è centrale e si fonda sull’idea che ogni controllo porti alla rovina, a partire dai vizi che controllano l’individuo e quest’ultimo che autocontrollandosi per difesa si spinge sempre più verso il polo opposto, in una riflessione su chi controlla chi, se il carnefice o la vittima. La mano medianica potrebbe essere quella di Sharon Tate, una delle vittime dell’orribile strage della congrega di Charles Manson del 1969, una presenza che entra negli apparecchi elettronici manipolandoli e raccontando la sua storia.
Per realizzare pienamente i suoi incubi sonori, Reznor decide infatti di affittare la casa di Los Angeles dove ha avuto luogo la strage (la famigerata villa al numero 10050 di Cielo Drive) e piazzarci il suo studio di registrazione (lo testerà prima con l’EP Broken, ma è solo con The Downward che parte a pieni giri). È una scelta macabra ma nello stesso tempo funzionale a far uscire i fantasmi di cui il disco tratta e imprimerli nei solchi dell’album, come lavorare costantemente con di fronte la brutalità e la violenza gratuita del sogno americano. All’inizio affascinato dal fatto di cronaca, dalle contraddizioni della società americana e dal mistero negativo della faccenda Manson, dopo un incontro con la sorella di Tate il musicista prende coscienza che la sua scelta può far sembrare che avallari il brutale omicidio. Scoppia in lacrime e da quel momento in poi dà probabilmente una direzione diversa al lavoro.
Lavoro che è un quadro della situazione psicologica di Reznor, in preda alla depressione e all’abuso di droghe e sesso, che trova nel suo piccolo mondo osceno (e in un certo senso puerile) una paradossale comfort zone tanto da rifiutare di curarsi col Prozac (che all’epoca andava forte tra determinati artisti martoriati, ricordiamo Bernard Sumner dei New Order che ne tesseva entusiasta le lodi). La cosa non può reggere e infatti alla fine del disco Trent piazza uno dei brani più ispirati di tutto il canzoniere americano, quella Hurt che è un ambiguo manifesto di sopravvivenza tra le macerie. Anche qui The Wall arriva in aiuto, il finale di Outside the Wall era un messaggio di speranza, ma segnalava anche il rischio di ricominciare tutto da capo (il disco dei Pink Floyd è in sostanza un loop: se lo metti in repeat la fine combacia con l’inizio). È così anche Hurt, dove il cantante sembra tanto teso a salvarsi quanto a rischiare di ricadere da un momento all’altro negli abissi dell’autocompiacimento del male. La canzone sta in piedi anche chitarra e voce, come ha dimostrato la versione di Johnny Cash che l’ha consegnata ai classici da pelle d’oca.
Ma The Downward Spiral è molto di più, è puro sound design dall’inizio alla fine. È probabilmente il tratto più innovativo e pioneristico, che ha fatto scuola. A parte concentrarsi sulla distorsione digitale in tutte le sue forme e declinata per ogni strumento, Reznor affina la tecnica del campionamento digitale unito all’improvvisazione, registrando lunghe session di chitarra e di batteria da campionare, manipolare col computer e inserire nei pezzi all’occorrenza. La presenza in studio di Adrian Belew e la sua maestria nell’improvvisazione con chitarre “aliene” (di cui abbiamo un assaggio nell’iniziale Mr. Self Distruct) aiuta Reznor ad approcciarsi allo strumento in maniera inedita, lavorando sulle dissonanze, sui detuning e su texture maggiormente ambient rispetto al passato (sarà talmente abbagliato da Belew da proporgli di far parte della live band, ma sarà osteggiato dagli altri musicisti e non se ne farà nulla).
Non mancano campionamenti da film e brani altrui usati in maniera poco ortodossa che ancora sono materia di ricerca tra in fan (si va da L’uomo che fuggì dal futuro a Non aprite quella porta, da Iggy Pop agli Art of Noise). C’è anche il plagio spiattellato senza ritegno di A Warm Place, praticamente Crystal Japan di Bowie. Altro aspetto importante è la struttura dei pezzi, che anche qui sembrano un lascito del prog: misure ritmiche non convenzionali (vedi March of the Pigs), aperture e chiusure che fanno pensare a vere e proprie suite più che a canzoni.
The Downward Spiral già nelle intenzioni profumava di classico. A causa delle tematiche molti addetti ai lavori pensavano che sarebbe stato un suicidio commerciale e forse anche nella testa di Reznor sarebbe potuto essere l’ultimo disco dei Nine Inch Nails. Invece, incredibilmente, l’album arriva secondo negli Stati Uniti e ottiene un grande successo in tutto il mondo, spiazzando il suo stesso autore che era convinto del contrario.
Ma cosa rimane oggi di questo grande capovolgimento di fronte nelle classifiche? Cosa resta di questa epopea autolesionista di successo? Se è vero che di The Downward Spiral non sentiamo molto parlare dalle giovani generazioni che sembrano sempre più “inNirvanate”, è vero anche che degli aspetti del disco hanno poi forgiato quello che è il pop moderno. Innanzitutto il lato “depressivo” che permea e ha permeato un determinato tipo di trap (XXXTentacion non era estraneo all’ascolto di The Downward) e che allora nel rap non era più di tanto accettato (nel disco c’è Big Man with a Gun che è una presa per il culo dei gangsta machisti). E poi il disco ha fatto capire che dietro a qualcosa di “estremo” c’è sempre un discorso accessibile e che è il vero nocciolo della questione (dai Beatles agli Einstürzende Neubauten il passo è breve), soprattutto se indorato con la pillola del sound design, tanto che oggi in effetti ascoltiamo dischi prodotti a prova di perizia acustica che veicolano messaggi discutibili e arrivano dove devono arrivare (vogliamo scomodare Kayne West?). Terzo, ma non ultimo aspetto, l’album ha ancora un largo impatto sulla scena alternativa e post industrial, basti pensare al compianto Soft Moon che di base aveva preso il testimone dell’esperienza Downward Spiral rinnovandola.
L’idea che il discodel 1994 sia idealmente composto dal fantasma di Sharon Tate fa venire in mente un aneddoto. Tori Amos e Trent Reznor in quel periodo hanno una relazione, lei lo va a trovare a Cielo Drive e nota che è sull’orlo dell’anoressia. Decide di cucinargli un pollo arrosto, ma non si ricorda come si fa e lo brucia. Chiama la madre e le chiede come sia possibile che abbia dimenticato il suo piatto forte. La madre risponde che da quando Abigail Folger, ereditiera del caffè Folgers, è morta in quella casa per mano dei mansoniani, c’è stata una maledizione contro qualsiasi cosa venga cucinata. Ma non contro quello che viene suonato, a quanto pare: una protezione speciale da parte di Sharon Tate che ancora ci fa dire, mentre ascoltiamo Hurt, “sotto i segni del tempo / svaniscono i sentimenti / Tu sei un’altra persona / e io sono ancora qui”.