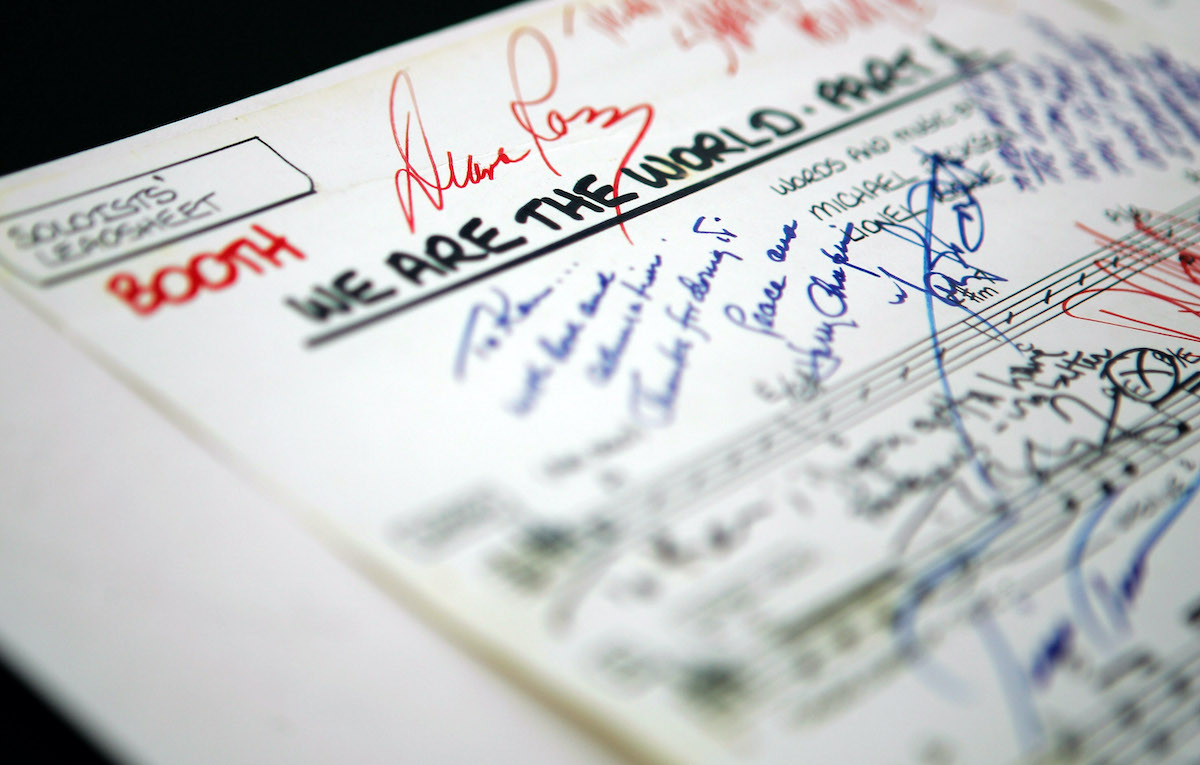Non sono in molti a ricordarlo, ma quest’anno non ricorrono solo i primi dieci anni dalla morte di Michael Jackson, ma anche quelli dalla serie di concerti che avrebbero dovuto riportarlo a suonare dal vivo dopo un’assenza che, oggi, fa forse ancora più impressione di allora. Oggi che il concetto di evento è venuto drasticamente meno (massimo ogni due anni le line up dei concerti sono composte dagli stessi nomi), un uomo che spendeva quattro milioni di dollari per uno spot su ITV London per dire di essere tornato è qualcosa che solo chi ha vissuto l’epopea di MJ negli anni ottanta può comprendere appieno.
Com’era spesso accaduto nel caso di un nuovo progetto di Jackson, nulla di quel tour aveva a che fare con la normalità: un’assenza discografica lunga otto anni, dieci date annunciate che poi, a sua insaputa, trasformarono in cinquanta, l’O2 Arena affittata per un annuncio di dieci minuti e un catalogo le cui vendite aumentarono anche del quattrocento per cento nel giro di poche ore. Io ero uno dei pochi che avrebbe assistito al debutto di This Is It. Avevo già visto Michael dal vivo, ma l’ultima volta risaliva addirittura al 1997, col cadavere di Kurt Cobain ancora caldo, l’eco delle prime infamanti accuse ancora presente e, forse anche per quello, un San Siro pieno per metà. Dodici anni dopo, lo scenario era più o meno lo stesso, con la differenza che trecentocinquanta biglietti erano stati polverizzati in mezz’ora e, soprattutto, che Michael sembrava spinto a quella follia più dai debiti e dai nuovi processi di pochi anni prima che da uno stato di forma adeguato ad un tour de force di quella portata. “Morirà prima”, mi dicevano tutti quelli che conoscevo. E infatti morì.
Benché la mia parte irrazionale pensi ancora all’influenza di quelle gufate sulla sua dipartita, era evidente a chiunque che la vita di quel cinquantenne, i cui tratti somatici erano andati cambiando a tal punto da renderlo un alieno, non avrebbe potuto andare avanti ancora per molto. Quello che rimaneva, che rimane e che, in qualche modo, aveva caratterizzato tutta la carriera del più grande performer di tutti i tempi, era semplicemente un grande senso di pena, di pietas per un uomo che aveva sì avuto tutto quello che si può immaginare da una carriera nel music businesses, ma che in fin dei conti era morto così come aveva passato tutta la vita: in solitudine. Un’esistenza fatta di sacrifici, di rinunce, cominciata a cinque anni con un padre che lo utilizzava per procacciare il miglior contratto possibile con la Motown per lui e per i suoi fratelli infinitamente meno dotati e conclusasi con un’iniezione che avrebbe dovuto fargli dimenticare per l’ennesima volta il peso di una vita da protagonista di un film di David Lynch.

Eppure, sul finire degli anni settanta, qualsiasi produttore black interrogato su quale fosse l’artista con cui avrebbe voluto lavorare, avrebbe fatto solo un solo nome: quello di un ragazzo di meno di vent’anni che ballava come fosse una sorta di esperimento genetico atto a mettere insieme le parti migliori di James Brown e Fred Astaire. Per sua fortuna se l’accaparrò Quincy Jones che, se da una parte trasformò l’artista acerbo in superstar, dall’altra aiutò il bambino mai sbocciato a crescere con l’affetto che gli era sempre mancato, sostenendo entrambe le sue anime. Sì perché Michael, in fondo, era sempre stato scisso in due parti: gli anni di sacrifici e maltrattamenti, uniti al grande successo ottenuto, avevano fatto sorgere in lui sentimenti contrastanti, fatti di ambizioni sfrenate unite ad una sacrosanta voglia di potersi godere la propria età come gli altri ragazzi. Tutte dinamiche in grado di segnare in modo indelebile la psiche di Jackson, che pareva non riuscire mai a godersi il momento senza pensare ad un nuovo traguardo da raggiungere.
Emblematico, in questo senso, il pianto inconsolabile la sera della consegna del Grammy per Off The Wall, il primo di una lunga serie della sua carriera: quelle lacrime non nascondevano commozione, ma rabbia e frustrazione dettate dalla convinzione che un solo premio e venticinque milioni di copie non rispecchiassero il valore del suo lavoro. Delusione che, per altro, l’artista avrebbe riversato nel lavoro successivo, quel Thriller che nella sua mente avrebbe dovuto segnare per sempre l’immaginario collettivo e superare qualsiasi altro lavoro presente, passato e futuro. Past, Present And Future, come avrebbe rimarcato enfaticamente anche il titolo del suo primo Greatest Hits.
Cosa rimane dunque oggi dell’esaltante e, allo stesso tempo, ultra tragica epopea di Jackson? I dubbi circa l’uomo, è ormai appurato, rimarranno per sempre, ma dopo dieci anni senza di lui e a pochi mesi dalla riattualizzazione degli scandali per i quali anche molti di quelli che oggi lo ammirano si vergognano di ammetterlo, è forse più giusto spostare nuovamente l’attenzione sull’unica cosa che conta: l’immenso talento di cui era dotato e l’importanza della sua figura per la musica nera di ogni tempo. Siamo infatti stati così abituati a sentir parlare di lui in termini di King Of Pop, che spesso ci si dimentica del suo fondamentale contributo pre Thriller. Ecco perché forse, per tributargli il migliore degli omaggi, almeno oggi sarebbe bello ricordarlo come The King Of RnB.