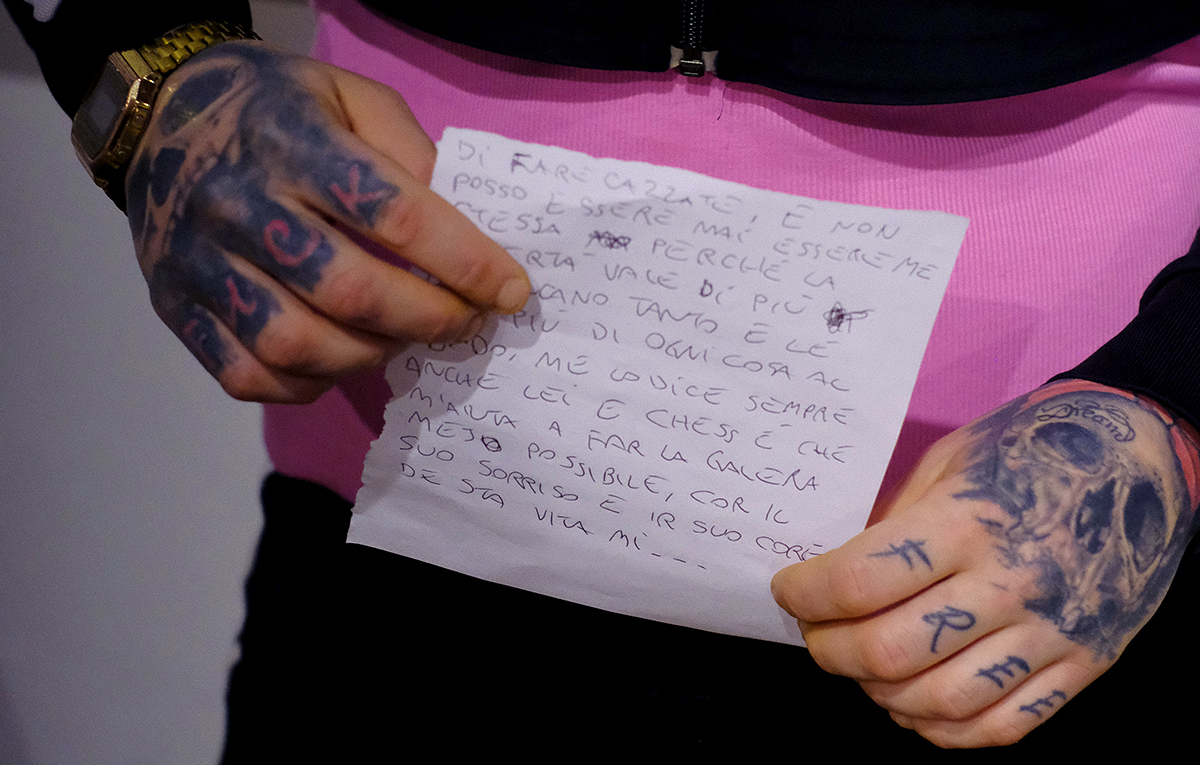Ci sono dubbi su qualsiasi cosa, dalla politica alla religione a come si cucina la pasta. Su una cosa però non ce ne sono: il più grande bassista del mondo è stato Jaco Pastorius. Chiunque venga interrogato sull’argomento tira fuori il suo nome, da Flavio Paulin, ex cantante e bassista dei Cugini di Campagna a Red Canzian dei Pooh, che dopo aver visto Pastorius dal vivo si fece un fretless e lo introdusse nel pop italiano, fino a Pino Palladino e Robert Trujillo dei Metallica, che non a caso ci ha messo quattro anni a produrre Jaco, il documentario sulla sua vita.
Di solito gli si riconosce i meriti di avere innovato lo strumento e perfezionato tecniche già esistenti (come l’uso di armonici artificiali o del muting, ma soprattutto del fretless, il basso elettrico senza tasti che ricordiamo fu inventato da Bill Wyman dei Rolling Stones e non da lui). Pochi si concentrano invece sugli aspetti visionari del suo essere compositore, sul fatto che era talmente avanti da voler smaterializzare la musica in puro rumore, per addizione pittorica. Riempire i vuoti finché non si sente altro che caos, ma un caos armonico.
È evidente nel disco Holiday for Pans, che quest’anno ha compiuto 30 anni. Uscito postumo per un’etichetta giapponese e registrato nel 1982, sarebbe dovuto essere il terzo disco di Pastorius. Venne invece rifiutato dalla casa discografica perché troppo esoterico. Non ce ne stupiamo, il disco è una specie di viaggio nella mente di un individuo che è andato oltre le barriere del reale: psichedelico come Barrett, autistico come Miles Davis, veloce come un sequencer (tanto che la sua influenza si allargherà anche alla IDM, in particolare con Squarepusher), soprattutto in fissa per l’uso delle steel drum suonate dal suo pupillo Othello Molineaux in maniera ossessiva, ottenendo un effetto simile alla colonna sonora di Alice nel Paese delle meraviglie della Disney buttata in un fustino di MDMA.
I discografici inorriditi decisero di sostituirlo con una compilation di cover eseguite live dal titolo Invitation, che sminuisce la caratura di un vero e proprio genio. Frustrato e non certo presente a se stesso per via del consumo smodato di droghe e alcol e per una personalità sempre più scissa tanto da trovarsi a vivere come un senzatetto, Pastorius non poteva scendere a più miti consigli, ma solo peggiorare nei suoi comportamenti imprevedibili e borderline. Da artista libero quale era, le gabbie del jazz gli stavano strette e anzi rappresentavano un problema esistenziale, col dramma di dover continuamente affrontare un pubblico che voleva sentire il funambolo, ma non quello che aveva veramente da dire.
Esemplari sono i suoi assolo basati sull’uso del delay usato come rudimentale ma efficace loop station e soprattutto l’utilizzo del distorsore combinato con una modulazione di chorus molesta, il cui risultato è a tutti gli effetti noise ante litteram. Il suo tentativo di superare Hendrix nella speculare versione da basso elettrico è evidente, ma la sua passione per i feedback straborda in territori harsh non ancora esplorati nel jazz, e che non lasciano scampo. Il pubblico generalmente, a queste sue impennate, reagisce con violenza e in alcune occasioni Jaco si paralizza in posizione fetale sul palco, riuscendo a riconquistare tutti tornando nella comfort zone del jazz-rock. Celebri anche gli scazzi con Joe Zawinul nei Weather Report, quando improvvisamente, nel bel mezzo di un pezzo suonava tutt’altro andandosene per i cazzi propri, cosa che di per sé sarebbe coerente con una armolodia alla Coleman, ma lontana mille miglia da una fusion che cominciava a mostrare i suoi difetti da secchioni in cattedra.
Jaco non aveva barriere stilistiche, e nel suo basso risuonava l’intera New York, che per moltissimo tempo fu la sua patria. Quindi anche la new wave, l’elettronica, il post hippie, i Suicide, il rap (a volte il suo fraseggio sul basso sembrava proprio far parlare lo strumento): tutto quello che insomma trasudava dai muri di una città le cui strade erano – letteralmente – la sua unica casa.
Volendo essere precisi, fu lui a individuare il concetto di punk jazz (come da brano manifesto omonimo del suo repertorio, originariamente scritto per i Weather Report su Mr. Gone), un modo di suonare fuori dagli schemi umorale e di getto, in cui c’è tensione anche nei momenti apparentemente chill e le armonie sono ardite. Pastorius è nel jazz l’equivalente di Sid Vicious nel punk. Uno è ipertecnico ma incostante, l’altro non sa neanche mettere le dita sulla tastiera ma prova in tutti i modi a suonare, entrambi sono ingestibili e trattati come outsider perché incapaci di rigare dritto nei rispettivi ambienti che hanno dato loro la fama.
Flea senza dubbio ha imitato l’attitudine punk jazz di Pastorius trovando poi la sua strada all’interno di quel percorso. Tant’è che Jaco è – per fare un esempio – più vicino a Les Claypool dei Primus piuttosto che a qualche altisonante nome del jazz tipo John Patitucci (che confessa di non aver toccato un fretless prima dei 20 anni per rispetto di Jaco e che non si sogna affatto di imitarlo per paura di non essere all’altezza). Se pensiamo che uno come Mick Karn dei Japan è stato appunto influenzato nello sviluppo della sua tecnica da Pastorius, o anche Sting nei Police, capiamo che forse Jaco è stato male interpretato: era per tutti e per nessuno.
Probabilmente quella che è riuscita a comprendere e incanalare il suo caos creativo è stata Joni Mitchell. Forti di una relazione artistica che li appaga in maniera quasi erotica, i due inanellano una serie di album (dal 1976 al 1979) che mantengono solo in apparenza delle strutture folk o jazz, entrando invece di fatto in un territorio sperimentale che ha il sapore della no wave (in particolare quella intrisa di influenze “latine” e sudamericane, che è riscontrabile in Don Juan’s Reckless Daughter) e di certe intuizioni di Captain Beefheart riviste con occhio fusion.
Dopo anni in cui ha perso di vista il bassista, nell’81 Mitchell va in un club a sentirlo. Jaco la riconosce e la mette subito in mezzo. «Abbiamo finito per suonare per un minuto scarso. Ho iniziato a improvvisare su un piano elettrico. A un certo punto Jaco ha girato giù un cavo in modo che scorresse lungo la tastiera dal Do centrale. Nel tentativo di spostarlo, ho inevitabilmente fatto una schifezza e qualcuno tra il pubblico ha urlato: “Non importa per gli errori, Joni”. Jaco stava ridendo. In quella particolare serata, era stato un sabotatore».
Ecco, la definizione giusta per Jaco è forse sabotatore della prevedibilità musicale, un pazzo diamante nero nel quale tutti i colori del suono erano assorbiti e convivevano insieme. E ancora oggi, ahimè, sta cercando le orecchie giuste nelle quali rifletterli. D’altronde è il suono del suo destino: the bass of doom.