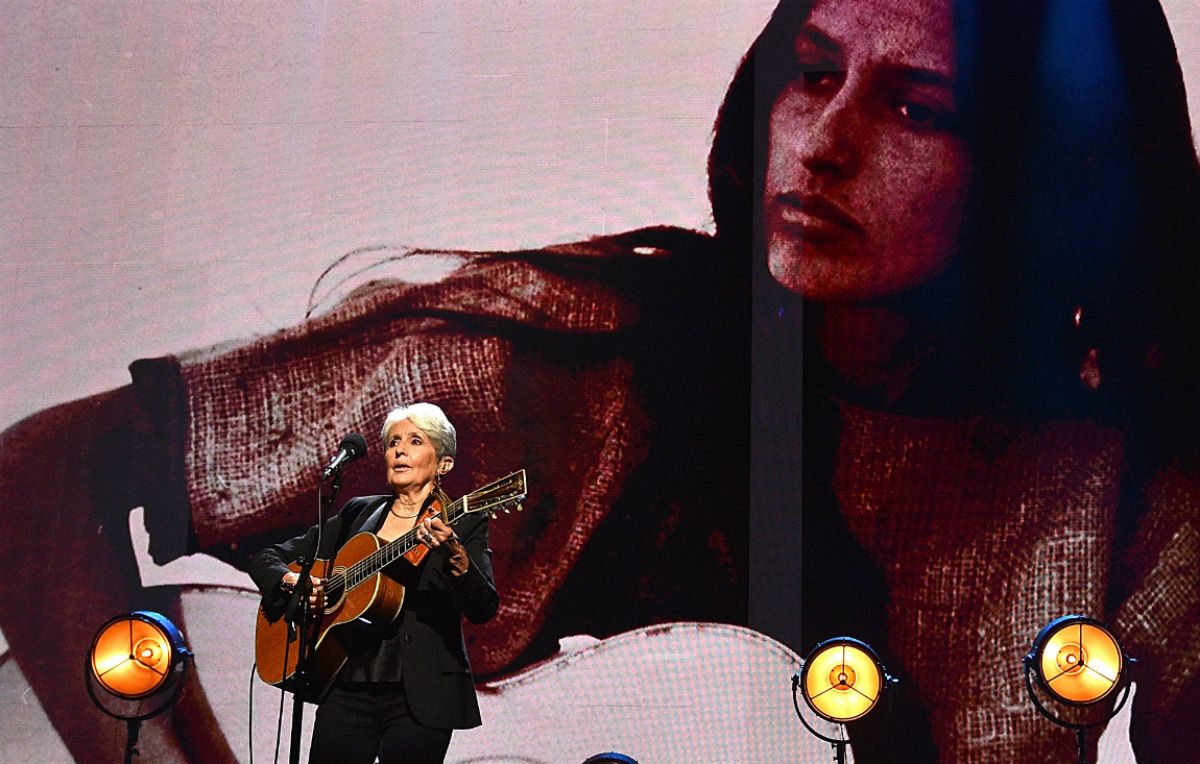Steve Albini ha lasciato questo sasso dopo 61 anni, stroncato da un infarto, un colpo secco come il rullante delle batterie dei dischi da lui prodotti, nell’unico posto dove probabilmente avrebbe voluto essere: lo studio di registrazione da lui realizzato nella sua amata Chicago nel 1997, Electrical Audio.
Su YouTube c’è una serie di video chiamata Show Us Your Junk! (letteralmente “mostraci le tue cianfrusaglie”) realizzata da Earthquake Devices, un’azienda che produce artigianalmente effetti a pedale che promettono di far suonare la vostra chitarra, basso o tastiera come una specie di antico manufatto alieno trasmesso da un televisore Mivar scassato sul fondo dell’oceano. In ogni episodio un noto produttore, musicista o tecnico del suono ci mostra il suo recording studio e soprattutto l’attrezzatura accumulata in anni di lavoro professionale (strumenti, amplificatori, console, ninnoli vari: chiunque suoni e/o produca musica è un accumulatore seriale di equipaggiamento).
Appena ho saputo, nel tardo pomeriggio di ieri, che la vita di Albini era finita come fosse uno dei miei dischi punk preferiti – troppo presto – sono andato a rivedermi l’episodio 23, quello a lui dedicato. Si apre con Steve nella sua classica tenuta da operaio scoglionato della Magneti Marelli degli anni ’70: tuta da lavoro blu, cappellino grigio, occhiale da bibliotecario svizzero, scarpe consunte. Anche una persona che non sa chi sia costui, che non ha la benché minima familiarità con il suo stratosferico curriculum, lo guarda e capisce che non c’è traccia di ego, di sovrastrutture, di quella mitologia rock di cui tante figure decisamente meno importanti di lui scelgono di ammantarsi.
Una sensazione confermata dalla frase di apertura dell’episodio: «Niente mi stimola. Faccio questo ogni giorno da oltre trent’anni, è solo lavoro. Certo, è un lavoro molto gratificante, amo quello che faccio, interagisco con le persone più interessanti del mondo, permetto loro di realizzare le loro più sfrenate ambizioni artistiche, cosa che è estremamente soddisfacente per me, però ecco, non sono in estasi quando faccio il mio lavoro… perché, appunto, è un lavoro». Sembrano le parole che potrebbe usare un idraulico per descrivere il proprio mestiere (sarebbe fra l’altro vestito meglio), non certo uno dei più importanti produttori e ingegneri del suono che il rock abbia mai avuto, un assoluto padrino dell’indie.
Per chi come il sottoscritto si avvicina al mezzo secolo di vita, Steve Albini è già un mito nei primi anni ’90, quando diventa il produttore di uno dei dischi più attesi di sempre, la prova del nove per i Nirvana dopo il successo interplanetario di Nevermind: In Utero, che l’anno scorso ha compiuto 40 anni. Ricordo bene il giorno in cui, con settimane di mancette e risparmi, vado da Mariposa Dischi in Porta Romana a Milano a comprarlo, prodigandomi poi in rituali che oggi con streaming e internet hanno perso tutto il loro significato ma che allora, nel 1993, sono pura magia. Scarto la plastichina, annuso il CD e infine ispeziono il booklet, mi guardo le foto, mi leggo i testi, i ringraziamenti. Cerco di vedere se riconosco qualche altro nome. C’è per esempio quello di un giovane regista di cui ho sentito parlare molto, si chiama Quentin Tarantino. Poi leggo: registrato da Steve Albini. Sarà per il cognome italiano (la sua famiglia aveva origini torinesi), ma quel nome mi rimane in testa.
Di lì a poco lo avrei trovato nelle note di alcuni dei miei dischi preferiti di sempre, roba del calibro di Surfer Rosa dei Pixies, Pod delle Breeders, Rid of Me di PJ Harvey, Tweez degli Slint, i primi fondamentali dischi dei Jesus Lizard. Steve Albini diventa sinonimo di sound brutale, senza compromessi. Ascoltatevi, per dirne una, Destroy Before Reading dei Jesus Lizard e avrete un’idea di come si possa tradurre acusticamente una rasoiata in piena faccia seguita da una versata di benzina sulla ferita.
Oltre che mago dei suoni, Albini è stato anche un grande musicista, pioniere e architetto del noise rock più sperimentale prima con i Big Black, forieri di un nichilismo che definire estremo è riduttivo, poi con i Rapeman (nome provocatorio del quale si pentirà negli anni), e infine con la sua creatura più nota, gli Shellac. Assieme al fedele Bob Weston e a Todd Trainer, Albini si inventa un genere con il disco di debutto della formazione, il fondamentale At Action Park, il post rock: geometrie spigolose, carezze di carta vetrata che con precisione millimetrica creano monumentali impalcature di suono sfociando in sporadiche melodie angolari.
Protagonista assoluta è la sua tecnica chitarristica percussiva e abrasiva ottenuta con plettri di rame e chitarre in alluminio Travis Bean. Li vidi al Primavera Sound di 15 anni fa a Barcellona con il mio amico Costantino della Gherardesca, e alla fine del loro set mi sentivo come se mi fossi passato tra i denti del fil di ferro.
Nel corso della sua ultratrentennale carriera Albini ha prodotto molti grandi artisti come Joanna Newson, i Mogwai, la Jon Spencer Blues Explosion, gli Helmet, i Sunn O))), Ty Segall, Jimmy Page e Robert Plant, Jarvis Cocker. Senza mai tradire la sua personale e indefessa etica professionale: dare il massimo per assecondare le pulsioni creative dell’artista, lavorare duro per tirare fuori la sua personalità in modo naturale e nello stile delle registrazioni sul campo (era un grande ammiratore dell’etnomusicologo Alan Lomax) senza ricorrere eccessivamente all’editing. Anteporre il risultato alla fama e ai soldi.
Che Albini fosse unico, che non ce ne sarà più un altro come lui, è testimoniato da migliaia di musicisti che hanno registrato sotto il suo sguardo vigile. Era uno che si impegnava con la medesima dedizione sia quando il cliente era un artista multiplatino che parcheggiava la Bentley davanti allo studio, sia che si trattasse di una band punk di scappati di casa che dormivano in un furgone scassato che puzzava di urina. Manteneva i prezzi del suo studio sorprendentemente bassi e accessibili rispetto a tanti produttori con un terzo del suo curriculum, ed era molto critico nei confronti dell’industria musicale, rea di sopprimere l’estro e la vitalità degli artisti e di lucrare eccessivamente sulla loro musica.
Sebbene sia una pratica usuale nel settore, Albini, in veste di produttore, non ha mai preteso alcuna royalty per i dischi ai quali ha lavorato (incluso il già citato In Utero, che ha venduto 15 milioni di copie). «Il modo in cui i produttori e gli studi venivano pagati, specie in quegli anni (i ’90, nda) era una pratica delle case discografiche per spostare dei costi dal loro budget – le parcelle del tecnico di studio appunto – e farli ricadere unicamente sull’artista. Ogni dollaro che avrei guadagnato (con In Utero, nda) sarebbe stato un dollaro in meno che avrebbero guadagnato Kurt, Chris e Dave. Credo che sia eticamente non sostenibile, assurdo. Io lavoro a un disco per pochi giorni e voi artisti per il resto della vostra vita dovrete continuare a pagarmi?». Così ha raccontato Albini a un ammirato Conan O’Brien nel suo podcast Conan O’Brien Needs a Friend.
Restiamo sulla genesi di In Utero. Nel 1990 i Nirvana sono in giro sul furgone quando qualcuno mette su Surfer Rosa dei Pixies. Cobain fa un balzo sul suo sedile proclamando ai suoi sodali «ecco il suono che avrà il nostro rullante!». Quel suono è merito di Steve Albini. Dopo il successo inimmaginabile di Nevermind e la popolarità che investe il trio, Kurt si sente a disagio, pensa che la produzione del disco sia troppo “patinata”, “commerciale”, che non rispecchi del tutto i suoni che aveva in testa. Vuole sentirsi libero dalla pressione della casa discografica che ha stanziato un budget enorme e ha una lista infinita di produttori a cui affidare questa gallina bionda dalle uova d’oro. Vuole che il suo nuovo lavoro sia una più accurata rappresentazione della band, di sé stesso come artista, e vuole che suoni come i dischi che ama. Quelli che ha prodotto Steve Albini.
Nel 1992 i Nirvana sono la band più grande del mondo e il seguito di Nevermind è il disco più atteso di sempre. Qualunque produttore di grido avrebbe fatto le capriole scodinzolando e si sarebbe ipotecato entrambi i reni per ricevere una telefonata dalla Geffen che lo informava che era in squadra. Albini è un produttore indipendente abituato da anni a cacciare fuori dischi di gente squattrinata che non ha manco i soldi per comprarsi le corde della chitarra in un paio di giorni, a tirare fuori le idee migliori con mezzi ristrettissimi. È rispettato nella scena noise per la sua militanza nella scena post hardcore (nei già citati Big Black e Rapeman) e per la sua intransigenza nei confronti del music business, colpevole di aver sacrificato la spinta eversiva del rock sull’altare del profitto. Quando il management dei Nirvana lo contatta, lui non fa capriole e non scodinzola. Invece scrive alla band una lettera che dovrebbe essere la Bibbia di ogni musicista del pianeta. Alcuni estratti:
«Credo che la miglior cosa che potreste fare arrivati a questo punto è esattamente ciò di cui stavamo parlando: tirare fuori un disco in un paio di giorni, con una produzione poco intrusiva ma di alta qualità, e nessuna interferenza di quelle teste dure ai piani alti. Se è questo ciò che avete in mente, mi piacerebbe un sacco farne parte. Se invece di questi tempi vi trovate a essere parecchio condizionati dalla casa discografica, di modo da sentirvi trattenuti e talvolta strattonati da un guinzaglio (e da cose come obbligarvi a rifare una canzone/un pezzo di essa/il modo in cui è stata prodotta, magari chiamando un tizio assunto da loro per “addolcire” un pezzo, trasformando il tutto in una stronzata remixata, o cose del genere), be’, state facendo una cazzata nella quale non voglio essere coinvolto. Sono interessato a realizzare dischi che riflettano davvero la percezione di una band nei confronti della musica e della vita. Se vorrete tenere fede a questo principio durante tutto il processo di registrazione, allora anche io darò tutto me stesso per questo disco».
«Adoro lasciare spazio alla casualità e al caos. Produrre un disco senza che si vedano le cuciture, dove ogni nota e sillaba è al proprio posto e ogni colpo di grancassa della batteria è identico, è veramente facile. Qualsiasi idiota con sufficiente pazienza e denaro può permettere che si compia un tale scempio. Preferisco lavorare a dischi in cui contano cose più importanti come l’originalità, la personalità e l’entusiasmo».
«Questione soldi: l’ho già spiegato a Kurt ma penso sia meglio specificarlo di nuovo. Non accetto e non accetterò che mi vengano ceduti dei diritti sui dischi che produco. Davvero. Punto. Penso che pagare i diritti a un produttore o a un ingegnere del suono sia eticamente indifendibile. La band scrive le canzoni. I fan della band comprano il disco. La band è interamente responsabile della buona o cattiva riuscita di un disco. I diritti appartengono alla band. Vorrei essere pagato come un idraulico: eseguo un lavoro e voi mi pagate una quantità di soldi adeguata al lavoro che ho fatto».
«Se ci vuole più di una settimana a fare un disco, qualcuno sta sbagliando qualcosa».
Nessuno nella sua posizione avrebbe mai avuto il coraggio di scrivere una mail del genere alla band più famosa del pianeta.
Al Guardian aveva recentemente dichiarato: «La parte che mi interessa è la registrazione, il fatto che sto documentando un pezzo della nostra cultura, il lavoro della vita dei musicisti che mi ingaggiano. Prendo questa cosa molto seriamente. Io voglio che quella musica sopravviva a tutti noi. Sono certo che le registrazioni analogiche sopravviveranno per secoli». Le sue sicuramente sì.