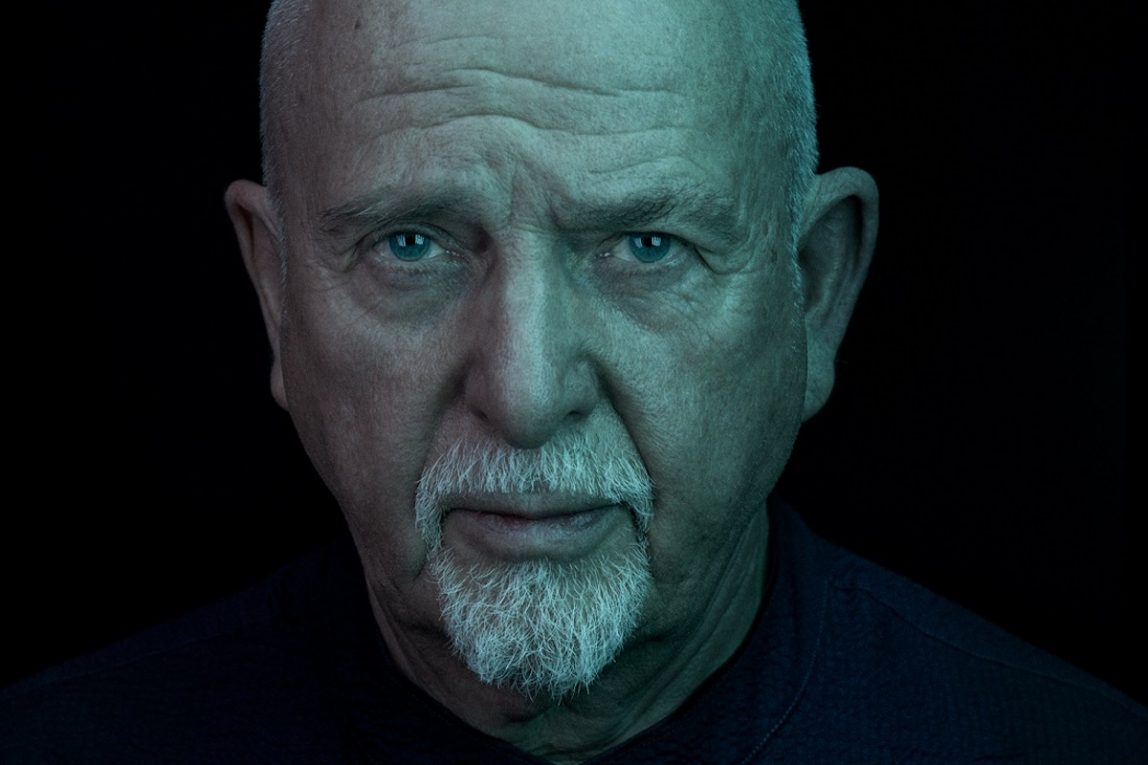Alcuni capitoli della storia dell’arte, che si traducono ad esempio, come in questo nostro caso, in prodotti musicali, sono talmente cruciali per peso storico e simbolico prima ancora che strettamente artistico da sembrare, per questa crucialità, persino più vecchi della loro età. È così che questi cinquant’anni di The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars che festeggiamo oggi sembrano, ed è incredibile a dirsi, quasi pochi per la forma statuaria che l’opera ha assunto attraverso il tempo.
Alzo le mani e lo dico subito: chi scrive deve a questo disco la vita, se la vita non è – e non lo è – quella cosa che implica semplicemente l’abitare questa Terra come essere respirante, ma l’attivazione piena e salda e porosa di tutte le più profonde funzioni vitali attraverso l’uso della cognizione emotiva, la pratica della libertà personale nel desiderio più ampio, aperto, di una libertà collettiva e la presa in carico del proprio comune ma pur sempre unico senso di alterità, di diversità, piccola o grande, segreta o conclamata che sia.
È una storia che ho raccontato e scritto spesso, ma ecco una buona occasione per ripeterla: ho incontrato una musicassetta sul cui lato B se ne stava, silenziosa da anni, la registrazione da vinile di questo disco del 1972 inciso da David Bowie una sera del novembre 1998 verso le 19:30, rovistando tra i tesori discografici dal gran valore sentimentale e dallo scarso valore commerciale che appartenevano ai miei genitori. All’epoca non sapevo chi fosse David Bowie e probabilmente non conoscevo neppure bene cosa fosse un LP. Oggi, dopo ventiquattro anni, ricordo precisamente l’angolo in cui ho pescato quella cassettina, il momento esatto in cui ho scelto di estrarla dal mucchio, la posizione assunta sul mio letto mentre ascoltavo le prime quattro tracce, quelle che da Five Years conducono speditamente, ma non senza trovate imprevidibili, a Starman, snodo ipermelodico rivelatore, parzialmente debitore in tal senso a Somewhere Over the Rainbow (e dove se non lassù?), dell’anima pop di un album che è prima di tutto, precisamente, un corpus di grandi canzoni pop con energici inserti rock, più che, come si dice spesso in giro, il contrario.
The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars è un disco di cui la storia celebrerà la dimensione musicale, le piccole avanguardie della scrittura, solo di traverso e molto tempo dopo, esattamente com’era nei programmi originari di Bowie che, più che di rock in sé, intendeva occuparsi con questo lavoro, del rock come rappresentazione, finzione inscenata, esibizione plastica del costruito umano.
Ricordo di quella sera e di quel primo ascolto, il senso inebriato di straniamento assoluto, le spalle al muro, le gambe incrociate, il corpo immobile, il mio guardare il vuoto e ascoltare con le orecchie tese e incapaci di decifrarle, costruzioni musicali diverse da quelle a cui ero abituata: il crescendo in apertura dell’album, alla fine di “Five Years”, che si frantuma in un’implorazione e che si ripete circolarmente, con una chiave narrativa diversa, nella struttura di Rock’n’Roll Suicide, in chiusura del disco e, ancora, l’architettura priva di ritornello della title track; vero incontro tra l’anima teatrale iperinglese di Bowie e il chitarrismo hard di Mick Ronson, Ziggy Stardust è già pura epica ancora prima di diventarla davvero, così, nel suo crescere senza ritornello, è un classico che si prepara, all’orecchio di chi ascolta, con gli abiti di sua maestà senza sapere neppure se gli spetterà il trono.
In fondo, in questo senso, la solennità preparata di Ziggy esprime bene l’idea non solo commerciale alla base dell’intero album: se vuoi essere una star devi prima di tutto comportarti da star, dunque se vuoi essere una rock’n’roll star devi occuparti di sembrare una rock’n’roll star e il rock’n’roll deve essere solo il mezzo di cui servirti per la riuscita della rappresentazione.
Quando approda all’ideazione di The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars, Bowie è un ottimo autore degli anni ’60 che non ce l’ha mai fatta davvero, ha avuto grandi momenti (con Space Oddity, specialmente) ma non ha ancora espresso sé stesso appieno. Il suo album del 1971, Hunky Dory, pieno di citazioni, esistenzialismo, purezza intorbidita da confusione nei riferimenti letterari, religiosi e nello spirito, è un lavoro straordinario che assumerà peso e forza storica soprattutto nella rilettura a posteriori, più di quanta gliene concedano vendite e risposte del pubblico al momento dell’uscita. Il disco della straordinaria Life on Mars?, un brano capace di incarnare perfettamente il senso mai statico, quando non ipercinetico, di Bowie per la multiformità e insieme per la classicità melodica, si presenta come un lavoro post adolescenziale, e non è dunque un caso che, come ben sottolinea Simon Reynolds, proprio quella Life on Mars? racconti in fondo del complesso di superiorità di una teenager molto intelligente che osserva tutto dalla distanza lucida di cui la dota quel senso di sprezzo tipico degli adolescenti.
Bowie stesso era, a quel punto della sua carriera, proprio come quella teenager: grazie alla sua intelligenza, alle letture grandi e a quelle di culto, agli ascolti e alle frequentazioni artistiche, sente ancora più vorace la frustrazione dell’inesplosione mentre Tony Visconti e Mick Ronson lo hanno (temporaneamente) abbandonato. È Tony Defries, l’imprenditore illusionista che fa del managing il suo palco teatrale, personaggio quanto i suoi protetti ma più astuto di loro, a studiare per Bowie una vita sotto i riflettori prima ancora che la sua vicenda artistica gli abbia davvero permesso di accenderli. Con la sede newyorkese della sua agenzia, la MainMan, Defries aveva per i suoi un conto aperto al Max’s Kansas City e uno per l’affitto delle limousine, assumeva segretarie e lavoratori ad affiancarlo – con Bowie ci sarà Cherry Vanilla – che provenivano dalle grandi agenzie pubblicitarie di Madison Avenue e dalla Factory di Warhol, luogo che affascinava Bowie quanto lo avevano colpito e affondato uno dei suoi protagonisti, Lou Reed, e pure Iggy Pop, due artisti di cui amava le storie e le band tanto da arrivare a produrre, in due diversi momenti dei 70s, i loro dischi solisti cruciali, rispettivamente Transformer (1972) e The Idiot (1977).
Quello che passa alla storia come un concept album, uno dei più grandi della storia, in realtà non lo è poi così tanto. Bowie, più che altro, infatti, si concederà di agganciare il concept all’album in fase finale, muovendosi tra i brani e costruendo la scaletta mettendo insieme pezzi esclusi da Hunky Dory (It Ain’t Easy) e brani nati all’ultimo, precisamente per essere delle hit (appunto Starman). L’idea della band costruita come fece Bowie aveva illustrissimi, giganteschi predecessori: i primi erano stati i Beatles con Sgt. Pepper’s ma poi c’erano stati i Mothers of Invention di Frank Zappa, i Turtles con The Turtles Present the Battle of the Bands e altri ancora, ma quello che è certo, e questo punto è una chiave fondamentale per aprire la porta sul mondo di Ziggy e del Bowie del 1972, è che nessuno come lui (neppure dopo) ha costruito una band immaginaria senza avere precise finalità musicali. Se cioè, per i Beatles, Pepper rappresentava, nel frangente, quasi una forma di salvezza, la possibilità messa in campo da McCartney di continuare a suonare insieme e incidere dischi, per Bowie, Ziggy e gli Spiders, col loro lavoro di performer, il trucco, i costumi di scena, il tocco folle dello stilista Freddie Buretti (che gli Spiders si erano inizialmente rifiutati di vestire), il mix di teatro Kabuki, scenari fiabeschi, mimo e commedia dell’arte erano un codice di bonaria manipolazione del mondo reale, la ricca rappresentazione dell’ascesa (e della caduta) di una star del rock’n’roll a cinque anni dall’apocalisse, versione confezionata, plastica, del cantante rock in ascesa che avrebbe dovuto essere (e che sarà) Bowie stesso.

In un clima di cambiamento, in cui gli ideali dei Sixties puzzavano di vecchio e con loro i jeans a zampa, i capelli lunghi (che Bowie tagliò di netto e dipinse di rosso acceso), quel gran desiderio di assoluta verità e di realtà che aveva nel corpo nudo, nell’esaltazione dell’idea del “naturale” e in una certa noncuranza di abiti e apparenze la sua vocazione pratica e nell’improvvisazione e nella regressione all’urlo primordiale la sua espressione teatrale e performativa, il glam credeva nella fantasia e nell’esotismo come luoghi dove costruire la libertà e per affermarla ricorreva a un uso della realtà e dei suoi strumenti sì iperestetizzato, sgargiante, luccicante ed eccessivo, ma specialmente in grado di anticipare in grande il postomodernismo, contro la dittatura della coerenza, della strada tracciata, della rivelazione, nell’arte, della propria iper realtà come unica strada percorribile.
Nella figura e nell’epopea cosmica di Ziggy, Bowie riuniva e insieme disperdeva come coriandoli al vento tutti i suoi frammenti, gli elementi della costruzione di un sé avvenuta fino a quel momento tramite il rock delle origini, da Little Richard a Vince Taylor, Marc Bolan, (Z)Iggy Pop, e ancora, si diceva, Lou Reed, Arancia meccanica, Metropolis, Lindsay Kemp, Christopher Isherwood, Eliot e un’infinità di tasselli deducibili mettendo gli Spiders e il loro cantante sotto le lenti del microscopio. L’operazione di ingrandimento ha senso fino a un certo punto, certo, così come è certamente limitata e parziale eppure ancora fondamentale, oggi, la prospettiva sulla questione sessuale e di genere che la figura di Ziggy impose al mondo con la sua caduta sul pianeta Terra e le sue affermazioni, poi rivedute e corrette continuamente, altresì, riaffermate, circa l’omosessualità, rilasciate agli esordi artistici di Ziggy, durante una storica intervista per il Melody Maker (all’epoca la rivista musicale più letta al mondo).
Bowie (e Defries) sapevano che sarebbe servito qualcosa di forte, di definitivo, e così aprirono le porte alla dichiarazione più scomoda e insieme dirompente di tutte: «Sono gay e lo sono sempre stato». Di lì a poco l’entourage di Bowie avrebbe scoperto che non era vero, al massimo era bisessuale ma forse, a dire il vero, nemmeno quello. L’effetto desiderato, però, si ottenne eccome: nella grigia, buia, dura Inghilterra dei primi anni ’70, i sorrisi, le fantasie degli abiti, la posa camp, il glamour innato e così perfettamente restituito da Bowie/Ziggy sul Melody Maker e da lì in poi ovunque si trovasse erano non solo una boccata d’aria ma una botta di energia, di pura libertà ed erotismo. Bowie aveva capito che quella dichiarazione gli avrebbe spalancato le porte in primis grazie all’enorme curiosità generale che ne sarebbe scaturita e in secondo luogo grazie alla scarica di senso di libertà collettiva che avrebbe generato, dicendosi gay, tra le righe, Bowie dichiarava altro, urlava a tutto il mondo di amare non tanto il suo stesso sesso quanto la possibilità di desiderare, chiunque e qualsiasi cosa, e specialmente di poter concentrare in sé istanze culturali diversissime, purché vitali, esuberanti, feconde, com’era ad esempio, ai suoi occhi, in quel momento la cultura gay.
C’è di più, in alcuni frammenti della cultura gay Bowie aveva letto e stanato l’espressione di un senso di solitudine e unicità che sentiva anche proprio, aveva scoperto molto presto che essere un adolescente di Brixton o un omosessuale potevano essere due condizioni in grado di generare stati d’animo e di emarginazione analoghi. Attraverso Ziggy e il suo farsi compendio ideologico e performativo postmodernista, Bowie, per la prima volta nella sua storia artistica, ha combattuto forme più e meno intime e collettive di quella emarginazione, laddove l’emarginazione si proiettava nel mondo a partire da solitudine e senso di un’unicità incompresibili dagli altri (la teenager intelligentissima di Life on Mars?, dicevamo).
Quando, quel pomeriggio a Top of the Pops per il lancio del disco, Bowie si ritrovò a cantare Starman davanti a tutta l’Inghilterra guardando e indicando con sicurezza in camera sui versi “I had to phone someone, so I picked on you”, tutti gli adolescenti inglesi (e non solo) si sentirono chiamati in causa, si sentirono guardati, ebbero la sensazione di sentire in casa loro lo squillo di quel telefono. Fu una mossa commerciale straordinaria, certo, ma fu specialmente una mossa umana destinata a una vita ancora più lunga. Non è un caso che il glam, e qui torno alle parole di Reynolds, generò come mai prima il fenomeno del fan che si vestiva come l’artista in adesione a un comune senso d’appartenenza a qualcosa: persino io, ragazzina della provincia italiana, ventisei anni dopo l’uscita di quel disco, dopo aver ascoltato quella cassettina che sarebbe rimasta nel mio stereo e nel mio lettore portatile per otto mesi, come Hugo Burnham, il batterista dei Gang of Four che allora non conoscevo, a una famosa fiera dell’usato di Milano comprai un boa di struzzo con il quale avevo preso a uscire quando mia madre mi chiedeva di andare a comprare qualcosa, o quando dovevo incontrare qualcuno dall’altra parte della città o sotto casa.
Io per prima sentivo, pur senza ancora riuscire a decifrarla, questa forza dirompente, legata a un comune sentire che attraversava a quel punto lo spazio-tempo e pur addobbata come mai prima, nella versione apparentemente meno naturale di me, con le unghie smaltate, i capelli pazzi e quel boa, mi faceva sentire pienamente me stessa. C’era l’imitazione, certo, ma c’era soprattutto l’esito di quello che sarebbe stato il più grande dono di Bowie alla storia della mia vita: la scoperta del gioco, talvolta estremo, delle infinite possibilità. Grazie a Ziggy, David Bowie è stato per molti un compagno di giochi, di scoperte, una figura utile all’autolegittimazione e anche alla leggittimazione dell’altro, diverso da noi. Ci avevano insegnato che siamo tutti uguali ma Bowie, in primis grazie a Ziggy, ci ha ricordato che siamo invece tutti diversi e che, anzi, abbiamo in qualche modo il dovere di ricordarci sempre di esserlo e di affermare nel mondo il nostro piccolo e personale spazio di diversità.
A cinquant’anni dalla sua uscita, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars, un disco di grandi canzoni pop dalla polpa morbidissima, con antri tirati che anticipavano il punk (Hang On to Yourself vs. God Save the Queen) forse non ha proprio bisogno dei nostri ricordi, ma certamente va letto, nell’arco storico, col potentissimo valore educativo che più che racchiudere, schiude, e nel quale, ancora più che nelle sue strutture sonore, va considerato come un’opera dell’avanguardia.
«Ogni donna è anche un uomo e ogni uomo è anche una donna», scrivevo alla mia compagna di banco, al ginnasio, sul diario, cercando di farmi largo tra le citazioni estratte dai testi dei Nirvana che avevano scritto altri a pennarello. Il concetto non era approfondito, andava certamente esplorato, espresso meglio, ma ci siamo capiti: che ogni corpo e ogni desiderio e ogni vitalità esistono per ciò che sono e per ciò che sono vanno valorizzati o persino esaltati e che tutto, davvero tutto, può essere speciale anche se è altro da noi sono veri principi educativi basilari che la scuola a quel tempo non mi insegnò, ma quella cassettina TDK, sì.