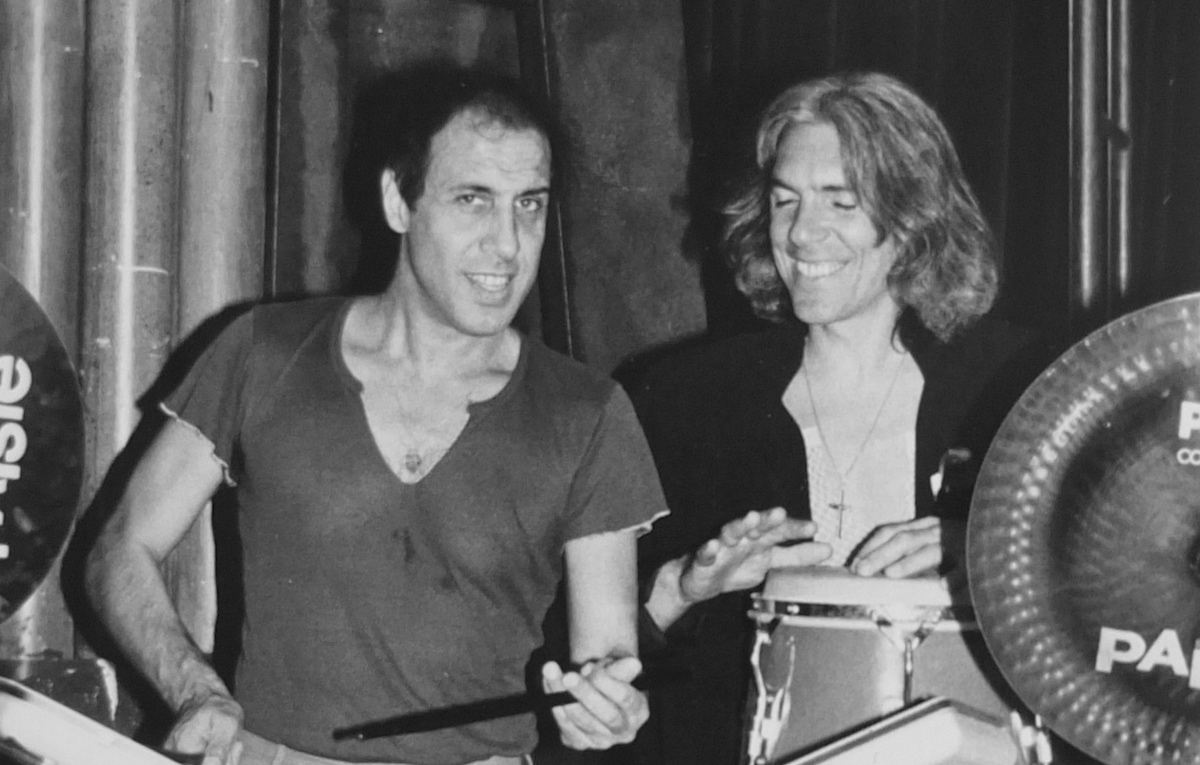Nella nostra identità di italiani, la data del 29 settembre significa una cosa sola: “Seduto in quel caffè, io non pensavo a te”. 29 settembre, appunto, è il classicone che nel 1966 Lucio Battisti, in sodalizio con Mogol, scrisse per l’Equipe 84, e che lui stesso nel 1969 ha interpretato nel suo album di debutto omonimo. Una spaghetti-My way, che ci restituisce l’immagine più convenzionale del suo autore: il deus ex machina della canzone pop, fra melodie alari e frasi-icona scolpite nei giri di do. Il padre, insomma, del nazionalpopolare.
Ma c’è un altro 29 settembre nella carriera di Battisti, a distanza siderale da quello che la storiografia tramanda facilmente: il 29 settembre del 1994, venticinque anni fa, usciva Hegel, il suo ultimo album. Se l’esordio di Lucio Battisti è praticamente una raccolta di hit, questo è un disco sepolto, per cui gli aggettivi che si leggono in giro dicono tutto: enigmatico, incomprensibile, ripiegato su se stesso ai limiti dell’ermetismo; futuristico, visionario, provocatorio nelle intenzioni. Sicuramente sincero, perlomeno nello sbattersene del mercato, delle italo-tendenze e della tradizione. Ai limiti dell’oltraggio verso l’eden definito con Mogol, quindi, e incompreso: ancora non sappiamo cosa significhi un lavoro del genere, che messaggio nasconda. Ed è notizia doppia, questa, se si considera che parliamo di uno degli inventori del pop italiano, edificato a colpi di ricerca – è vero – eppure incrociata con l’immediatezza.
Ma la storia della star di Acqua azzurra, acqua chiara che abiura tutto per la sperimentazione era iniziata prima: nel 1980, quando il Nostro ruppe il sodalizio con Mogol e decise di trincerarsi nel silenzio. Zero apparizioni pubbliche, zero promozione, pochissimi singoli. E già (1982) fu il primo tassello del nuovo periodo, con sintetizzatori al fronte e i testi atipici della moglie di Lucio – Grazia Letizia Veronese – al posto degli storici di Rapetti. Uno step: da Don Giovanni (1986) le liriche passarono al poeta Pasquale Panella, sancendo l’inizio della “fase bianca” (per il minimalismo “bianco” delle copertine) con album ancora più difficili, pubblicati ogni due anni. Dal 1986 fino, appunto, al 1994. “Se sono stato io a inventare il pop – deve aver pensato Battisti – allora sarò io a distruggerlo”: da lì in poi il Nostro abbraccerà l’elettronica e le pulsazioni, la dance e la disco, con testi astratti e complessi. Come a fare a brandelli il paradigma da lui stesso stabilito, e che aveva finito con l’odiare. Per i fan storici sarà spiazzante, le vendite coleranno a picco, la critica si dividerà fino a rivoltarsi a tanta solitaria auto-iconoclastia. Ma a Battisti interesserà poco: l’importante era diventato osare, non ripetersi più.
Ecco: Hegel e il suo integralismo non vengono dal nulla, ma sono il culmine di questo processo. E tutt’ora restano un rebus: cosa significa, per esempio, la copertina con una “E” in bella vista? Boh. Del resto che c’è da aspettarsi da un disco scritto con un poeta (un esperimento già attuato dall’altro Lucio della musica italiana, Dalla con Roversi, con risultati altrettanto criptici) e ispirato al pensiero di Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filosofo che chiunque al liceo ricorda con lacrime, sudore e sangue? Appunto: i testi si dividono fra ermetica e pura filosofia (la title-track, ascoltare per credere), paroloni che in comune con “le bionde trecce” di Mogol hanno solo la voce. Una voce che sembra di un fantasma onnipresente ma inclassificabile, dell’artista figlio di un’altra dimensione: un artista che vuole comunicarci qualcosa, o magari solo prenderci in giro, forse starsene per conto proprio dopo una vita sotto i riflettori. Non si sa, come non si sa – per dire – a cosa corrisponda “l’orgoglioso refrigerio” dell’opener Almeno l’inizio (quasi una Prendila così post-atomica, o comunque post-popolare), così come lo pseudo trattato di Estetica. C’è, ovviamente, la ricerca di un lessico che si immoli alle necessità metriche, ma è chiaro che un significato sepolto (non si sa dove, però) rimane.
Di sicuro Hegel era – come appurato – “avanti” per la nostra musica, rinunciando alla confortevole tradizione per gli inglesismi allora attuali della house, del synth-pop (Tubinga ne è una super-cavalcata) e della dance. Anche qui: la ricerca di sonorità in terra britannica era già emersa prima e durante la svolta bianca (Il veliero del 1976, per dire), ma il punto diventa l’estremizzazione di un pop elettronico e minimale che magari riduce pure la violenza dei battiti del precedente – e parecchio ostico – Cosa succederà alla ragazza, ma ne aumenta la complessità. Ballabile eppure enigmatico insomma, straniante perché mette una ritmica sincopata sopra al gusto per la melodia (lui, Battisti!). Un po’ un Battiato votato al dancefloor, un po’ Matia Bazar dei tempi d’oro, soprattutto contro ogni certezza: la ballad all’italiana viene decomposta coi campionamenti (La bellezza riunita), Stanze come questa profuma addirittura di Underworld (!) e lo schema classico strofa-ritornello – che tanto gli aveva dato nei Settanta – si trasforma in un ricordo da cartolina, sotto strati di sintetizzatori.
È l’apocalisse del pop italiano condotta da chi l’aveva definito, ma è una fine che si consuma nell’indifferenza. Nonostante l’album provasse a illuminare verso direzioni che l’Italia ignorava (e continuerà a ignorare), rimarrà il meno venduto (e ascoltato) della sua carriera, probabilmente per l’essenza concettuale che lo anima: non ha la carica divulgativa necessaria per consentire al grande pubblico di sdoganarlo da semplice freak, e resta trincerato in se stesso. Come se la distruzione della forma canzone, Battisti, la portasse avanti dal divano di casa sua, e a noi ascoltatori, fan, critici, giornalisti, appassionati e nostalgici del periodo Battisti-Mogol non rimangano che piccoli scampoli fuoriusciti da questa reticenza.
E a distanza di venticinque anni, insomma, in Hegel troppe cose non tornano – il significato di certi testi, come alcune scelte “sottosopra” di arrangiamento. Probabilmente l’intenzione era quella: finire la carriera con un mistero spiazzante che suonasse in eterno, agli antipodi degli esordi, nel dubbio perpetuo. O magari l’esigenza era molto più intima: registrare un disco esattamente come lo si voleva, e chiuderlo con un pezzo (La voce del viso) che è un synth-pop danzerino talmente sfacciato che non poteva altro che far sentire Battisti finalmente liberato dalla sua stessa icona. Non lo sapremo mai, ma questo rimarrà un problema nostro. Per Lucio, è evidente, era tutto perfetto così.