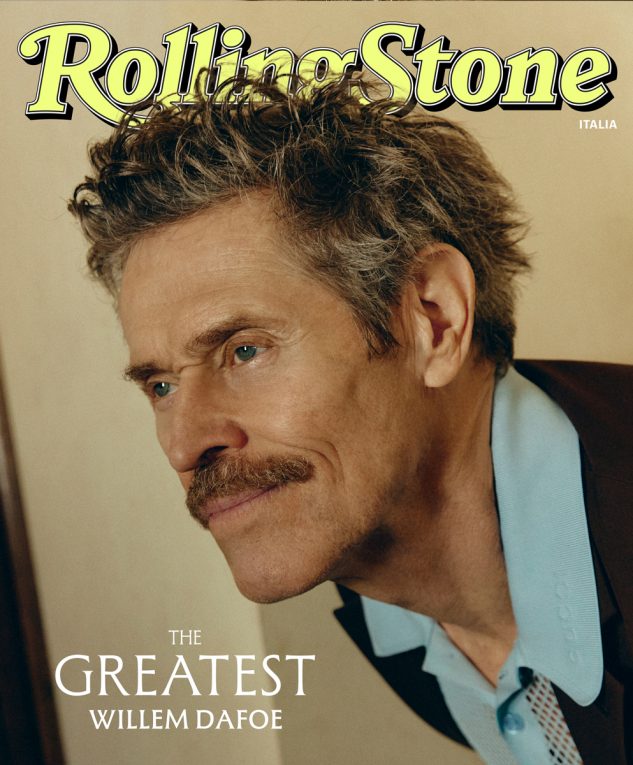Per Lula non è solo una vittoria, ma una resurrezione
Tre anni fa il leader del Partito dei Lavoratori trascorreva le proprie giornate in una cella scontando false accuse: ieri è stato eletto, per la terza volta, presidente del Brasile, ponendo fine alla (terrificante) esperienza del governo Bolsonaro. Lo attende una sfida difficilissima: dovrà restituire dignità e rappresentanza alle popolazioni indigene, fermare la deforestazione e irrobustire un welfare dilaniato
Appena tre anni fa, Luiz Inácio Lula da Silva trascorreva ventitré ore al giorno rinchiuso in regime d’isolamento all’interno del carcere federale di Curitiba, ingannando i tempi morti della detenzione come meglio poteva: in cella leggeva molti libri, con una certa predilezione per i saggi che il sociologo Jessé de Souza ha dedicato agli studi sulla disuguaglianza imperante nella società brasiliana; per mantenersi in forma, passeggiava per almeno due ore al giorno su un tapis roulant; da grande appassionato di calcio, non perdeva neppure una partita del Corinthians, la squadra che tifa fin da bambino (ironia della sorte, una passione che condivide con Jair Bolsonaro); soprattutto, preparava il terreno per un ritorno in politica che progettava da almeno otto anni, stroncato sul nascere dagli sviluppi di un’inchiesta, la Lava Jato, caratterizzata da parecchie zone d’ombra e paragonata a più riprese alla nostra Tangentopoli.
Ripercorrere in questa sede le tappe che hanno scandito il caso giudiziario più chiacchierato della storia recente brasiliana è impresa ardua; riassumendo: Lula era stato condannato per due processi. Uno, in primo grado presso la 13ª Vara da Justiça Federal di Curitiba, poi in appello presso il Tribunale Regionale Federale della Quarta Regione, riguardava un appartamento «Triplex» nella località balneare di Guarujá, Stato di San Paolo. L’altro, in primo grado sempre a Curitiba, era relativo alla ristrutturazione di una casa di campagna nella località di Atibaia; l’abitazione, formalmente, risultava di proprietà dell’imprenditore Fernando Bittar, ma secondo il Ministero Pubblico Federale, di fatto, Lula era il proprietario reale e l’utente principale dell’immobile, che aveva ricevuto dall’azienda OAS in cambio di una serie di favori per farle ottenere contratti (senza gare d’appalto) con Petrobras, la ricca e potente compagnia petrolifera statale brasiliana al centro di numerosi scandali.
Da lì in poi le dietrologie e le speculazioni hanno dominato la cronaca: per i detrattori, Lula è un corrotto da punire; chi vive nella terra di mezzo, pur non ritenendolo completamente innocente, reputa le accuse nei suoi confronti eccessive e strumentali; infine, per i sostenitori, si è trattato di un processo di stampo eminentemente politico, attuato al fine di impedire al leader del Partido dos Trabalhadores di candidarsi per le elezioni del 2018 – una suggestione rafforzata dalla circostanza che Sergio Moro, il Pubblico Ministero che ha condotto, dal marzo 2014, il processo in primo grado dei crimini identificati nell’operazione Lava Jato, per uno strano scherzo del destino si è trovato a occupare la carica di ministro della Giustizia del governo Bolsonaro; non sono mai state trovate prove che confermassero l’ipotesi investigativa e, nell’aprile del 2021, con una sentenza storica, la Corte Suprema ha etichettato l’operato di Moro come imparziale e motivato per fini politici: il processo dovrà ripartire, staremo a vedere.
Per tutti questi motivi, per i sostenitori di Lula la vittoria di ieri assume un significato importantissimo: il leader del Partito dei lavoratori è riuscito a risorgere dalle ceneri di uno scandalo giustizialista, conquistando per la terza volta la carica di Presidente della Repubblica Federale del Brasile e battendo per circa un milione di voti il candidato di estrema destra Jair Bolsonaro.
¡VIVA @LulaOficial!
📍La Huella de Seregni pic.twitter.com/7p0WivXWTV— Frente Amplio (@Frente_Amplio) October 30, 2022
Non è stata una vittoria scontata: i sondaggi davano Lula vincente già al primo turno, sottostimando grandemente le grandi concentrazioni di interesse (il settore agroindustriale e dell’allevamento, rappresentato in Congresso dalla cosiddetta “bancada ruralista“, quello della sicurezza pubblica e privata, i sindacati dei camionisti e dei tassisti preoccupati dalle liberalizzazioni e dall’apertura alla concorrenza, le comunità religiose evangeliche pentecostali, i land grabbers interessati allo sfruttamento economico delle terre indigene) che remavano in direzione di una rielezione dell’ex militare. In un certo senso, quindi, Bolsonaro qualche motivo per sorridere ce l’ha: ha allontanato lo spauracchio della disfatta riuscendo a ridurre un divario che sembrava incolmabile, costringendo Lula al ballottaggio e certificando che la società brasiliana è più divisa e polarizzata che mai.
A confermarlo sono anche i numeri: Lula ha incassato il 50,8% dei voti, imponendosi al fotofinish. Lo aspetta un mandato complicatissimo e pieno di insidie, dovrà fare i conti con un’opposizione feroce e compatta che non perderà occasione per delegittimare il suo mandato e rievocare i suoi trascorsi giudiziari.
Peraltro, la crociata contro la legittimità dell’elezione di Lula è iniziata con larghissimo anticipo, ben prima dell’apertura delle urne: intuendo la sconfitta e prendendo in prestito la lezione di uno dei suoi numi tutelari, Donald Trump, Bolsonaro ha avuto buon gioco nell’avvelenare il dibattito agitando lo spauracchio delle “elezioni truccate”. Non sappiamo ancora se, nei prossimi giorni, assisteremo a scene simili a quelle dell’assalto a Capitol Hill, ma la sensazione più diffusa è che il leader del Partido Liberal non perderà occasione per aizzare la sua base contro il risultato elettorale.
Quel che è certo è che, dopo quattro anni di agenda Bolsonaro, il ritratto che emerge è quello di un Paese ferito: sembra passata un’eternità da quella mattinata surreale dell’8 ottobre del 2018 quando, folgorati sulla via di Damasco, ci siamo risvegliati con un ex artigliere dalle aperte simpatie fasciste (e accanito sostenitore dei metodi resi celebri in patria dalla dittatura militare di Humberto de Alencar Castelo Branco, che ha tenuto in pugno il Brasile fino al 1985) alla testa della sesta potenza economica mondiale. Sotto la regia del numero uno del Partido Social Liberal, il Brasile è diventato un Paese peggiore, funestato da politiche sconsiderate che non hanno fatto altro che impoverire la popolazione, esacerbare le disuguaglianze e gli sviluppi della catastrofe ambientale e, soprattutto, azzerare i diritti degli indigeni.
Da quando è salito al potere, Bolsonaro ha messo in campo ogni mezzo utile per mantenere fede alla sua agenda neoliberista, anti-indigena ed ecocida, incoraggiando l’utilizzo delle terre indigene e delle aree protette dell’Amazzonia, duramente colpite dalla deforestazione e dalle miniere illegali, per agevolare lo sfruttamento delle risorse e aprire il polmone della Terra alle meraviglie del libero mercato. Ha paragonato i loro abitanti ad animali rinchiusi negli zoo, suggerendo che le loro condizioni di vita avrebbero vissuto un netto miglioramento se soltanto avessero scelto di rinnegare una volta per tutte i loro costumi tribali e le loro usanze ancestrali per buttarsi a capofitto nella modernità trasformandosi in imprenditori, godendo di una fetta dei profitti che sarebbero derivati dall’apertura dei loro terreni all’allevamento, all’agricoltura, al taglio del legname e all’estrazione.
Un quadro aggravato anche da una delle gestioni della pandemia più scellerate e dilettantistiche al mondo: la risposta brasiliana al coronavirus da parte dell’amministrazione Bolsonaro è stata un completo disastro, a partire dalla promozione di cure bizzarre come il cosiddetto “kit-Covid”, ossia un insieme di farmaci terapeutici la cui efficacia non è stata provata scientificamente, come l’idrossiclorochina o l’ivermectina antiparassitaria, fino ai ritardi nella fornitura di vaccini – secondo quanto dichiarato in aula da Carlos Murillo, direttore generale di Pfizer per il Sudamerica, il colosso farmaceutico tentò di negoziare la vendita di vaccini al Brasile ben sei volte, cinque nel 2020, a partire già dal mese di agosto, e un’ultima nel febbraio 2021. In questo contesto, il governo non avrebbe risposto a 53 delle 81 mail di proposta d’acquisto da parte di Pfizer, rallentando notevolmente la fornitura e la somministrazione dei vaccini nel Paese. L’anno scorso, mentre le piazze delle principali città brasiliane si riempivano di manifestanti uniti al gridi di “Fora Bolsonaro!”, alcuni senatori di opposizione hanno addirittura dichiarato di essere in possesso di prove che potrebbero certificare l’instaurazione di una specie di ministero della Salute parallelo, in cui sedicenti esperti e consiglieri di fiducia avrebbero proposto al presidente di adottare strategie e rimedi privi di qualsiasi fondamento scientifico – in quei mesi, era quasi impossibile distinguere Bolsonaro da un personaggio di Sacha Baron Cohen.
Nel gennaio del 2021, Raoni Metuktire dei Kayapo e Almir Narayamoga Surui della tribù Paiter Surui, due leader indigeni, hanno presentato al tribunale dell’Aia un dossier dettagliato per provare a fotografare lo stato dell’arte della “cura bolsonaro”: pagine che hanno evidenziato come la deforestazione, i trasferimenti arbitrari di intere comunità e gli omicidi di leader indigeni si siano impennati da quando Bolsonaro ha preso il potere nel 2019. Il caso è stato portato davanti alla Corte Penale Internazionale, dove l’ex militare è stato accusato di crimini contro l’umanità e genocidio. Risulta quasi impossibile, poi, dimenticare la carnevalata suprema dello scorso 16 marzo, quando Bolsonaro è stato onorato dal suo stesso governo di una “medaglia al merito indigeno” per il suo agire “altruistico” nei confronti delle popolazioni dell’Amazzonia.
Con un retroterra del genere, Lula dovrà assumersi l’onere di promuovere un ritorno alle politiche sociali che avevano caratterizzato la sua precedente presidenza, di irrobustire un welfare dilaniato e di fornire dignità e rappresentanza alla popolazione indigena, in primis restituendo autonomia operativa e rappresentanza al FUNAI, l’organizzazione del governo brasiliano che dovrebbe proteggere i loro fragili equilibri ma che, negli ultimi anni, è stata infiltrata dal verbo dell’estrattivismo tramite il posizionamento di personale fedele al credo delle privatizzazioni propagandato da Bolsonaro. L’altro nodo cruciale (cui la questione indigena è direttamente collegata) è, ovviamente, quello della deforestazione e dei cambiamenti climatici: negli ultimi quattro anni, l’Amazzonia è stata trattata come una merce tra le tante da cui estrarre valore; il neo presidente ha parlato apertamente di deforestazione zero e di transizione verso un’economia sostenibile, segnando un cambio di passo deciso rispetto all’operato scellerato del suo predecessore. Che dire: è ancora prestissimo, ma il ritorno di Lula non può che essere una buona notizia per l’ambiente, le minoranze e la riduzione delle disuguaglianze – solo per citare qualche numero: con un coefficiente di Gini pari al 52% nel 2014, la disparità di reddito brasiliana si può definire tra le più alte al mondo. Nonostante sia parte del G20 e fra le prime dieci economie al mondo, in Brasile il ceto più ricco della popolazione continua a beneficiare e appropriarsi di una maggiore fetta di rendita: da questo punto di vista, avere un sindacalista al governo non può che far ben sperare.