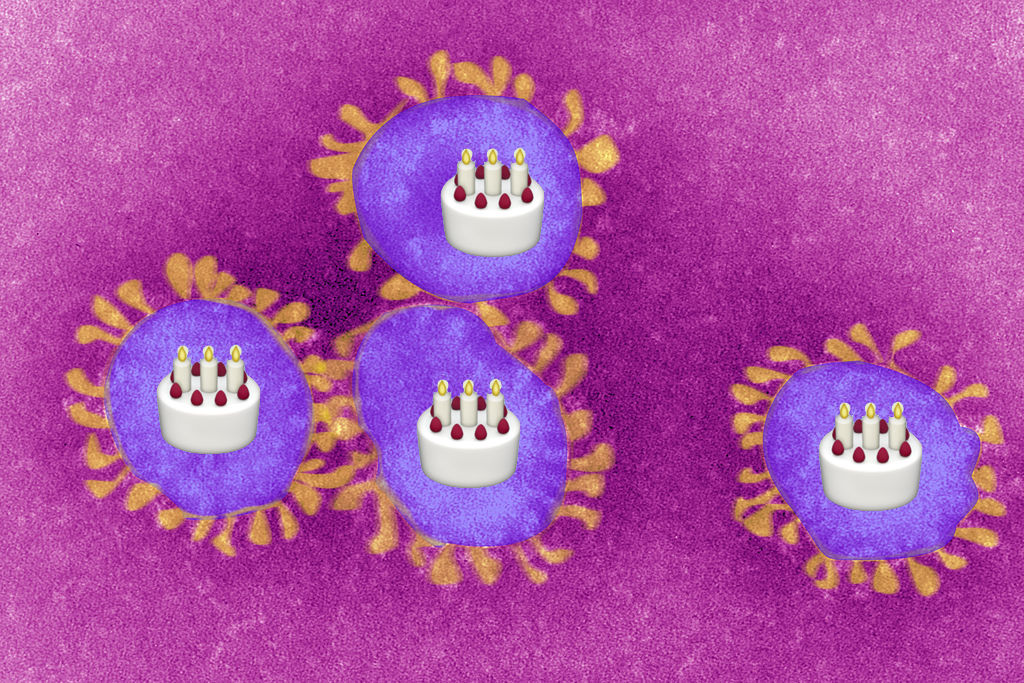Non è ufficiale, ma quando scriveremo la storia della pandemia da coronavirus del 2020 e dovremo stabilire il giorno in cui tutto è iniziato decideremo per comodità di renderlo tale: il 17 novembre 2019 – almeno stando a una ricostruzione a posteriori fatta lo scorso marzo dal quotidiano di Hong Kong South China Morning Post – un uomo di 55 anni residente nella provincia cinese delle Hubei veniva infettato da un virus sconosciuto che sarebbe stato poi battezzato SARS-CoV-2, aka “il coronavirus”.
È questo uomo il paziente zero, almeno ufficialmente, anche se non ci si è accorti che lo fosse. In ogni caso, due giorni fa era l’anniversario della sua infezione e oggi, un anno fa, possiamo ipotizzare che questo signore abbia cominciato a manifestare i primi sintomi. Non sappiamo che ne sia stato di lui, se sia guarito o meno. Quello che sappiamo è che ha messo involontariamente in moto qualcosa di molto più grande di lui e di tutti noi, qualcosa che un anno dopo è ancora qui e che ha già cambiato profondamente le nostre vite – sia in termini generali come società, sia dal punto di vista individuale.
Il 2020 resterà nella storia come l’anno della pandemia, e nelle nostre memorie personali come l’anno che invece che 12 mesi ne è durato 120 percepiti. Oggi quello che facevamo e pensavamo lo scorso dicembre, appena un anno fa, ci sembra appartenere a un’altra vita. Riuscite a ricordare di che cosa parlavate prima che la pandemia si abbattesse sul mondo e tutti i discorsi cominciassero a vertere inesorabilmente sul bilancio di oggi dei morti e dei contagi, o sui negazionisti della pandemia, o sulla dicotomia aprire/chiudere, o sui discorsi in tv di Giuseppe Conte?
Alla fine del 2019, che in fondo è appena un anno fa, girava un meme su quanto l’anno fosse stato terribile per il mondo, qualcuno si ricorda perché? Qualcuno si ricorda qualcosa, qualsiasi cosa, del 2019? A inizio febbraio 2020 girava un altro meme sotto forma di bingo con tutte le cose incredibili che erano già successe nel mondo in quei primi 30 giorni. Erano, credo, cinque o sei; io me ne ricordo solo due: la morte del generale iraniano Soleimani e la tensione con gli Stati Uniti (su Twitter era andato in trending topic #WWIII, si parlava davvero del rischio di una terza guerra mondiale); l’invasione delle cavallette che stava devastando l’Africa orientale. In tutto questo il coronavirus era ancora una piccola epidemia confinata a Wuhan, nella Cina centrale, che sembrava non riguardarci ma che presto sarebbe arrivata imponendosi di prepotenza come fenomeno fuori scala rispetto alle nostre normali preoccupazioni.
In quel periodo sono andato all’Università Statale di Milano per sentire una conferenza dello storico Alessandro Barbero. È stata una di quelle situazioni che a ripensarci adesso sembrano provenire da un’altra vita: aula affollata, tutti stretti uno all’altro, nessuna mascherina (di lì a poco ci sarebbe stato il primo caso italiano, Mattia di Codogno, e le prime zone rosse). In quell’occasione, a una domanda sul rapporto delle nuove generazioni con la Storia, Barbero aveva detto che i giovani d’oggi, a differenza di nonni, padri e fratelli maggiori, non avevano mai fatto esperienza diretta di un evento di quelli che cambiano il mondo. I nostri nonni avevano i ricordi della seconda guerra mondiale, i nostri padri ricordavano la paura della Guerra Fredda e il giorno del crollo del muro di Berlino, noi trentenni sappiamo dire con precisione dove eravamo e cosa stavamo facendo l’11 settembre 2001. Un nato sul finire degli anni Novanta, diceva Barbero, non aveva alcun ricordo paragonabile.
Le ultime parole famose. Di lì a poco abbiamo avuto gli episodi di razzismo contro i cinesi “portatori del virus” con la gente – io compreso – che andava a mangiare nei ristoranti cinesi per esprimere solidarietà. Poi il caso di Codogno, Lodi, Vo’ Euganeo e le prime zone rosse, ma ancora non c’era grande preoccupazione al riguardo – ricordo che nel weekend in cui Codogno era il focolaio italiano io sono andato a una conferenza a Firenze con un centinaio di persone ammassate in una sala più piccola di casa mia. Poi le scuole chiuse, tutti a casa in quarantena, le sirene delle ambulanze ovunque, lo stato di emergenza, la gente che cantava sui balconi e se la prendeva coi runner. Quegli stessi ragazzi che secondo Barbero non sapevano che cosa fosse la Storia ne hanno avuta una lezione indimenticabile. Probabilmente rimarranno colpiti a vita: c’è da aspettarsi che i ragazzi che oggi fanno lezione su Zoom diventino magari paranoici sui germi, come le nostre nonne che dopo aver vissuto le privazioni della guerra ne hanno tratto la lezione che bisogna avere sempre uno sgabuzzino pieno di cibo perché non si sa mai.
E questo cambiamento profondo vale anche per le società. Come ha scritto di recente l’economista Branko Milanovic, quando guardiamo a come i Paesi occidentali hanno affrontato l’emergenza vediamo che ogni volta che hanno visto i primi risultati delle soluzioni applicate, hanno perso la pazienza e smesso di applicarle. “L’Occidente si muove senza sosta da una soluzione magica all’altra, sperando di risolvere il problema immediatamente: immunità di gregge per tutti, o una terapia speciale, o il vaccino”, col solo risultato di ritrovarsi otto mesi dopo il primo dilagare della malattia alla stessa distanza dal ritorno alla normalità. Intanto vediamo che altre società, in Asia, a una forma di normalità controllata ci sono già tornate, applicando metodi relativamente semplici – mascherine obbligatorie, tamponi ripetuti, app di tracciamento – con disciplina ferrea.
È possibile che questa grande differenza nasca dallo stesso discorso che faceva Barbero a febbraio, ma applicato alla civiltà occidentale. Distanti tre generazioni dall’ultima situazione di queste proporzioni – intesa non solo come crisi sanitaria, ma nel senso più ampio di momento in cui la stessa tenuta del corpo sociale e le sue necessità di base rischiano di venire messe in discussione – le nostre società di oggi mancano di quelle tracce nascoste lasciate dall’esperienza passata di eventi fuori dall’ordinario capaci di sconvolgere la normalità. Dunque andiamo a tentoni: come civiltà, di fronte a questa crisi, siamo il ragazzino classe 2000 che fa la didattica a distanza con la webcam spenta per farsi i cazzi suoi.
All’inizio della pandemia, l’impressione generale era di ottimismo: sapevamo che sarebbe durata abbastanza a lungo ma non pensavamo – o forse lo sapevamo ma non volevamo ammetterlo – che il coronavirus sarebbe arrivato a compiere gli anni. Molte compagnie aeree prolungavano sì i biglietti dei loro clienti impossibilitati a viaggiare ma li prolungavano magari di sei mesi, come a dire “prendiamo tempo e poi si vedrà”. Il governo italiano, che a marzo-aprile è stato il primo al mondo a imporre un lockdown generale piuttosto duro – anche se non ai livelli cinesi – e prolungato, l’ha fatto probabilmente anche perché convinto del fatto che così facendo si sarebbe risolta la questione una volta per tutte. E invece eccoci di nuovo qui, con un numero di morti al giorno ai livelli del picco della prima ondata, molti più casi e un’epidemia che non è più concentrata in poche regioni. Non perché non siamo stati bravi o perché non l’abbiamo presa seriamente, ma perché abbiamo scambiato per una battaglia campale che si vince o si perde quella che invece si è poi rivelata più simile a una guerra di logoramento.
Un anno dopo, leggere libri come La peste di Camus o le storie della grande epidemia di influenza spagnola di 100 anni fa ci ha ormai rotto. Le espressioni culturali collegate al coronavirus ci hanno ormai rotto. Le videochiamate su Zoom ci hanno rotto, o meglio ci causano un senso di fatica mentale sempre crescente. La corsa contro il tempo per trovare un vaccino, ormai diventato l’unica soluzione per tornare alla normalità, sembra cominciare a dare qualche frutto, anche se è ancora difficile distinguere le vere buone notizie a da quelle che, comunicate tramite comunicato stampa dalle case farmaceutiche, servono più a far salire il titolo in borsa, generare aspettative e ingraziarsi le autorità regolatrici che non a risolvere il problema.
E intanto il coronavirus è ancora tra noi – anzi, giudicandolo con l’unico criterio in cui si possono giudicare i virus, ovvero quello della loro capacità di replicarsi e circolare, non è solo ancora tra noi ma gode di ottima salute. Sarebbe da fargli una torta e dei regali, se le pasticcerie e i negozi non fossero chiusi per evitare il contagio.