L’era d’oro dei gay bar romani, se mai c’è stata, non l’ho vissuta. Viene da dire: che importa, oggi ci sono Grindr e le serate queer aperte a tutti – il Mucca, Latte Fresco, il Giam d’estate all’Eur. E ancora, la gay street col Coming Out e i tavolini sul marciapiede. I gay bar, però, quelli vecchio stile, a porte chiuse – come le saune del resto – ci sono ancora, delizia, rifugio o vergogna, a seconda dell’epoca, della serata, dell’umore di chi le frequenta. Agli etero va spiegato che gli ingressi sono anonimi, scuri; si paga prima di entrare come in discoteca, si scende sempre una rampa di scale. A volte c’è pure una pista da ballo, la musica non manca, ma lo spazio è risicato; lo si risparmia per le dark room, il retro bottega degli incontri – un tempo clandestini, per cui ancora adesso l’ingresso a questi locali è dietro tesseramento. Un corridoio o una rampa di scale porta a dedali di alcove e stanzette dove gli amanti e gli estranei si danno piacere in un erotismo crepuscolare.
A Monti c’è il 101, che è abbastanza nuovo, non fa selezione all’ingresso, è per gay, queer e alleati, ma la dark ce l’ha. Pare un bar da spiaggia piantato sottoterra. L’ultima volta che ci sono stato alla tv del bancone davano repliche di Ru Paul’s Drag Race, mentre i turisti ballavano Lizzo. Il Censured dista un isolato in salita. È più classico. Gli specchi alle pareti sanno di anni Novanta e le stanzette sotterranee paiono cabine di un treno. Mi è capitato che trasmettessero, tra tanti porno, Pretty Woman. Dietro Termini, al Company, si ritrovano gli orsi. Al Black Hole Club di San Giovanni, con due gigantografie di Tom of Finland accanto al bancone, il corridoio è proprio buio, non fosse per le stelle artificiali: quella polare è la prima zip di un jeans che brilla in penombra.
Ne sa qualcosa il giornalista americano Jeremy Atherton Lin, autore di una storia del mondo gay che passa per i suoi locali, di ieri e di oggi, tra Londra, Los Angeles e San Francisco. Dico che ne sa qualcosa perché il suo Gay Bar. Perché uscivamo la notte (minimum fax, trad. Sara Reggiani) si apre con una liberatoria ammucchiata in una dark room londinese qualche anno fa (incipit: “Comincia a esserci puzza di pisello”), prima di esplorare una cultura del clubbing porosa dove politica, sesso e musica diventano indistinguibili. “Grindr ha il suo uso, ma a me le foto del cazzo non interessano proprio – fa spallucce Atherton Lin, ormai over 50, ben portati, seduto in casa editrice a Roma, con un cappello Patagonia in testa che lo scurisce in volto e non si toglie mai, un po’ come il Sylar di Heroes – La gioia sta nella sorpresa, quell’abbassare una zip. La serendipità del bar”.
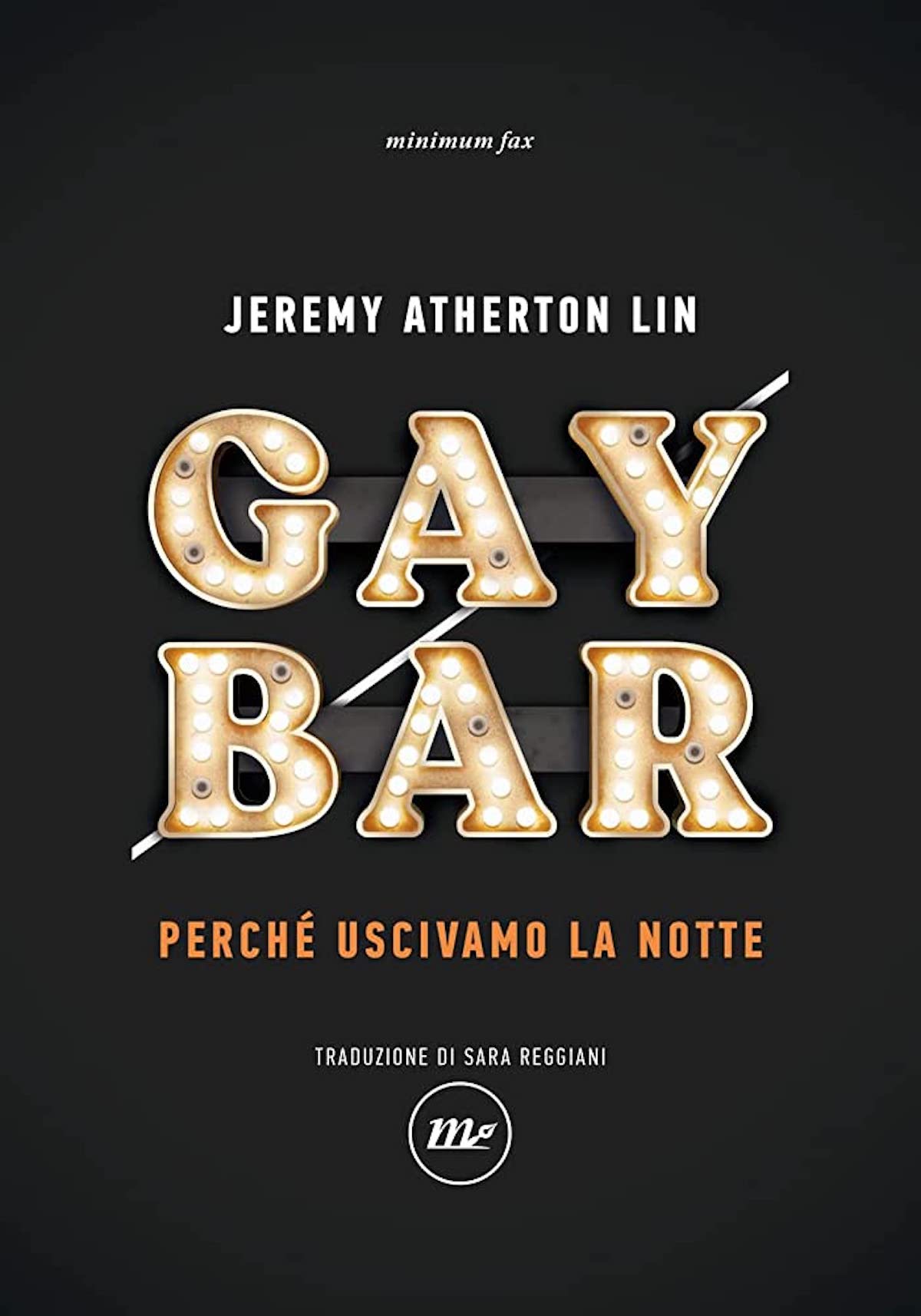
No, non è il solito boomer contro le app, semmai un daddy molto disponibile che più tardi nel libro, parlando di un ragazzetto spigliato (twink) frequentato di recente, scrive divertito: “Questi ragazzi non hanno bisogno della mia saggezza. Di cameratismo, forse”. Che poi non è vero, e infatti in Gay Bar si può fare tesoro della testimonianza di un’invidiabile educazione sentimentale anni Novanta.
Atherton Lin ci racconta del suo arrivo a Los Angeles, West Hollywood, soprannominata Boys Town, appena passato il picco di contagi da Aids, quando sbucano le pubblicità del depilatissimo – ed etero – Marky Mark, icona in boxer Calvin Klein. Poi c’è Londra, dove incontra il suo compagno per la vita, Famous, a una serata gay di brit-pop. Segue il trasferimento a San Francisco, nel cuore queer della città, il quartiere di Castro… e via dicendo. Ogni locale visitato porta con sé dei fantasmi: gli omosessuali invisibili della storia e le tracce dei luoghi clandestini rimossi con la forza, rifugi fin troppo precari e violabili. Così alle prime esperienze di un ragazzo ventunenne che scopre sesso, amore e vita notturna tutte insieme, si alternano le analisi storiche e gli aneddoti più o meno terrificanti. Come il fatto che fino agli anni Novanta i poliziotti britannici più carini servissero da esche in borghese nei bagni pubblici, col manganello dietro le spalle. Esemplare è invece la storia del Twin Peaks di San Francisco, il gay bar che aveva la pretesa di essere “pulito”. Per la prima volta un locale queer sfoggiava ampie vetrate, ma proprio per questo le proprietarie impedivano agli avventori di esprimere affetto, fosse anche un bacio. Non solo per sfuggire alla polizia, ma per dimostrare di poter essere “rispettabili”, come se solo così si potesse dare cittadinanza all’omosessualità. “Quando cedi a queste idee crei una versione lobotomizzata della cultura gay – ribatte Atherton Lin – Io invece volevo che il sesso ci fosse nel libro, c’è dalla prima pagina. È un modo di vivere il mondo. Ci sono la musica, la poesia, la psicanalisi; per me c’è il sesso. Ne scriverei sempre. Creare intimità è un atto politico”.
Non c’è intenzione di romanticizzare il gay bar, né di criticarlo, spiega, solo di parlarne. Di lati oscuri ce n’erano. “Certe persone venivano escluse in base all’età, al colore della pelle, al livello di mascolinità” dice, e già da ragazzo c’era arrivato, che pochi anni prima in certi club di Los Angeles, lui che in parte è asiatico, non sarebbe riuscito a metterci piede. Lo Studio One che frequentava, oggi demolito, un tempo faceva selezione razzializzata all’ingresso. “Non sono certo posti perfetti – continua – Però c’è un aspetto che viene colto da quella canzone di Sylvester, You Make Me Feel Mighty Real, e cioè che sulla pista da ballo, siccome l’identità è sempre relazionale, incontrandoci possiamo sentirci reali. Qualunque cosa tu decida di essere per quella notte, un cowboy o una drag queen, è in questi posti che senti di poter diventare quello che sei grazie al fatto che gli altri ti vedranno e al modo in cui ti vedranno. È una percezione reciproca. Sui social e sulle app proponiamo invece una versione della nostra identità così curata e lusinghiera che alla fine è come se non ci fosse più nient’altro da aggiungere. Perdi la possibilità che qualcuno ti faccia sentire in un certo modo, alla you make me feel this way”.
Certo, lui è stato fortunato. È nei gay bar che ha incontrato il suo compagno, Famous. “Abbiamo da poco celebrato il nostro 27esimo anniversario” racconta. Il loro è stato un amore transoceanico, su e giù tra Londra e San Francisco, finché Famous l’aereo di ritorno non l’ha più preso. Ormai se ne stanno per lo più in Gran Bretagna, ma continuano a vivere ogni avventura insieme. Il prossimo libro, anticipa Atherton Lin, sarà sulla loro storia d’amore e “su come abbiamo costruito un rapporto duraturo quando il matrimonio gay non esisteva, inventando le nostre regole”.
Oggi Atherton Lin esce di meno. “Facciamo vita più casalinga. In pratica, guardare Ru Paul’s Drag Race è il nuovo gay bar. E intanto fai aperitivo”. Il rapporto coi locali resta invece ambiguo: “Ho cercato di raccontare questi sentimenti ambivalenti che avevo da giovane naive, senza edulcorarli”. Il gay bar è delusione e potenzialità, bettola e rifugio, voglia di farsi toccare e disprezzo per gli altri (e quindi per se stessi). Si può compilare un campionario di opposti che appaiono nel libro e ripercorrono alcune fasi, oggi superate, del percorso di liberazione queer: essere “rispettabili” o godersela; apparire o prendere un profilo basso (post-gay si diceva, quasi etero); trasformare i locali gay in monumento, come accade con il centenario Royal Vauxhall Tavern di Londra (apertamente queer e drag dai ’50), o lasciare che mutino e forse si spengano. “Quando ero giovane fantasticavo su come sarebbe stato entrare in un posto liberato, inondato da una luce quasi da spiaggia, e non uno con musica tecno, in penombra e col pavimento appiccicoso” confessa, anche se poi è lì che si apre il libro. “Negli anni Novanta c’era un bar a Londra che era un posto anarchico, che si basava sul rompere le regole e comportarsi in maniera inappropriata. Non dico fosse una buona cosa, ma chi ci andava aveva il diritto di negoziare caso per caso le proprie regole”. Del resto, aggiunge, “il senso di vergogna va e viene”, e il gay bar è sempre in trasformazione. Possono essere dei cessi dove si va per scopare, grandi cabaret, le arcate sul Tamigi, ormai demolite, del settecentesco Adelphi a Londra, o quei locali pieni di bandiere arcobaleno dove tutti possono entrare, magari non sessualizzati, come – aggiungo io – il Coming Out o la libreria transfemminista Tuba a Roma.
“Un ragazzo a Bologna mi ha chiesto se la chiusura dei gay bar non fosse in fondo una buona cosa, visto che sono sempre stati un po’ dei ghetti. Per lui era un segno che vivessimo in una società più equa. Ma va detto che per altre minoranze, come quella trans, avere un proprio spazio sicuro è ancora una necessità. E poi non basta una generazione per dichiarare che si è ottenuta l’uguaglianza. Ci sono così tante leggi regressive sui diritti. Quando parte una canzone come quella di Sylvester o un altro inno gay, può succedere che la gente nella stanza ancora oggi riviva non solo i propri traumi passati, ma quelli dei propri antenati gay. Se questo genere di sopravvivenza culturale, quasi epigenetica, persiste anche quando il rischio di una persecuzione non è così immediato, l’eco di quella storia allora è ancora rilevante”.











