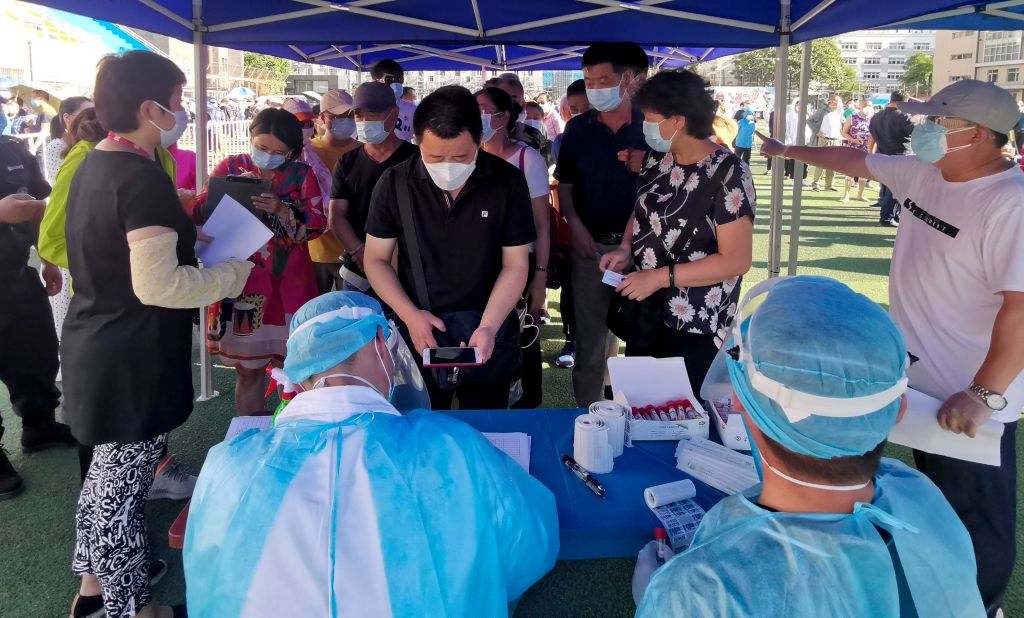Dall’ultima volta che abbiamo scritto dell’argomento, due settimane fa, i medici deceduti per Covid19 sono passati da 24 a 88. Di questi ben 36, più di un terzo, sono medici di base, caduti sul lavoro più dei colleghi di ogni altra categoria e specializzazione. Il motivo, secondo molti, è ancora una volta la mancanza di dispositivi di protezione individuale: mascherine FFP3, guanti, tute protettive, calzari, schermi facciali. Materiale che negli ospedali viene fornito, ma per i presidi di medicina territoriale, ovvero i medici di famiglia, risulta introvabile già da settimane, con grande rischio per la loro salute e quella dei pazienti.
In Lombardia, dove infuria il focolaio principale dell’epidemia in Italia, il problema sembrava non doversi più porre a partire dal 23 marzo scorso, quando la regione con una delibera ha istituito le cosiddette USCA, ovvero le Unità Speciali di Continuità Assistenziale. In sostanza, delle squadre perfettamente attrezzate per l’emergenza che, in presenza di pazienti con sintomi da sospetto Coronavirus, li visitano al posto dei colleghi meno equipaggiati.
“L’idea in linea di principio è buona”, racconta a Rolling Stone Paolo Maggioni, 35 anni, medico di famiglia con uno studio in zona Navigli a Milano. “Il problema è che è ancora tutto molto nebuloso”. La sensazione però, ci spiega, è che siano state istituite soprattutto per concentrare i pochi dispositivi di protezione disponibili, e togliere così dall’impasse tutti quegli operatori della sanità territoriale che non si sentono tranquilli a lavorare senza. Inoltre, ci sono dubbi sull’applicabilità reale di questa nuova delibera. Per fare un esempio, come ci conferma l’ufficio stampa della locale ATS (che, lo ricordiamo, è l’ente che dal 2015 ha sostituito le ASL) nella Città Metropolitana di Milano, che ha una popolazione di oltre tre milioni di persone, sono state attivate otto USCA, di cui solo due in città e sei nell’hinterland. Ognuna di esse si compone di due medici, operativi da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 19.00, e si stima possa fare circa 20 visite al giorno.
“Per dare una misura, una città come Milano ha 1.000 medici di base, e se tutti loro dovessero inviare anche solo una richiesta di visita al giorno – rigorosamente via mail e attendendo risposta, perché la procedura è questa – è facile immaginare che la casella di posta in arrivo rischierebbe di intasarsi nel giro di poche ore”, commenta Maggioni. “Inoltre, ci è stato detto che in caso di pazienti troppo instabili non dobbiamo rivolgerci alle USCA ma chiamare direttamente il 112, e che non dobbiamo rivolgerci a loro neanche per i pazienti troppo stabili, perché quelli possono essere monitorati da noi al telefono”. Insomma, non è chiaro quando siano effettivamente attivabili. Non è escluso che il servizio sia implementato in futuro, ci segnalano dall’ufficio stampa di ATS, ma la situazione attuale è questa. “La maggior parte di noi medici di base, però, ha voglia di aiutare: perché non metterci in condizione di renderci utili, piuttosto?” si chiede Maggioni.
Come si legge nella delibera, a lui e ai suoi colleghi è raccomandato di mantenere “attività di studio esclusivamente su prenotazione e dopo triage telefonico, riducendo orari e solo per pazienti non COVID, non sintomatici, non anziani/fragili”, e di effettuare visite domiciliari “esclusivamente su pazienti senza sintomi febbrili/respiratori, prevalentemente fragili e cronici o verso pazienti non COVID”. Insomma, se uno ha pazienti con sintomi riconducibili al coronavirus, che fa? “Al momento, su 1700 persone che seguo, ne ho circa 60 a casa che sospetto fortemente siano state contagiate”, dice Maggioni. “Con tutto quello che si sente in giro, sono tutte nel panico. Siamo in contatto ogni giorno via telefono, ma non basta a tranquillizzarle: se voglio fare il mio lavoro fino in fondo, devo vederle”.
A livello giuridico è una linea sottile: formalmente non esiste un divieto di visita a domicilio per i medici di base lombardi – che devono continuare a operare “in scienza e coscienza” – ma solo un’indicazione generale che scoraggia a farlo. Maggioni non smette perché ha un rapporto di fiducia con i suoi pazienti, e non vuole abbandonarli. “Oltre ai guanti ho ancora qualche mascherina FFP3, che mi ero procurato in un negozio di edilizia, e qualche presidio arrivato dal Comune di Milano, ma le mie scorte dureranno ancora per circa una settimana”.
Dopo l’istituzione delle USCA, l’ATS ha invitato i medici che volevano continuare l’attività domiciliare a comunicarlo, per poter ricevere i presidi di protezione completi. “L’ho fatto subito, ma dopo più di una settimana non mi è ancora arrivata risposta”. Consapevole che ciò che ha non gli è sufficiente per proteggersi, ha allontanato temporaneamente da casa la compagna e la figlia di cinque mesi, per non rischiare di contagiarle. I tamponi continuano a non essere fatti, né ai pazienti non ospedalizzati, né ai medici di base, nonostante le ripetute assicurazioni da parte delle istituzioni.
Il quartiere in cui lavora il dottor Maggioni, i Navigli, è densamente popolato e gli appartamenti sono piccoli: se uno degli abitanti si ammala, isolarsi è praticamente impossibile. “Questo mese quattro miei pazienti, coinquilini, si sono ammalati a scaglioni: avevano stanze singole, ma condividevano bagno e cucina”, racconta. Il dottor Franco Riili, medico di base 41enne che ha lavorato a lungo nel primo soccorso e oggi ha uno studio in zona Loreto a Milano, chiama questo tipo di situazione “i lazzaretti domestici”: case dove vivono persone che sono molto probabilmente pazienti COVID, ma non hanno mai fatto il tampone e non sono mai state isolate, contagiando così tutta la famiglia. Per fortuna, spiega Riili, la stragrande maggioranza guarisce, magari con l’aiuto di una terapia domiciliare “off-label”, ovvero con la somministrazione di farmaci già in commercio per curare altre malattie – che nella pratica sembrano funzionare bene anche per questa, ma ancora non riportano nel foglietto illustrativo indicazioni per il COVID-19, perché non c’è stato tempo di avviare una sperimentazione mirata su un virus così nuovo.
È il caso del Plaquenil, un vecchissimo farmaco anti-malaria che secondo molti ospedali sarebbe efficace nella fase precoce della malattia, per evitare che il paziente si aggravi. “Per noi è un rischio prescriverlo, perché ce ne prendiamo interamente la responsabilità, ma l’epidemia va combattuta giocando d’anticipo sul territorio, con tutti i mezzi disponibili”, racconta. “Così mi sono lanciato”. All’inizio dell’emergenza, immaginando cosa sarebbe successo, ha comprato su Amazon ed eBay decine di tute, visiere, mascherine. Non si tratta di equipaggiamento per il biocontenimento, come quello che si trova negli ospedali: nella maggior parte dei casi è materiale che si usa per l’edilizia e il bricolage, ma è sempre meglio che niente.
“Se la maggior parte dei malati si concentrano negli ospedali è perché c’è stato un grande fallimento della medicina territoriale, in quanto mancavano i dispositivi di protezione”, spiega il dottor Riili. Avendo fatto cambusa quando ancora si trovavano, anche lui fa ancora visite: fa un primo screening tramite videochiamata, e per i pazienti fragili (gli anziani o quelli con patologie croniche, ad esempio) ha istituito un protocollo apposta. “La procedura è molto lunga, e i due terzi del tempo li impiego a vestirmi e svestirmi”, racconta. “Arrivo sul pianerottolo del malato, indosso i dispositivi di protezione completi, lo invito a spalancare tutte le finestre e le porte di casa e a indossare una mascherina chirurgica e poi disinfetto le superfici su cui appoggerò le mie apparecchiature”.
Riili viaggia con un ecografo portatile di sua proprietà, abbastanza piccolo da stare in uno zaino: è perfetto per diagnosticare le polmoniti da COVID anche in mancanza di tamponi o lastre. In caso di necessità prescrive una terapia off-label a base di Plaquenil, antibiotici ed eparina. “È chiaro che se un paziente COVID viene ricoverato in ospedale dopo due settimane di febbre alta e fiato corto, senza essere mai stato visitato o curato, la funzionalità dei polmoni sarà già abbastanza compromessa”, osserva. Anche questo potrebbe essere uno dei motivi per cui la mortalità dalle nostre parti è così alta. Purtroppo, però, gli ecografi portatili in dotazione ai medici di base sono rari, molto costosi e non tutti sono capaci di usarli: per utilizzarli su larga scala ci vorrebbe un coordinamento dall’alto, in cui però il dottor Riili non spera più. “Questa epidemia è molto simile a quella della Spagnola, all’inizio del ventesimo secolo, e anche i governanti e la popolazione stanno replicando molti schemi che si erano già visti allora”, conclude. Nel suo piccolo, per diffondere buone pratiche e smentire fake news utilizza la sua pagina Facebook, in cui dialoga con i pazienti dando suggerimenti utili per la gestione dell’emergenza.
I social stanno giocando una parte fondamentale, per chi lavora sul territorio. Molti medici e operatori sanitari di base, infatti, non ricevendo linee guida chiare, si confrontano tra di loro sulle prassi da adottare nelle chat di gruppo su WhatsApp, in gruppi Facebook aperti solo ai professionisti, o facendo rete con chi ha gli stessi problemi. Come il MOOSS, un gruppo di medici, odontoiatri e operatori socio-sanitari nato in Lombardia per agevolare in tutti i modi possibili chi combatte contro il virus ed elaborare strategie da applicare.
L’intuizione arriva da Tommaso Mascarello, 36 anni, odontoiatra di Saronno. Allo scoppio dell’emergenza, facendo chirurgia del cavo orale (in cui è necessario proteggersi dalla saliva e dai batteri più che in molti altri ambiti della medicina ambulatoriale), aveva già una notevole fornitura di schermi facciali, occhiali, mascherine e camici monouso. “Avevo iniziato a fare magazzino già all’inizio dell’inverno, non volevo trovarmi sguarnito se fosse scoppiata una pandemia. Era un gesto quasi egoistico: temevo che, se la richiesta di mascherine si fosse impennata, non ne avrei avute abbastanza per lavorare”, racconta a Rolling Stone. Quando ha saputo che i medici di base della sua zona erano privi di dispositivi di protezione, ha messo a disposizione le sue scorte personali. “Si sono presentati alla mia porta venti medici di famiglia e hanno fatto razzia, tipo le locuste”, scherza. “Da lì ho capito la gravità della situazione e insieme a un gruppo di amici abbiamo creato il MOOSS, per metterli in contatto con quei professionisti (dentisti, veterinari, operatori sanitari) che avevano materiale da dare ai medici che ne avevano bisogno”.
Il progetto si è allargato a macchia d’olio nel giro di breve, e oggi il MOOSS è operativo in buona parte del nord Italia. Ha anche ampliato i suoi obbiettivi, perché è subito stato chiaro che la carenza di mascherine era la punta dell’iceberg. “Fare formazione era indispensabile, perché molti di questi dispositivi sono complicati da mettere e togliere correttamente. Anche se sei equipaggiato di tutto punto, se li usi nel modo sbagliato rischi di moltiplicare il rischio di infettarti. Tant’è che di solito si usano in coppia, con un collega che controlla che tu li abbia indossati e utilizzati nella maniera giusta”, spiega Mascarello.
Negli ospedali, soprattutto nei reparti di malattie infettive, per utilizzarli ci sono esercitazioni e certificazioni apposta, così il MOOSS ha pensato organizzare un corso con un istruttore abilitato, rivolto appunto ai medici di base. Quando ha inoltrato ufficialmente la domanda al prefetto, però, ha ricevuto un responso negativo, perché nonostante fosse nell’interesse della salute pubblica si trattava pur sempre di un assembramento di persone, al momento vietato per decreto legge. “È paradossale che iniziative di questo tipo vengano bloccate. Anche per questo, il fatto che siamo una rete informale è un vantaggio: in questo modo possiamo muoverci tra le maglie della burocrazia, agendo con una rapidità e un’agilità che le istituzioni non potrebbero avere”, commenta.
Oggi il MOOSS mette in contatto medici di base di tutto il territorio, insegna procedure di sanificazione dei dispositivi, crea gruppi d’acquisto dall’estero per procurarne di nuovi ed elabora strategie per prevenire i vari scenari possibili, tra cui il cosiddetto Progetto Monatti, in cui prendendo ispirazione dai Promessi Sposi si auspica che a lavorare con i pazienti COVID siano medici che hanno già gli anticorpi per la malattia. “Quando dicono che quella contro il COVID è una guerra, significa anche che è soprattutto chi è sul campo ad avere la percezione reale di ciò che succede”, aggiunge. “Siamo noi che dobbiamo agire, anche prendendoci dei rischi”.
Il 7 aprile l’Ordine dei Medici della Lombardia ha firmato una lettera aperta indirizzata ai vertici della sanità regionale in cui sottolinea come nel corso dell’emergenza “sia risultata evidente l’assenza di strategie relative alla gestione del territorio” – denunciando anche la mancanza di tamponi e dispositivi di protezione personale per i medici di base. La “situazione disastrosa in cui si è venuta a trovare la nostra Regione”, si legge nella lettera, dipende anche dal fatto che quella attuale sia stata trattata come un’emergenza da gestire solo nei reparti di terapia intensiva. Su un punto, insomma, la percezione sembra unanime: il modello della sanità lombarda, che tende a concentrare il grosso delle risorse sugli ospedali lasciando sguarnito ogni altro presidio (ivi compresi i luoghi in cui isolare i malati ancora contagiosi che non vivono soli) in questo momento non si sta rivelando vincente. Forse siamo ancora in tempo per correggere parzialmente la rotta: il capitale umano e la voglia per farlo ci sono, è evidente.