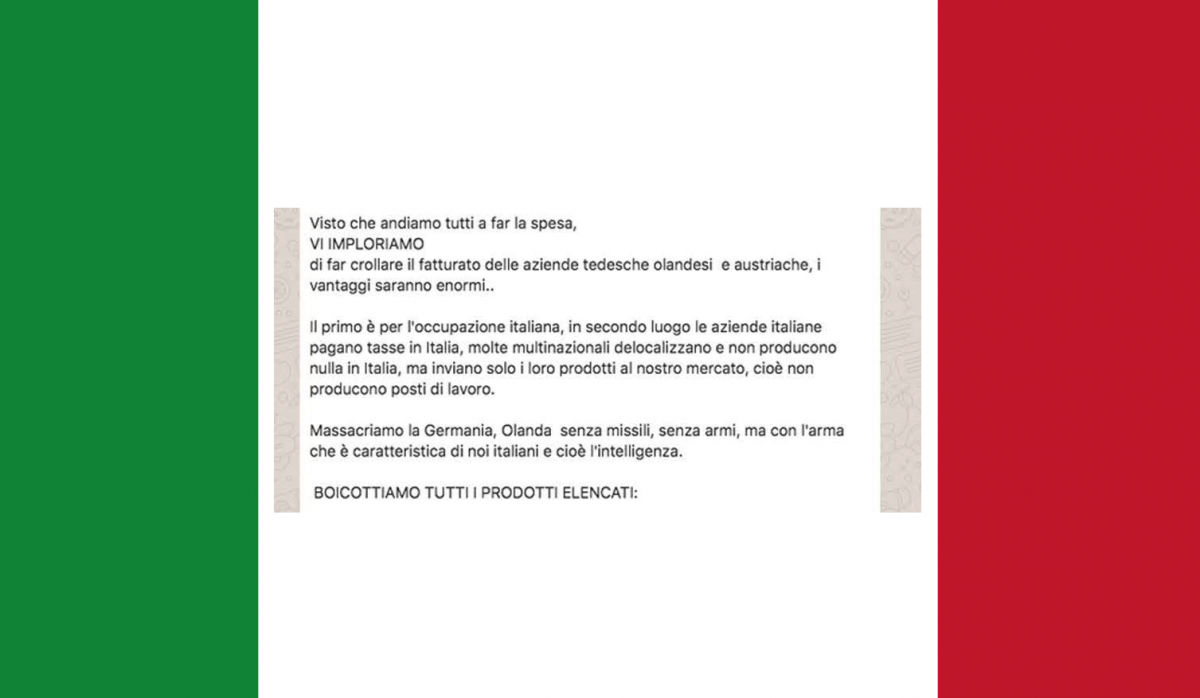Ho un caro amico che su WhatsApp ne abusa, con mio sommo disappunto.
«Allora confermato domani sera?»
«Sì, va bene.»
«Hai iniziato a guardare Loot?»
«No, non ancora.»
«L’altro giorno sono andata a mangiare la pizza da Oceania, buonissima»
«Te l’avevo detto, anche io adoro quel posto.»
Punto, punto, sempre punto. Alla fine, raggiunto il massimo apice del fastidio, gliel’ho chiesto: «Senti, ma perché concludi tutti i messaggi con un punto? È strano, lo sai? A metà tra il perentorio e l’arrogante». Lui, come d’altronde nel suo stile, m’ha risposto laconico: «Perché è grammaticalmente corretto.». Punto, ovviamente. C’è da dire che, quando si tratta di una persona con la quale si è in confidenza, quest’abitudine molestissima riesce a essere ridimensionata e pure perculata, ma se il punto infame viene utilizzato da qualcuno che non si conosce poi così tanto bene, è capace di gettare la controparte nello sconforto più totale. Perché l’ha messo? Cosa desidera farmi intendere? Gli (o le) starò forse antipatica? Dovrei cogliere un sottotesto che mi sfugge?
Max Harrison-Caldwell sul New York Times ne fa una questione in un certo senso generazionale, sostenendo che il punto è largamente usato dai boomer, che in questo modo mettono a disagio i più giovani. Il mio amico di cui sopra però ha trent’anni, e credo troverebbe tale distinzione vagamente offensiva. John McWorther, autore del podcast Lexicon Valley, azzarda un parallelismo interessante: così come i discorsi preparati sono analoghi alla scrittura formale, allo stesso modo il parlato informale equivale all’invio di messaggi. I linguisti Naomi Baron e Rich Ling hanno concluso in uno studio del 2007 che «l’atto di inviare un messaggio coincide con la punteggiatura finale della frase»; l’uso del cosiddetto text speak è stato inoltre analizzato come una forma di cambio di codice situazionale. In altre parole, non ricorrere ai punti è un modo per il mittente di indicare che si sente a proprio agio con il destinatario.
Gretchen McCulloch, linguista canadese e autrice di Because Internet, ha dedicato un intero capitolo del suo libro al “tono di voce tipografico”, che esplora non solo punti e puntini di sospensione come significanti del tono, ma anche DIGITARE TUTTO IN MAIUSCOLO (che equivale a urlare), servirsi di *asterischi* (per enfatizzare), nonché il privilegiare la «tipografia minimalista» tutta minuscola, che può indicare una sorta di monotòno impassibile e sarcastico. Il mio – anzi, il nostro – vivere i punti alla fine dei messaggi come tonalmente significativi deriva dalla loro totale inutilità: è chiaro che un messaggio è terminato indipendentemente dalla punteggiatura, poiché ogni messaggio nasce e muore nella sua bolla.
La questione si fa spinosa quando su WhatsApp compare il famigerato «Sta scrivendo», che per i messaggi “normali” sono i tre puntini di sospensione lampeggianti: in entrambi i casi, spesso sul destinatario piomba un carico da novanta di attesa e frustrazione, dato che – come nel parlato – c’è un ritmo che entrambe le parti coinvolte nella conversazione hanno la responsabilità di mantenere. Per evitare dunque di tenere il proprio interlocutore con il fiato sospeso, lo scrivente invia frasi singole e senza punteggiatura al posto di frasi complete. Per McCulloch, adattarsi a questa nuova forma di comunicazione può risultare difficile per le vecchie generazioni, convinte che «le regole imparate a scuola siano fisse e immutabili, e che tutto ciò che segue sia una barbarie. Le mode però cambiano, le parole cambiano e pure la punteggiatura può essere diversa».
E se il punto alla fine del messaggi è indicatore di un’eccessiva serietà e autorevolezza, altre forme di scrittura stanno cominciando a utilizzarlo come tale: determinati post sui social acquisiscono di colpo un tono completamente differente, e lo stesso avviene per alcuni titoli di giornale. Sebbene ogni generazione voglia erigersi ad arbitro di stile, le nuove convenzioni che circondano il punto sono soltanto l’ultimo episodio di una storia secolare di esplorazione grammaticale.
Al di fuori della comunicazione privata, romanzieri e poeti hanno esplorato per decenni la cosiddetta punteggiatura non-standard: da E.E. Cummings a Tom Wolfe, passando per James Joyce, Alberto Arbasino e Raymond Carver, parecchi scrittori si sono votati alla sperimentazione con un linguaggio esplicitamente artistico – a differenza della maggior parte dei messaggi di testo. Ma l’uso (o l’omissione) “senza regole” della punteggiatura da parte di questi autori dimostra che si è saputo guardare oltre le norme grammaticali con uno scopo ben preciso: rappresentare per iscritto pensieri, discorsi o sentimenti. Morale della favola: le leggi che dettano la punteggiatura non sono state affatto conservate senza vita come insetti imprigionati nell’ambra, anzi.
Ben Zimmer, lessicografo ed editorialista del Wall Street Journal, sostiene che l’utilizzo del punto si è irrimediabilmente evoluto, e tale evoluzione è destinata a diffondersi da un mezzo all’altro: «Sono ancora relativamente conservatore quando si tratta di rinunciare ai punti, ma mi sono reso conto che lo sto facendo sempre di più, il che suggerisce che sta diventando un’aspettativa, una convenzione o una norma a cui le persone si stanno adattando, incluse quelle più anziane come me».
Da maniaca della punteggiatura quale sono, posso confermare che nulla è più insopportabile di un eccesso della stessa: ficcarla ingiustificatamente in ogni dove è visivamente disturbante e vanifica il piacere della lettura; o, per dirla in modo più poetico rubando le parole a Theodor Adorno, «in ogni segno di punteggiatura evitato premurosamente, la scrittura rende omaggio al suono che sopprime». Caro amico mio che finisci tutti i messaggi che scrivi su WhatsApp con un punto, sono riuscita a convincerti che si tratta di un’abitudine al limite dell’intollerabile?