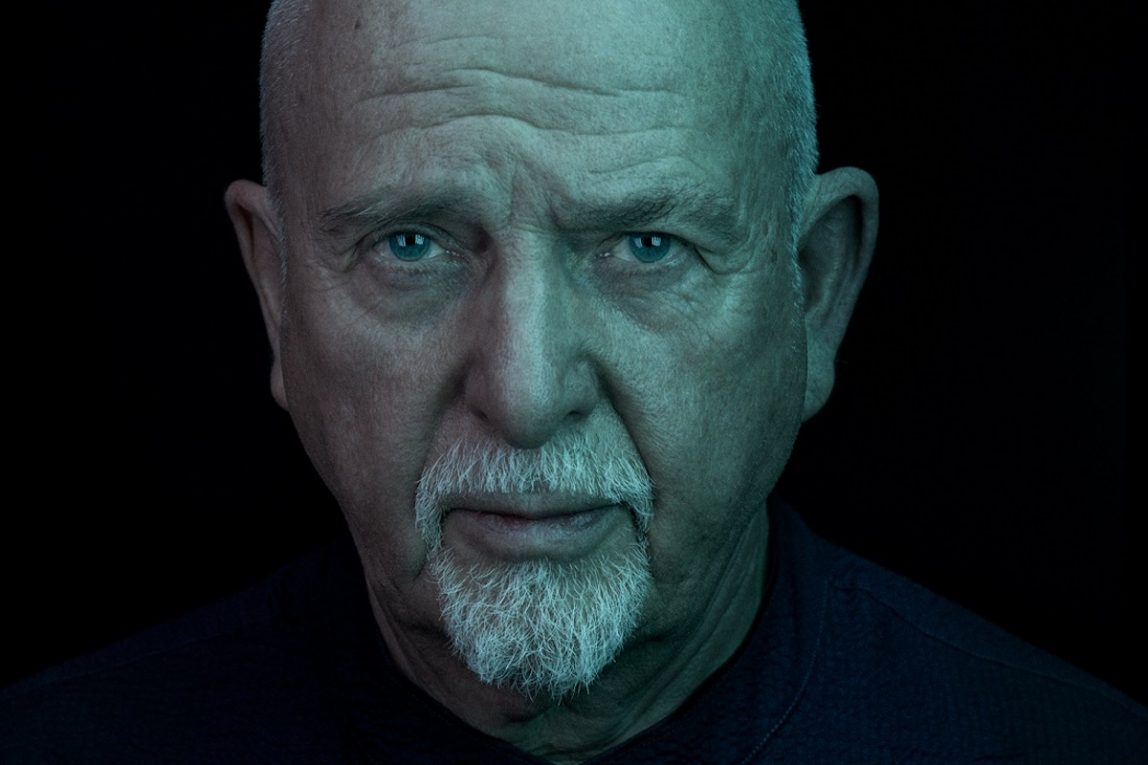Guardatevi da chi annuncerà questo disco usando parole come avant-jazz, sperimentazione, dissonanza. Nonostante i musicisti coi quali ha lavorato provengano dal jazz contemporaneo, poco scolastico ma in odore di fusion (il sassofonista Donny McCaslin, il chitarrista Ben Monder e altri), il nuovo David Bowie non ha niente del folle avventurismo del suo lontano maestro Scott Walker – che negli ultimi anni pare sempre più un Alban Berg metallaro. Assomiglia soltanto a se stesso (e ci mancherebbe): alla sua segreta storia mod, al citazionismo spinto della sua estetica, alle convenzioni camp del musical, che coltiva e pratica da 40 anni.
Né l’ingresso recente di Bowie nel novero degli artisti sottratti alla routine del rock ed entrati nelle gallerie d’arte e nei musei, ci farà dimenticare che la Trilogia Berlinese NON era una pala d’altare espressionista, ma tre dischi di vinile suonati per anni fin nella più sperduta delle stanzette di provincia, e da qui entrati nel Dna di più d’una generazione di musicisti e ascoltatori. Oggi, con il suo produttore di sempre Tony Visconti, Bowie spiega che, in sostituzione del ritmo motorik della Trilogia, l’ispirazione gli viene dai beats del rapper Kendrick Lamar e dalla collaborazione con il dj James Murphy, coinvolto però in questo lavoro molto meno di quanto annunciato.
Uhm. Si può storcere il naso, non è blasfemo. D’altra parte l’uso insistito del sax (così desueto oggi in questa forma) in tutto l’album meriterebbe già un saggetto per conto suo. Da allievo del sassofonista inglese cool Ronnie Ross (che chiamò anni dopo a fare l’assolo di Walk on the Wild Side), Bowie scelse il sassofonista fusion David Sanborn per l’assolo di Young Americans. Oggi chiede a McCaslin di far strillare lo strumento in libertà su tutta Tis A Pity She Was a Whore, che è una roba da teatro contemporaneo – unendo assieme un testo sull’incesto di un commediografo del ’600 e l’anniversario della Prima Guerra Mondiale.
Anche in Lazarus strilla un sassofono, ed è come se fossimo a teatro. Lo siamo. Una delle canzoni inedite del musical off-Broadway che immagina un seguito a L’Uomo che cadde sulla terra. Michael C. Hall (Dexter) fa la parte dell’alieno e il testo lamenta l’essere intrappolato in un corpo umano da cui finalmente sta per liberarsi. Di nuovo, una struggente metafora della condizione nella quale Bowie adora crogiolarsi: quella di sopravvissuto alla rovine di un mondo intero, e rovina egli stesso (come tutto il mondo). Par di leggere tra le righe della critica americana che il musical sia una solenne puttanata rispetto al fascino dell’originale film di Nic Roeg. Amen.
Per chiudere con l’avant-jazz, ecco il trattamento riservato a Sue (Or In A Season Of Crime), che in origine era una murder ballad in stile Kurt Weill, cantata con la big band di Maria Schneider: via i fiati, dentro un intreccio di chitarre sopra un ostinato ritmico, come ai tempi di Heroes. Ma senza Fripp né Eno, bisognerà pur dirlo. Si ritrovano altre ombre della passata magnificenza berlinese in Girl Loves Me, che ha un suono molto tribale, anni ’80. E in I Can’t Give Everything, una ballad con pianoforte, armonica, e sassofono, si torna ancora più indietro, nel tentativo di scalare il giro discendente di accordi jazzy di Life on Mars.
Essere un alieno intrappolato nel corpo di una rockstar che si chiama David Bowie è dura, a quasi 70 anni compiuti. Ma lo scherzetto migliore all’alieno lo ha fatto proprio McCaslin (col quale c’è da intuire un rapporto da alter ego, tra sassofonisti), giurando di aver sentito dire dal suo autore che la lunga e ambiziosa title-track Blackstar sia un pezzo sull’Isis. Circostanza smentitissima: Blackstar sarà la sigla di una serie tv sul crimine nell’Est Europa. Però quel “giorno dell’esecuzione” di cui parla il testo, coi tempi che corrono, sopravanzerebbe di molto in fascino la paccottiglia thriller-demoniaca del lungo videoclip girato dal regista Johan Renck, con Bowie protagonista, bendato come un prigioniero.