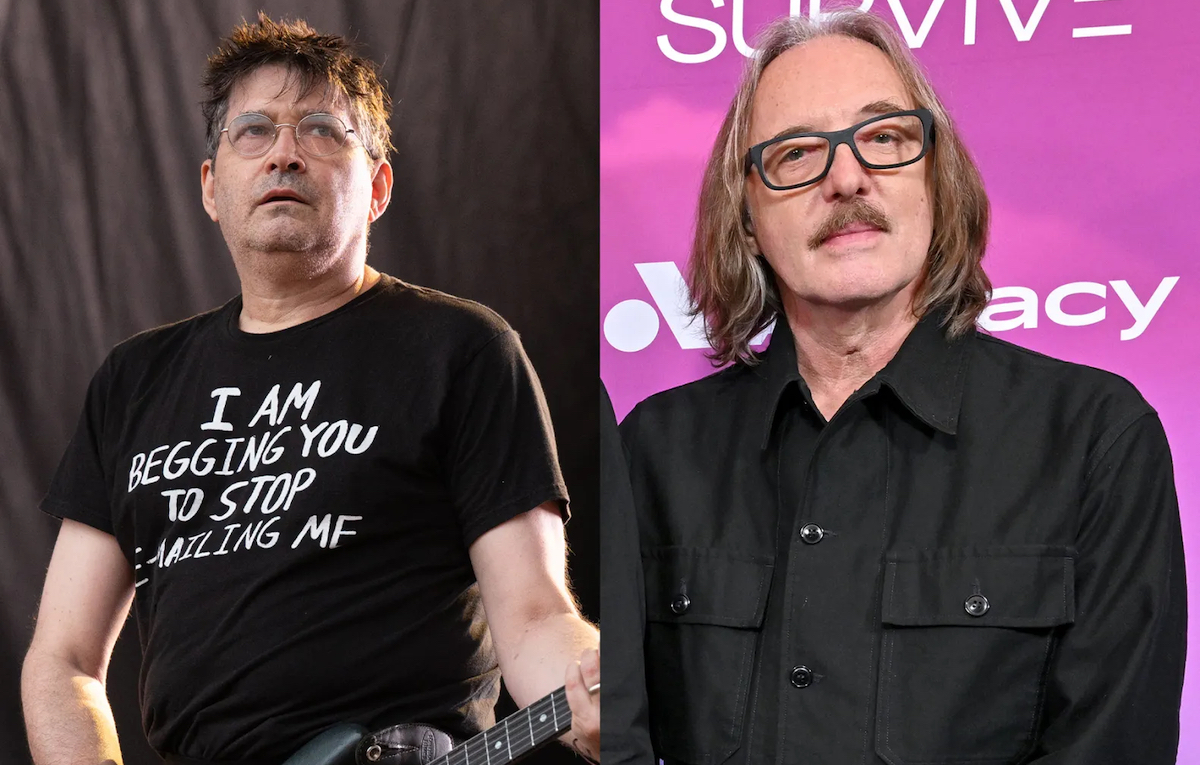Nella primavera del 1992 un uragano proveniente dal Dorset, sudovest dell’Inghilterra, si abbatté sul rock di quel periodo con una forza che poteva essere paragonata solo a quella di certe tempeste britanniche di una quindicina di anni prima (leggasi punk ma anche, più appropriatamente, Kate Bush). Fu evidente a chiunque che l’esordio della allora ventiduenne Polly Jean Harvey era di quelli importanti, ouverture di una storia che non era difficile immaginare lunga, complessa, artisticamente felice e narrativamente articolata come in effetti sarebbe stata. Nelle primissime copie di Dry, album che la sua autrice era convinta in quel momento sarebbe stato il primo e ultimo della carriera, erano presenti anche le versioni demo dei brani in scaletta, poi eliminate nelle tirature successive.
Quelle versioni unpolished riappaiono oggi, a quasi trent’anni di distanza, anche in edizione separata rispetto al disco che inaugura il programma di ristampa su vinile dell’intero catalogo dell’artista. Operazione meritoria, come può certamente confermare chiunque abbia dato un’occhiata alle valutazioni di molti 33 giri originali (la terminologia anni ’90 è d’obbligo) della musicista inglese. Ma il punto non è quello biecamente collezionistico o completistico. La domanda da farsi, una volta ascoltati (o ri-ascoltati) gli 11 demo di Dry, è: cosa ci dicono dell’artista di diverso da ciò che abbiamo storicizzato e che oggi diamo per assodato sulla giovane PJ Harvey? Oppure: possono essere considerati uno squarcio su una ipotetica storia alternativa?
In genere, quando si analizzano quelle cose che servono spesso a fare buon peso nelle cosiddette ristampe deluxe (versioni differenti, prove in studio, inediti lasciati a languire per decenni come fondi di magazzino e, appunto, demo) si ricorre a una terminologia standard e criticamente si entra in modalità pilota automatico. Un demo per definizione è “crudo”, “spoglio”, “non sviluppato”, “spontaneo”, in molti casi addirittura più “autentico” della versione finita perché più vicino alla sensibilità e alle idee di partenza degli artisti prima che le etichette e i produttori ci mettessero le mani sopra. O almeno ci piace pensare così. Nella storia della musica pop ci sono molti esempi di questo tipo, ma per quanto riguarda Dry possiamo escluderlo (per gli altri dischi di PJ vedremo, qualche sorpresa potrebbe esserci soprattutto su quelli meno celebrati). Benché giovanissima, Polly Jean era sufficientemente determinata per imporre la propria visione, oltretutto a una etichetta discografica e a due co-produttori (Head e Rob Ellis) che la sostenevano al 100%. Se si annunciò al mondo in quella maniera, c’era evidentemente una ragione. Il che non significa che i demo in questione (contrariamente a troppi casi analoghi) non siano interessanti e non rappresentino una magnifica esperienza d’ascolto.

Le canzoni, anche in formato voce e chitarra (ma che voce, e che chitarra), sono perfettamente strutturate, suonano in modo scintillante, reggono benissimo e concettualmente non si discostano troppo dalle versioni conosciute. Emerge qui e là, per forza di cose, una più pronunciata vena folk-blues, come in Dress o nell’eccellente Happy and Bleeding. Ma in pezzi come Sheela-Na-Gig, Joe o Victory la differenza è solo di grado, non di struttura. Nel senso che i brani finiti poi sul disco suonano inevitabilmente più “spessi”, con chitarre e ritmica che aggiungono muscoli a uno scheletro già di ottimo livello musicale. I tempi, del resto, richiedevano quel trattamento.
Interessante tuttavia notare un paradosso di fondo: se quelle 11 tracce, così com’erano nelle versioni primigenie, probabilmente non avevano, in pieno fallout grunge, sufficiente potenza per bucare l’immaginario del pubblico indie rock di allora, riascoltate oggi suonano stranamente contemporanee. Da un lato sembrano più affini al cantautorato essenziale e un po’ dark, soprattutto femminile, che è andato codificandosi negli ultimi anni; dall’altro, adombrano soprattutto a livello vocale una PJ Harvey più matura e intensa. In questo senso, costituiscono nel loro insieme una sorta di teaser che forse sì, ci dice qualcosa di rilevante. Ad esempio, che nella PJ degli albori erano già presenti in nuce diverse caratteristiche che avremmo ritrovato nella PJ non solo di To Bring You My Love o Stories From The Cities, Stories From The Sea, ma addirittura dei suoi ultimi dischi.
E quindi ben vengano, questi demo. Non riscrivono certo la storia, ma in tempi in cui la sacralità dell’opera d’arte finita una volta per tutte è messa in discussione, in cui gli “album” si connotano più come processi in divenire che come risultati scolpiti nella roccia, rappresentano un modo stimolante di guardare al passato di una grande artista. Senza cambiarlo di segno, semmai aggiungendovi un’angolazione differente, una dimensione ulteriore.