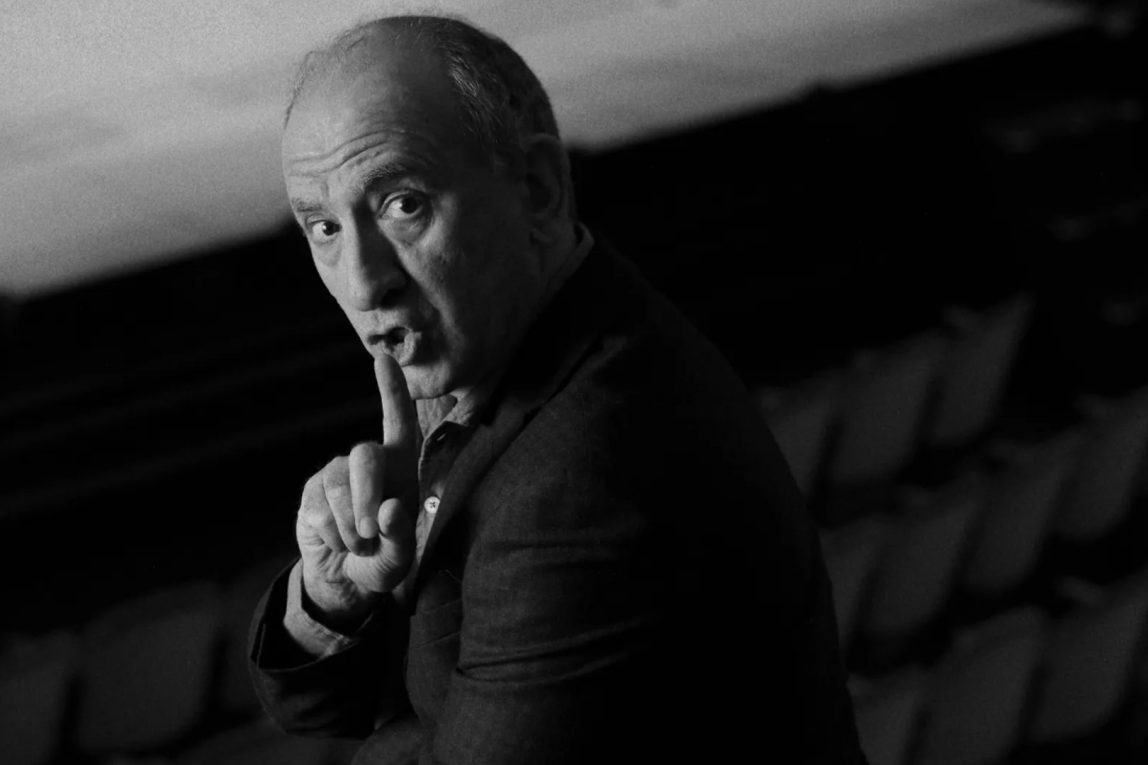Solo pochi giorni fa Gerusalemme era al centro di un piccolo caso diplomatico tra Italia e Israele, dopo che Rcs Sport, organizzatrice del Giro d’Italia, aveva annunciato la partenza della rassegna ciclista, al via il prossimo 4 maggio, da “Gerusalemme Ovest”. “Gerusalemme è una città unita. Certe definizioni sono una infrazione delle intese col governo israeliano. Se ciò non sarà cambiato Israele non parteciperà all’evento”, avevano detto in una nota congiunta due ministri israeliani, costringendo alla retromarcia immediata Rcs e a buttare al macero tutte le pubblicazioni con la precedente dicitura.
Se mai ce ne fosse stato bisogno, la reazione dell’esecutivo israeliano a quella che da Milano è stata descritta semplicemente come “un’espressione tecnica e priva di alcuna valenza politica, imputabile al fatto che la corsa si svilupperà logisticamente in quell’area della città”, beccandosi di tutta risposta l’accusa di “essere complici dell’occupazione israeliana” da parte dell’Olp, lascia intravedere quanto sia grande e agitato il nido di vespe in cui Donald Trump ha infilato tutte quante le sue dita.
Il presidente americano ha fatto sapere che nelle prossime ore avvierà la procedura per spostare l’ambasciata degli Stati Uniti da Tel Aviv a Gerusalemme. Potrebbero volerci altri sei mesi, ma la decisione da un punto di vista politico è presa. E ha suscitato reazioni in tutto il mondo, come è inevitabile che fosse: dalla collera dei palestinesi, che hanno annunciato tre giorni di manifestazioni fino a venerdì, al crollo dei mercati, fino ai tentativi di mediazione dei leader internazionali e all’appello del papa per il mantenimento dello status quo. Perché quello raggiunto negli anni a Gerusalemme è un equilibrio straordinariamente precario, e ogni fatto che avviene dentro le mura della città, o attorno a esse, rischia di comportare un’eresia per l’una o per l’altra parte in causa, e di avere conseguenze che è persino difficile prevedere.
Gerusalemme è una delle città più contese del pianeta, dall’insediamento nel 3000 avanti Cristo a oggi, passando per le epoche assire e babilonesi, per Ciro, Alessandro Magno e i romani, per le crociate e Saladino, il lungo regno ottomano e gli anni della corona britannica. Fino al dopoguerra e alla nascita dello Stato di Israele. La città è di fatto divisa in due dal 1949, dal primo conflitto tra arabi e israeliani e l’armistizio che ne seguì. Allora fu stabilita una Green Line per separare la parte ovest, israeliana, ricca e residenziale, da quella orientale, allora sotto il controllo della Giordania.

La situazione, per gli Stati confinanti frutto di una invasione israeliana di quelle terre, rimase congelata fino al 1967 e alla guerra dei Sei Giorni, con cui Israele annetteva dallo Stato di Palestina, sorto tra mille difficoltà, anche la parte est. Nemmeno gli Accordi di Oslo, firmati nel 1993 con grandi aspettative, hanno risolto la questione. A ciò si aggiunge il tema delle colonie, insediamenti fuori da ogni accordo internazionale, con cui Israele ha espanso nel tempo il proprio territorio e in cui vivono centinaia di migliaia di persone. Una politica che ora Trump sta sdoganando in maniera più palese che mai.
Gerusalemme Est, in cui si trova la città vecchia con i monumenti e i luoghi di culto e che è abitata in maggioranza da arabi (senza cittadinanza), è una zona militarizzata. La sua valenza simbolica è incalcolabile, per tutti. Qui c’è la Spianata delle Moschee con al Aqsa, eretta nel luogo secondo cui i fedeli musulmani Maometto salì al cielo, al posto del Tempio di Salomone, luogo sacro dell’ebraismo, come il Muro del Pianto, oppure la cristiana Basilica del Santo Sepolcro. Non a caso tra queste vie si sono verificati negli ultimi anni molti degli scontri e degli atti di terrorismo più efferati, e qui i capi di Stato ambientano le loro frequenti visite in una delle aree più turbolente del pianeta.
Lo status di Gerusalemme è un capitolo tutt’altro che irrilevante in un conflitto che, da decenni, divide il mondo in due, e che alimenta a sua volta tensioni in altre regioni, e fa da combustibile a molti fenomeni di terrorismo, come testimoniano di volta in volta parole o scritti attribuiti ad attentatori o aspiranti tali.
La “città eterna” è, di fatto, considerata la capitale sia dagli israeliani che dai palestinesi. Questi ultimi lo rivendicano sin dal principio, e lo stesso fa Israele, che, pur avendo proclamato nel 1980 per via parlamentare, “l’indivisibilità di Gerusalemme capitale”, ha dovuto fronteggiare più di una risoluzione internazionale secondo cui a Gerusalemme è in corso una “occupazione di territori”.
Rimane una “capitale contestata”, e, seppure la maggior parte degli organi legislativi e di governo israeliani, come il parlamento, la Knesset, si trovino qui, tutti i Paesi stranieri hanno deciso negli anni passati di portare le proprie rappresentanze a Tel Aviv, città israeliana ben più “pacificata” lungo il Mediterraneo. Fino all’annuncio di Trump, che rischia di dare fuoco alle polveri in una fase, tanto per cambiare, molto delicata, in cui, dopo anni di veleni, è in corso un riavvicinamento sul fronte palestinese tra Hamas e Fatah, per avviare una gestione unitaria dei territori e un processo di riconciliazione nazionale.

A complicare il quadro, la continua danza delle alleanze tra i Paesi arabi della regione, con il tentativo americano, a fidarsi dei commentatori, di isolare ancora di più l’Iran sciita e esasperarne la distanza dall’Arabia Saudita, sempre più vicina a Israele negli ultimi periodi. In più c’è la Russia, che tanti problemi sta dando a Trump sul fronte delle inchieste giudiziarie, il cui protagonismo in Medio Oriente, dalla guerra in Siria in poi, ha indispettito Washington.
Ma in quello spicchio di mondo, la storia lo insegna, a ogni miccia può corrispondere un rogo. E negli ultimi anni le ambasciate hanno più volte catalizzato la rabbia e la violenza, dalla crisi iraniana raccontata nel film Argo fino alle fiamme e agli assalti alla sede saudita a Teheran due anni fa dopo l’omicidio dello sceicco al-Nimr. Cosa accadrà nei prossimi giorni e mesi è impossibile da dire. Come già avvenuto nel caso della crisi con la Nord Corea, non lascia del tutto sereni il pensiero che nella stanza dei bottoni ci sia uno come Donald Trump. La speranza è che, se alla fine vorrà schiacciare proprio quello rosso, sia sempre e solo per ordinare una coca.